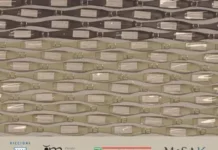Così ragionavano i “Padri della Patria” mentre calavano, non invitati, nella penisola. Come il Re Galantuomo lamentava (in francese) l’uso italico del baciamano.
“Che fortuna, caro Massari, aver fatto l’Italia prima di averla vista!”, aveva sospirato il Cavour al futuro storiografo del Risorgimento. E sì che il Cavour, questa Italia indegna delle attenzioni del Piemonte, l’aveva vista soltanto fino a Firenze. Ma gli era bastato. A Firenze aveva fatto dietro-front e se ne era tornato a Torino, nella civiltà. Chi invece – per dovere d’ufficio, amor patrio e per imperscrutabile disegno della Provvidenza – fu costretto a procedere oltre lasciò via via impressioni ancor più scoraggianti. “Altro che Italia! Questa è Africa. I Beduini, a riscontro di questi cafoni, sono fior di virtù civile”, scrive Farini, il luogotenente del regno. E Massimo d’Azeglio, rincarando la dose, precisa immaginosamente: “La fusione con i Napoletani mi fa paura come mettermi a letto con un vaioloso”. “Che dissoluzione – scrìve il La Farina dalla Sicilia – il ’48 era la repubblica di Platone in confronto del ’60.” Con i nuovi-fratelli-finalmente-liberati, i fratelli liberatori adottano metodi drastici e spicci. “Non era possibile governare – ricorda placido il Della Rocca nelle sue Memorie – se non incutendo terrore. Mi telegrafavano in questa forma: ‘Arrestati nel luogo tale, quattro o cinque briganti!’ E io rispondevo: fucilate.” E Gaetano Negri, di rincalzo: “Qui, in questa guerra bassa e atroce, si procede per imboscate, per intrighi e tradimenti. Ora ci si mettono anche i curati a seminare zizzania e a procurarsi guai. Bene. Sistemeremo anche loro.”
E così, tra curati e briganti e presunti tali, le esecuzioni sommarie furono moltissime (anche se pare eccessiva la cifra di ottomila, indicata da Bayard de Volo) e dodici interi villaggi vennero incendiati per ordine dei generale Pinelli. Non erano, questi, episodi atti a facilitare l’auspicata integrazione fra Nord e Sud. Cosi come non veniva facilitata da proclami del genere di quello lanciato, sempre dal generale Pinelli, alle truppe piemontesi: “Siate inesorabili come il destino. Contro chi ci si oppone la pietà è delitto; sono i prezzolati scherani del vicario, non di Cristo, ma di Satana. Noi li annienteremo; schiacceremo il sacerdotale vampiro che colle sue sozze labbra succhia il sangue della madre nostra patria. Purificheremo col ferro e col fuoco le regioni infestate dall’immonda sua bava, e da quelle ceneri sorgerà rigogliosa la libertà.”
Sul fronte militare i fratelli liberatori procedono a suon di proclami, fucilate ed esecuzioni sommarie; sul fronte psico-economico adottano invece la strategia dell’affamato stringendo senza remissione i cordoni della borsa. “II Comune di Palermo – ridacchia il La Farina dalla Sicilia, in una lettera al Cavour del dicembre ’60 – è ridotto al punto di non aver da pagare i lampionai, le balie dei trovatelli minacciano di dover abbandonare i bambini, oggi mi si annuncia che i matti non hanno il pane, e quindi il sindaco è tutti i giorni dietro al mio uscio a pitoccare…” Con questo spirito i fratelli piemontesi accostavano gli altri fratelli dell’ltalia-libera-e-una. Potevano permetterselo. Stavano prendendo possesso delle loro nuove colonie. Acquisite, per di più, senza colpo ferire (se si eccettuano i tanto strombazzati quanto risibili fatti d’arme del generale Cialdini nelle Marche e nell’Umbria). Anzi, assai meglio che senza colpo ferire: offerti su un piatto d’argento. E avevano persino dovuto insistere, gli aspiranti sudditi. Fare anticamera. Come nel caso della deputazione di Modena e Parma (di quest’ultima faceva parte Giuseppe Verdi) che dovette attendere dieci giorni prima di essere “graziosamente ricevuta”; come nel caso della deputazione della Toscana che dovette fare anticamera a sua volta prima di sentirsi dire che il re era “disposto ad accoglierla”; e come, infine, la deputazione delle Romagne che non venne nemmeno ricevuta a Torino, ma che dovette spostarsi alla Villa Reale di Monza.
Che poi, tutta questa Italia regalata cadeva addosso a re Vittorio all’improvviso e non certo come una manna dal cielo. Il progetto originale, sia del Savoia, sia del suo ministro Cavour, infatti, non era tanto il “disegno storico” di liberare la “nazione asservita”, quanto quello più modesto e provincialotto (e molto più in stile con la Casa), di allargare il più possibile i propri domini. Quando dicono “Italia”, sia Vittorio sia Cavour pensano all’Italia settentrionale (la ricca Lombardia e il Veneto con l’accesso sull’Adriatico) e non si sognano certamente l’Italia pontificia, men che meno quella dei Borbone. Ora che il Ricasoli, il barone di ferro, gli ha regalato la Toscana “in nome della popolazione tutta”, lui, Vittorio, non sa cosa farsene. È dispostissimo a cambiarla con il Veneto che, invece, gli viene negato. Per il Veneto, anzi, è disposto a offrire qualcosa di più: un miliardo di lire e, in aggiunta, il consenso per il ritorno di Ferdinando di Lorena a Firenze (si tratta, è ovvio, di conti fatti un po’ frettolosamente, perché il miliardo non ce l’ha, e quanto alla Toscana c’è di mezzo il Ricasoli, per nulla disposto a lasciarsi barattare come merce di scarto). La stessa cosa per i principati dell’Italia centrale. “Dia i principati all’Austria e anche al diavolo se li vuole, ma ci faccia dare quel che voglio”, scrive al Cavour in missione a Parigi. Questi principati, dunque, proprio non li agognava. Dovette rassegnarsi ad accettarli, visto che ci tenevano tanto – come scrive il Massari – ad “andare a ingrossare le file dell’esercito liberatore, correre a militare sotto il vessillo di casa Savoia, obbedire agli ordini di re Vittorio Emanuele”. Soltanto al momento delle consultazioni popolari (11 marzo 1860) risultò lampante che gli unici a non smaniare per aggregarsi al Piemonte erano proprio i sudditi dell’Italia centrale, a dispetto di quanto volevano far credere i vari baroni, di ferro e non, e tutti gli altri candidati a occupare i posti lasciati liberi dagli “invasori stranieri”. Nonostante l’apologia risorgimentale (il solito Massari, ad esempio) ci abbia informato come “le popolazioni tennero l’invito con entusiasmo; accorsero alle urne con tutto lo slancio di un ardente e illuminato patriottismo”, sappiamo che in realtà l’operazione venne condotta con sistemi da regime totalitario.
Il Ricasoli – il quale da buon aristocratico non si faceva illusioni sui sentimenti del “buon popolo” – con una severissima circolare ai prefetti ordinò una mobilitazione in massa per portare alle urne tutta la popolazione in grado di votare. Stessa delusione – e anche questa sempre taciuta dall’apologia sabaudo-risorgimentale − verrà dalla consultazione popolare riguardante la cessione di Nizza e della Savoia. Tutti coloro (Garibaldi in testa) che si erano battuti affinché alle popolazioni di Nizza e della Savoia fosse conservato il privilegio di rimanere italiani, ebbero la non gradevole sorpresa di leggere nelle cifre finali che nella sola Nizza, su 25.000 votanti, 24.840 erano a favore dell’annessione alla Francia, e solo 160 ambivano l’onore di “militare sotto il vessillo di casa Savoia”. Vittorio dovette rassegnarsi ad accettare l’Italia e, quel che è peggio, a fare un giro per visitarla. E, come il suo ministro Cavour, si rese conto quasi subito di non aver fatto un grande affare: “Il n’y a pas de routes – scrive dal Meridione il 18.10.1860 (francese e piemontese erano, come è noto, le lingue ufficiali, e le uniche, del primo re d’Italia) – pas de ponts sur les fleuves, pas d’auberges, pas de pain, pas de vivres, et un abrutissement civil complet. Ce qui pourtant assassine c’est qu’on doit subir des baise-mains affreux de manière que des fois je suis bien dé moralisé. “ (1) Che peccato, caro Cavour, che tu non abbia visto l’Italia prima di farla…
Ma c’è anche chi da Sud replica: Servizio di leva? No grazie! Sto con i Borboni
Salvatore di Fede
L ‘unità non piace neppure a chi, nel Meridione, vuole difendere la propria identità culturale. Nel Regno di Sardegna l’esercito aveva avuto un ruolo più importante che nel Sud: organizzato sul modello francese, esprimeva strettissimi legami tra la gerarchia militare, la monarchia e la classe politica; per esempio, sia Cavour che D’Azeglio, presidenti del Consiglio negli anni ’50, erano stati ufficiali di carriera, come buona parte del personale politico piemontese. E mentre i Borboni favorivano l’esenzione dalla leva “per stimolare le arti ed i mestieri”. La Mormora, ministro della Guerra del Piemonte, difendendo l’esonero per i benestanti di quel regno (la somma richiesta era di L. 3.000, lo stipendio annuo di un professore dì Torino), nel 1854 così dichiarava al suo Parlamento: “Oltre che fare il soldato, costringerebbe i giovani che studiano a rinunciare spesso e per sempre alle carriere e professioni liberali con sorte troppo più dolorosa che non tocca alle altre classi a cui la milìzia non toglie l’arte e il mestiere. ”
Il privilegio borghese, il forte carattere burocratico e militare del Regno dei Savoia, la dura repressione delle minoranze ebree e valdesi negli anni di Carlo Alberto, la dicono lunga sul “nuovo ordine sociale” imposto al Sud con l’unità. Dopo la conquista garibaldina e il “pugno di ferro” dell’esercito piemontese, lo stato unitario usò ed estese anche al Meridione la legislazione piemontese in materia di leva. Per evitare sorprese furono sciolte le truppe garibaldine e borboniche, dando il via alla piemontesizzazione dell’esercito, che fu usato così come dice Settembrini: “come il fil di ferro, per cucire l’Italia e mantenerla unita.” La legge Ricotti sulla leva attuò, secondo quanto scrive Gianfranco Poggi, “un sistema di reclutamento che disperde le reclute sul territorio in maniera tale che molti soldati si trovano in località che non percepiscono ancora come parte del loro paese, e in cui e a cui si sentono acutamente estranei”. Si evitava così il pericolo di creare dei blocchi (militari e civili) culturalmente omogenei, che avrebbero potuto ribellarsi alla monarchia. “Viceversa – contìnua Poggi – se ci si troverà a dover usare unità dell’esercito per reprimere disordini entro la popolazione civile, può essere vantaggioso che si sentano in buona parte etnicamente e culturalmente estranee alle località in cui operano.
“Questa migrazione interna forzata serviva (come voleva la propaganda ufficiale)“, aggiunge Rochat, “a far conoscere l’Italia e gli Italiani fra di loro… una sorta di turismo coatto a fini patriottici, come se l’unità morale del paese potesse trarre giovamento dalla vita di caserma”. Con le prime leve vengono richiamate quattro classi di giovani meridionali. Ma su 76.000 coscritti nel 1861 i carabinieri del regno di Sardegna riuscirono a obbligarne solo 20.000, e con le armi. Scrive N. Colaianni: “Quando fu fatta la prima leva sotto i Sabaudi molti coscritti non risposero all’appello. Il governo con ferocia senza pari dà loro la caccia come a belve e ad incivilire i barbari manda ufficiali che assassinano i contadini soffocandoli col fumo come i francesi avevano incivilito i barbari della Kabilia”.
Nel 1863 nel circondario di Napoli si ebbe la più alta renitenza con il 57,7% degli iscritti agli elenchi di leva nazionali. È dello stesso anno la legge Gavone sulla repressione violenta della renitenza: alla fine del 1863, su 2.321 detenuti delle carceri militari, 1.073 erano dell’Italia meridionale. Tutti gli altri renitenti meridionali sfuggiti ai generali piemontesi confluirono nell’onda lunga del brigantaggio postunitario. Se i meridionali sono stati fino a quel momento estranei all’istituto dell’esercito, anche per la non aggressività militare della monarchia borbonica, dall’unità in poi essi costituirono e rappresentarono la più dura e lunga lotta (e fu di popolo) che si sia mai combattuta a Sud e in quella che fu poi l’Italia. L’esercito borbonico, che si scioglie come neve al sole di fronte a Garibaldi, si riorganizza in bande di popolo di fronte all’esercito del Piemonte, a difesa della propria libertà e cultura.
La resistenza alla leva si intrecciò, quando non le motivò, alle altre cause che suscitarono quella aspra lotta di popolo: numerosi sono gli episodi che testimoniano quella resistenza, numerosi come le migliaia di giovani che furono fatti fucilare e imprigionare per renitenza, insieme alle proprie donne e parenti. Una dura repressione, per un fenomeno importante e imponente. Emerge un filo che regge e tesse questi episodi e fa parlare di tradizionale estraneità del Mezzogiorno all’esercito (a quelli di tutta Europa che occupano nei secoli le nostre terre). Di questa cultura non militare è involontario testimone Cesare Lombroso, il criminologo organicista, allorché dice: “Da noi i ragazzi sogliono giocare ai soldatini ed è buon presagio d’una vita maschia ed energetica: in Calabria giuocano a fare il prete. ” E per sottolineare l’assenza di “spiriti guerreschi” aggiunge: “Nel saggio del Livi… la Calabria entra nel numero degli ufficiali e allievi colla cifra del 28,8%, cifra minima di tutto il regno.”
Col 1866 i soldati meridionali prendono parte, contro la propria volontà, a fatti di guerra, in una storia italiana che attraversano come spettatori attoniti e impauriti. Così scrive Antonio Uccello: “Il popolo era lontano dai problemi di politica interna e internazionale che la classe dirigente italiana affrontava in quel momento. Una vecchia di Canicattini Bagni, detta ‘a Santiuna’, che ebbe il padre richiamato nelle prime leve, raccontava del pianto e della disperazione della madre che, dopo anni di silenzio, priva di notizie (i richiamati erano quasi tutti analfabeti), pensava che il marito fosse morto. La Santiuna ricordava l’improvviso ritorno del padre… aveva portato un gran cappello con piume colorate, trastullo dei figli; raccontava di una grande festa che, coi suoi compagni, aveva fatta a Roma per avervi abbattuto un muro dopo una lunga corsa. Esclamava la vecchia: ‘Per questo gli fecero la festa: aveva abbattuto un muro… chissà che muro era.’ Il padre della Santiuna aveva partecipato coi bersaglieri alla presa di Roma.”
È alla luce di queste vicende che capiamo oggi la storia emblematica di due soldati meridionali, Salvatore Misdea, calabrese, e Costanzo, siciliano. Come tutti i coscritti meridionali, sul finire dell’800 questi furono obbligati a star lontani dalla propria terra per tanti anni da un’assurda legge che aveva in fondo paura di loro e della loro diversa cultura. Misdea e Costanzo, soggetti a un’autorità rigida e sprezzante, condannati al silenzio perché parlavano una lingua incomprensibile all’ufficialità piemontese, tolti d’autorità al loro ambiente culturale, costretti nei limiti alienanti del linguaggio e della tradizione militare, in un momento di disperazione e di impotenza, uccisero dei militari (loro superiori per grado), sotto le bandiere di quell’Italia fatta unita per volontà degli industriali del Nord, degli agrari del Sud, della borghesia liberale e su tutto della “virtù sabauda”. Furono entrambi condannati a morte, con l’accusa d’esser pazzi omicidi.
Del caso Misdea, nel 1884, si occupò Lombroso, il criminologo. Nel 1862 era stato in Calabria come ufficiale-medico. Nel libro scritto in quei tre mesi descrive un popolo “dotato di un senso estetico delicatissimo” ma folle, arretrato, sporco e malato. Quella esperienza in Calabria gli permise di risolvere e ridurre la ribellione di Misdea in una diagnosi di “furore epilettico”. Le esplosioni di violenza di Misdea, di Costanzo poi e tutte le altre che seguirono, si spiegavano, per lui, nel ‘‘temperamento bilioso” proprio dei meridionali, che erano anche vittime del ‘‘morbus astratis, in proporzioni enormi” così come della “pazzia morale”. Lombroso ha così consegnato Misdea alla storia della follia, rendendo da un lato giustizia alla patria “straziata” da tanta violenza, e dall’altro col Misdeismo (come sindrome) ha permesso l’identificazione, criminalizzante, tra follia e meridionalità. Oggi sappiamo che quegli “umori bellicosi”, lungi dall’essere insani atti di follia, furono l’inevitabile risposta a una condizione che negava una cultura subalterna.
E arriviamo ai nostri giorni: il rifiuto collettivo al servizio militare, da parte di giovani baraccati della Valle del Belice (e prima del 1972, anno in cui fu riconosciuta, con la 772, l’obiezione di coscienza). Su 1.800 giovani che nel 1970 avrebbero dovuto rispondere alla chiamata alle armi, 920 erano emigrati, 150 si erano arruolati in polizia e 60 erano in carcere. I “superstiti” nel 1970, in massa, rifiutano la coscrizione per protestare contro lo stato che aveva mancato ai suoi impegni di ricostruzione, e contro il sottosviluppo a cui era (è) condannato il Mezzogiorno. Quella che nasce da questo contesto è un’obiezione di coscienza collettiva, come lotta “all’esercito subìto con la violenza” e strumento di lotta per una “società senza sfruttatori”. Dopo lunghi processi fu loro concesso di svolgere il servizio civile. Nel 1972 viene riconosciuto il principio dell’obiezione di coscienza con la legge 772, alla cui approvazione senz’altro contribuì la lotta dei baraccati della Valle del Belice.
La nostra storia è dunque anche storia di libertà, di renitenza ieri, di obiezione di coscienza oggi. È la storia di un popolo che ha sempre lottato e combattuto a difesa della pace e del suo lavoro, e che all’unità e all’emigrazione ha sacrificato molto della propria identità culturale. Obiettare all’esercito è anche lavorare per l’autonomia, contro la dipendenza coloniale e il sottosviluppo. Scegliere per il servizio civile è restare a Sud, nei nostri paesi, senza emigrare una volta di più.
Note
1 “Non ci sono strade, ponti sui fiumi, locande, pane, cibo, e c’è un totale abbrutimento civile. Ma ciò che sconvolge è il fatto che si debbano sopportare dei baciamano terribili, tanto che a volte sono parecchio demoralizzato.”