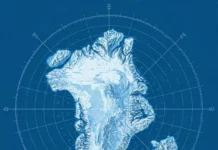Più di 227mila positivi accertati e un numero di morti che ha superato la soglia dei 30mila, impianti produttivi ed esercizi commerciali rimasti chiusi per settimane, ragazzi a casa da scuola dall’inverno inoltrato: nel tardo pomeriggio del 21 febbraio, quando apprendevamo l’ufficialità del primo caso di contagio Covid 19 sui nostri territori, probabilmente nessuno, neanche i più pessimisti, avrebbe immaginato un tale scenario di morte e sofferenza. Il virus si è diffuso a macchia d’olio anche in Europa e in tutto il mondo causando 328mila decessi, ha segnato una cesura indelebile nella storia mutando le nostre abitudini che ragionevolmente non torneranno uguali a prima ancora per parecchio tempo, anche a pandemia conclusa, il tutto in una prospettiva di probabile recessione economica globale che non lascia ben sperare.
I principali focolai epidemici si sono registrati in aree densamente popolate e di transito nelle quali gravitavano milioni di persone ogni giorno: Wuhan prima, la Lombardia, il Regno Unito e New York poi, sono così saliti tristemente agli onori della cronaca quotidiana. Tuttavia il Coronavirus è arrivato anche in zone della terra scarsamente abitate, dove da secoli risiedono popoli incontattati o che hanno scelto di vivere isolati, lontano dalla civiltà globalizzata. Queste situazioni risultano particolarmente complesse e delicate in quanto, se l’infezione si diffondesse violentemente all’interno di questi gruppi, la loro sorte potrebbe essere segnata per sempre e portare addirittura all’estinzione.

Al riguardo l’Amazzonia è sicuramente il territorio che corre il pericolo maggiore, trattandosi di un’area unica per la biodiversità vegetale (il polmone verde) e per quella antropologica, con la più elevata concentrazione di popoli isolati del pianeta: gli yanomami, gli awà, i waorani, i kawahiva, i munduruku, sono tutti gruppi che hanno preferito vivere lontano dagli altri per conservare e preservare il loro patrimonio culturale. Sono quindi decisamente più vulnerabili al contagio non essendo quasi mai entrati in contatto con l’esterno e non avendo di conseguenza sviluppato difese immunitarie sufficienti; inoltre i popoli indigeni adottano uno stile di vita comunitario, hanno un accesso limitato a beni e servizi e vivono a notevole distanza dalle strutture ospedaliere, tutti fattori che non giocano a loro favore durante questa epidemia.
Ma la cosa più preoccupante è la politica anti-indigena portata avanti dal governo centrale brasiliano. Il presidente Jair Bolsonaro fin dall’inizio del suo mandato ha perseguito una strategia volta alla sottrazione delle terre natie ai gruppi autoctoni, visti come un impedimento allo sfruttamento commerciale della regione amazzonica. Lo scorso gennaio ha pertanto nominato il missionario evangelico Ricardo Lopes Dias a capo del dipartimento dei popoli incontattati o di recente contatto della FUNAI (Fundação Nacional Do Índio), l’agenzia responsabile della tutela e protezione dei gruppi indigeni e dei loro luoghi ancestrali. Il problema è che Dias appartiene a New Tribes Mission (conosciuta negli USA come Ethnos 360), una delle organizzazioni missionarie più estremiste del mondo che ha come obiettivo primario la conversione forzata dei popoli isolati, ottenuta con ogni mezzo e a qualsiasi prezzo; e ha già comunicato di aver ideato piani per contattare le tribù della Valle Javari, acquistando anche un elicottero per poterli raggiungere. In questa situazione di pandemia generale, con i casi in Brasile che continuano ad aumentare, il contatto con “missionari” provenienti dall’esterno sarebbe fatale e si tradurrebbe in un etnocidio.

Non viene soltanto dai missionari evangelici il pericolo per i popoli amazzonici: essi sono infatti minacciati anche dai cercatori d’oro illegali e di petrolio, dai protagonisti del traffico di legname e dagli allevatori dell’agro-business. È stato stimato che, in particolare nell’area dove vivono gli yanomami, nello Stato di Roraima al confine tra Brasile e Venezuela, siano presenti circa 20mila minatori illegali che scorrazzano liberamente per il territorio indigeno saccheggiandolo e depredandolo e, in questo periodo, mettendo a rischio la salute dell’intero nucleo indigeno.
Survival International, che fin dall’inizio si era opposta alla nomina di Dias, ha esercitato forti pressioni sul governo brasiliano sensibilizzando l’opinione pubblica mondiale e lanciando una campagna volta a boicottare il neoeletto rappresentante e a bloccare l’attività estrattiva nella regione.
Inoltre l’UNIVAJA, l’organizzazione indigena della Valle Javari, ha intentato una causa contro i missionari e chiunque voglia tentare di raggiungere le tribù isolate dell’area. A fine aprile è stata emessa una storica sentenza che ha ufficialmente proibito ai missionari evangelici di raggiungere e contattare i popoli isolati a causa della loro particolare vulnerabilità, pena una multa giornaliera di 1000 real. Inoltre il giudice ha autorizzato il ricorso a polizia e militari per far rispettare la sentenza. Si tratta di una vittoria importantissima quanto inattesa, dal momento che l’azione evangelizzatrice in atto era ben organizzata e i missionari decisi a portarla fino in fondo. È ora auspicabile che il governo locale vigili affinché nessuno provi a rimettere piede nella zona, proprio quando per una volta la legge si è schierata a fianco degli autoctoni: dovrebbero essere sempre loro, infatti, a poter scegliere come vivere, difendendo questo sacrosanto diritto così come le loro terre ancestrali.
Se la sentenza venisse realmente fatta rispettare, forse il Coronavirus non risulterà fatale per le tribù amazzoniche. Al momento si segnala una giovane vittima, il quindicenne Alvanei Xirixana, membro yanomami del villaggio di Rehebe nell’area del fiume Uraricoera, venuto a mancare il 9 aprile. La speranza è che la chiusura della valle abbia limitato il più possibile gli scambi e l’eventualità di contagi, altrimenti le conseguenze sarebbero gravissime.
Anche in altre aree del Sudamerica la situazione non è migliore: una menzione preoccupata riguarda la situazione dei waorani. Indigeni dell’Amazzonia ecuadoregna, vivono una situazione critica per la scarsità nei loro villaggi dei servizi di base, quali la fornitura di acqua potabile e la rete fognaria, impossibilitati pertanto ad affrontare da soli un’epidemia di questa intensità che in Ecuador ha già mietuto quasi 2800 vittime. Il dramma è che il sistema sanitario nazionale si trova al limite del collasso e il governo centrale non ha fatto niente per aiutare le comunità indigene.

Alcuni gruppi nativi appaiono in seria difficoltà anche in Nordamerica; come i navajo, i quali in alcune riserve non possono usufruire d’acqua corrente e, più in generale, non hanno servizi sanitari adeguati. Il numero di contagi sta aumentando vertiginosamente, superando le 100 vittime e registrando tassi infettivi tra i più alti del mondo. Jonathan Nez, il presidente della nazione navajo, ha attaccato le autorità statunitensi affermando che il suo popolo non ha ancora ricevuto un centesimo dei fondi d’emergenza stanziati dal Congresso. In questo clima di drammatica difficoltà appare ancora più controversa – meglio, vergognosa – la decisione governativa di revocare lo status di riserva alla tribù dei mashpee wampanoag in Massachussets: il dipartimento degli Interni ha di fatto privato gli amerindiani del diritto a governare sulle loro terre natìe, rubando ancora una volta acri di terreno a loro sacri da secoli. È soltanto l’ultimo dei furti commessi dal governo centrale nei confronti delle tribù pellirosse, ma risulta ancora più vile in quanto perpetrato in un momento di crisi nazionale e mondiale, con una pandemia non ancora placata le cui conseguenze potrebbero coinvolgere anche i wampanoag.
In Asia la situazione generale sembra in leggero miglioramento, anche se non sempre si riscontra una piena affidabilità dei dati diffusi, con numeri da prendere con le pinze. Come riporta Survival, il cui monitoraggio è costante non solo in Brasile ma in tutto il mondo, alcuni popoli indigeni come gli orang rimba in Indonesia e gli adivasi in India hanno scelto volontariamente di mettersi in isolamento spontaneo nelle foreste e, dove possibile, hanno chiuso l’accesso ai loro territori per evitare qualsiasi contatto con l’esterno.
È invece da monitorare il caso degli uighur, etnia turcofona di origine mongolica e religione islamica che vive da minoranza nella Cina nord-occidentale, nella regione dello Xinjiang. Nonostante il governo di Pechino abbia da sempre cercato di evitare che informazioni al riguardo uscissero dal territorio nazionale, non è un mistero che questo popolo, al pari di altre minoranze musulmane presenti in Cina, abbia subìto una brutale repressione tramite i “campi di rieducazione”, apposite strutture dove sono stati trasferiti a forza milioni di uighur con l’intento di reprimerne cultura, religione, lingua e tradizioni. Nati inizialmente con la scusa di “trasformare” gli usi e costumi delle minoranze per adattarli ai modelli tradizionali dei cinesi han, sono diventati luoghi di prigionia a tutti gli effetti nei quali vengono incarcerati ogni anno i musulmani senza aver subìto un regolare processo: si tratta di una vera persecuzione.

All’inizio del mese di aprile sono stati documentati vari trasferimenti di massa di operai uighur spediti a lavorare al di fuori dello Xinjiang in fabbriche della Cina centro-orientale, per sostituire i lavoratori cinesi obbligati a rimanere in quarantena nelle loro abitazioni a causa del Coronavirus… con tutti i rischi relativi al fatto che proprio il cuore del Paese ha rappresentato l’epicentro del contagio globale. In sostanza l’idea di Pechino è stata di utilizzare lavoratori uighur e di altre minoranze per far ripartire l’ingente motore dell’economia nazionale; ovviamente obbligandoli, pena la reclusione forzata nei famigerati “campi di rieducazione”. Ci troviamo di fronte all’ennesima vessazione nei confronti di un popolo perseguitato da anni, ma altresì abbandonato a se stesso anche dai Paesi a maggioranza islamica che, in altri casi, non fanno mancare il sostegno ai loro correligionari nel mondo. Anche qui i rischi sono altissimi, sia per chi è stato costretto a lavorare nelle fabbriche delle aree interessate dai primi focolai epidemici, sia per i prigionieri dei campi di rieducazione nella malaugurata ipotesi che il virus si diffonda al loro interno: milioni di uighur potrebbero non avere scampo.
Il Covid ha fortemente colpito noi occidentali, abitanti delle zone maggiormente popolate e produttive arrecando pesantissimi danni in termini di vite umane, economici e socio-culturali (di quest’ultimi, gli effetti probabilmente ci appariranno nitidi solo tra qualche tempo). Tuttavia è altrettanto importante raccontare le vicende dei popoli che vivono in aree più remote della terra e le loro battaglie contro il virus, anch’esse assai difficoltose: in alcuni casi la mancanza di strutture sanitarie e di servizi di base adeguati, uniti alle inadempienze dei governi centrali, potrebbe portare a devastanti stermini. Siano popoli che hanno optato per vivere isolati o minoranze ingiustamente maltrattate, essi necessitano di tutto l’aiuto possibile affinché non corrano il rischio di scomparire per sempre. Per loro non sarà certo sufficiente continuare a ripetere che “andrà tutto bene”…