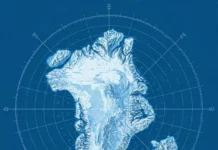I crimini compiuti dalla Stato turco nei confronti del popolo curdo (al limite dell’etnocidio) sono relativamente noti, anche se non abbastanza. Ma forse meno quelli operati da Teheran. Qualche recente episodio mi sembra abbastanza indicativo.
Risale al 2 luglio 2018 il gesto disperato di Marjan Behrouzi, la mamma di Hedayat Abdullahpour, prigioniero politico curdo arrestato nel 2016 e condannato a morte in Iran. Un evento che non ha trovato adeguato risalto sui media. Marjan si cosparse di liquido infiammabile (pare benzina) per immolarsi davanti all’ufficio del governatore di Shenoy. Il suo atto estremo venne però bloccato dall’intervento di alcune persone che avevano visto quando stava accadendo.
Qualche giorno prima, il 30 giugno, era stato arrestato dai servizi di sicurezza nella sua abitazione anche Farhar, fratello di Hedayat, accusato di aver collaborato con un partito dell’opposizione clandestina curda. Stando alle dichiarazioni di un familiare, dopo aver subìto brutali torture, Farhar sarebbe stato trasferito in un commissariato di Oroumieh. Inoltre anche Abu Bakr, padre dei due prigionieri politici, era stato sottoposto a interrogatori e maltrattamenti. E tutto questo avrebbe alimentato la comprensibile disperazione della madre.
Hedayat Abdullahpour fu arrestato nella città di Oshnavieh (Sino, in curdo) e accusato, sostanzialmente senza prove, di fare attività di propaganda per un partito clandestino di opposizione, di appoggiare i guerriglieri curdi del PJAK 1) e anche di aver preso parte a scontri con i pasdaran, i guardiani della rivoluzione islamica. L’accusa di legami con la guerriglia curda viene utilizzata abitualmente dalle forze di sicurezza iraniane come pretesto per arrestare qualsiasi attivista curdo, sia o meno effettivamente legato a qualche organizzazione clandestina.
In aprile un altro militante curdo venne condannato a morte, nel processo di appello, dalla Corte suprema di un Tribunale Islamico Rivoluzionario. Al momento della seconda condanna il ventiquattrenne Ramin Hisen Penahi – arrestato con l’accusa di far parte dell’organizzazione Komala 2) e di “lottare contro il governo islamico” – era ancora in sciopero della fame (da gennaio) per protestare contro la prima condanna.
Rimasto ferito in una imboscata tesa dai pasdaran a un gruppo di quattro militanti, fu l’unico a sopravvivere all’agguato. Ramin Penahi, che al momento della cattura non era nemmeno armato, venne poi torturato. Con la possibilità di vedere il suo avvocato soltanto una volta, brevemente e alla presenza di agenti. Il suo processo era durato soltanto un’ora.
Anche la madre di questo prigioniero politico curdo si era mobilitata per la salvezza del figlio. In maggio aveva rivolto un appello a Federica Mogherini – rappresentante UE per la politica estera e la sicurezza – affinché l’Unione Europea intervenisse per protestare contro l’esecuzione (con data già stabilita) di Ramin.
Aveva scritto:
Questa è la lettera di una madre da un piccolo comune nel Kurdistan iraniano. Una madre il cui cuore ogni giorno si riempie della paura che una parte del suo cuore venga giustiziato. Capisce cosa significa?
Sono una madre con un cuore in fiamme. Da tre anni non c’è sollievo. Da lunghi anni sostengo i miei figli che parlano di legalità e giustizia. Ma qui tutto è vietato. Quello che vivo oggi ricorda l’inferno.
Sono sicura che avrà sentito il nome di Ramîn Hisên Penahî. Perfino se Ramîn dovesse aver fatto un errore, la sentenza contro di lui non può essere un’esecuzione. Ho ragione con quello che dico? Ramîn è un attivista politico. Vogliono giustiziarlo perché hanno costruito un sistema della menzogna. Vorrei che Lei incontrasse i responsabili in Iran e fermasse l’esecuzione di Ramîn. L’Iran deve essere condannato davanti alla Corte di Giustizia Europea. Per via di mio figlio piccolo Ramîn ogni giorno è un peso per me. Si metta nella mia condizione. Faccia qualcosa per impedire questa catastrofe. Sono certa che Lei possa fare qualcosa. Vorrei che si impegnasse seriamente per fermare questa decisione. Non permetta che Ramîn venga giustiziato.
Purtroppo, come c’era da aspettarsi, dopo mesi e mesi trascorsi nel braccio della morte, Ramin Hisen Panahi venne impiccato il 9 settembre alle prime luci dell’alba nel carcere di Raja’i Shahr a Karaj (provincia di Hengaw). Dandone l’annuncio, il fratello Amjad chiese alla comunità internazionale di condannare sia l’avvenuta esecuzione, sia quelle previste per altri detenuti politici in Iran.
Qualche giorno prima dell’esecuzione Panahi era apparso in un breve video. Con voce roca, aveva voluto comunque ringraziare familiari, amici e il suo popolo per il sostegno datogli in tutti questi mesi.

Meryem Fereci torturata e assassinata
Ma in Iran ai curdi – e alle donne curde in particolare – succede anche di peggio. Il 14 luglio 2018 le peggiori ipotesi sulla sorte di Meryem Fereci, studentessa curda di 33 anni desaparecida da oltre una settimana a Teheran, trovavano tragica conferma. Sequestrata e torturata, era stata poi eliminata in una operazione di “guerra sporca” da manuale.
I primi timori per la sua vita risalivano a una decina di giorni prima, quando non era più rientrata a casa. Ovviamente i suoi amici avevano da subito pensato che fosse di nuovo in mano alle forze di polizia.
Come aveva ricordato il suo avvocato, la giovane curda era stata condannata a tre anni di carcere dal Tribunale Rivoluzionario per aver partecipato a manifestazioni di protesta alla fine del 2017 e agli inizi del 2018. Dapprima detenuta, le era stata poi concessa la “libertà vigilata” con l’obbligo di recarsi ogni giorno a firmare in un commissariato. Possiamo immaginare cosa sia accaduto, forse proprio all’interno del commissariato: lei donna, curda, dissidente, in balia degli aguzzini in divisa…
Stando ai primi rilevamenti, il corpo di Meryem, bruciato (anzi carbonizzato, per rendere difficile l’identificazione, mascherare i segni delle violenze, forse di uno stupro), presentava segni evidenti di tortura. Ufficialmente sarebbe stato ritrovato dalla polizia soltanto sabato 14 luglio e il riconoscimento del cadavere è avvenuto con il test del DNA.
A darne la notizia fu l’associazione che promuove la “Campagna di Difesa dei Diritti dei prigionieri”. Appare evidente che si è di fronte all’ennesima violazione dei diritti umani e del diritto dei popoli da parte del regime iraniano: nella sostanza non molto diverso da quello turco, almeno nei confronti dei curdi.

N O T E
1) Ricordo che il PJAK (partito della vita libera in Kurdistan; in curdo Partiya Jiyana Azad a Kurdistane) è un’organizzazione che opera, anche con l’autodifesa armata, nel Rojhelat (i territori curdi sotto l’amministrazione iraniana dove vivono circa nove milioni di curdi). Viene considerato legato al PKK e fa parte dell’Unione delle Comunità del Kurdistan.
2) Komala (“società”) è un’organizzazione curda la cui origine risale al 1969. Il suo nome completo è Komeley Sorrisgerri Zehmetkesani Kurdistan Eran (KSZK, società dei lavoratori rivoluzionari del Kurdistan). Nacque nel 1968 (con un impianto ideologico marxista-leninista, inizialmente maoista) come movimento di opposizione alla monarchia persiana e per difendere la popolazione curda. Venne duramente represso dalla polizia segreta, la famigerata Savak. Con la rivoluzione iraniana, Komala si era trasformato in partito politico laico, opponendosi al referendum per l’istituzione di una repubblica islamica. Dotato di una forza di autodifesa armata, attiva soprattutto nella provincia di Sanandaj, nel 1982 contribuì alla ricostituzione del partito comunista dell’Iran. Ne prenderà le distanze nel 2000 con la nascita dell’Organizzazione rivoluzionaria del popolo del Kurdistan. Attualmente si potrebbe definire un’organizzazione socialdemocratica.