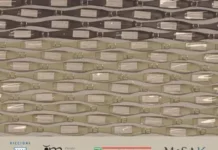Forse perché sostanzialmente pacifica, poco propensa alle rivolte armate, la comunità assiro-caldea (siriaca) era certamente meno nota rispetto ad altre altre minoranze etniche o religiose più “combattive”, come i curdi o anche i drusi.
Gli assiri abitano i territori mediorientali da almeno duemila anni e la loro lingua, di origine aramaica, presenta tre varianti: il caldeo, l’assiro e il turoyo. Ugualmente sono presenti tre chiese cristiane: la Chiesa Caldea (cattolica), l’Antica Chiesa d’Oriente (ortodossa) e la Chiesa Assira d’Oriente che deriva direttamente dall’eresia nestoriana (minoritaria).
Meno nota si diceva, anche se saltuariamente se ne parla. Per esempio una decina di anni fa (ottobre 2015) quando un folto gruppo di hunger striker diede inizio a uno sciopero della fame nel distretto di Midyat (provincia di Mardin, sud-est della Turchia) chiedendo il riconoscimento del genocidio assiro (conosciuto come sayfo, “spada”) di un secolo prima. Raccogliendo la solidarietà e il sostegno di alcuni sindacati turchi e del partito democratico del popolo (hdp, filo-curdo).
All’epoca, Aynur Özgün, esponente dell’assemblea delle donne siriache, annunciava che “non era quello il primo sciopero della fame e non sarebbe stato nemmeno l’ultimo”. Del resto la loro lotta per il riconoscimento del genocidio e per i diritti del popolo siriaco durava da diversi decenni, anche se in passato gli scioperi della fame venivano organizzati soprattutto dalla diaspora.
 Oltre alle migliaia di quelli deportati, sarebbero oltre 300mila gli assiri massacrati dalle truppe ottomane – contemporaneamente agli armeni e ai greci del Ponto – tra il 1914 e il 1920, all’epoca dei Giovani Turchi e della disgregazione dell’impero ottomano). Le prime stragi di massa avvennero nel sud-est dell’attuale Turchia, oltre che a Mardin anche a Diyarbakir (in curdo Amed) dove vennero uccisi tutti i maschi assiri. Ovviamente, come per gli armeni, lo Stato turco si è sempre rifiutato di riconoscere il genocidio degli assiri, accusando chi protestava di “falsificare la storia e diffamare la Turchia”.
Oltre alle migliaia di quelli deportati, sarebbero oltre 300mila gli assiri massacrati dalle truppe ottomane – contemporaneamente agli armeni e ai greci del Ponto – tra il 1914 e il 1920, all’epoca dei Giovani Turchi e della disgregazione dell’impero ottomano). Le prime stragi di massa avvennero nel sud-est dell’attuale Turchia, oltre che a Mardin anche a Diyarbakir (in curdo Amed) dove vennero uccisi tutti i maschi assiri. Ovviamente, come per gli armeni, lo Stato turco si è sempre rifiutato di riconoscere il genocidio degli assiri, accusando chi protestava di “falsificare la storia e diffamare la Turchia”.
Ma una conferma ulteriore della portata di tale genocidio è venuta in questi giorni: grazie alla scoperta di uno strettissimo passaggio segreto, centinaia di crani e resti umani (la maggior parte sarebbero di donne e bambini) sono stati rinvenuti in una chiesa, Mor Dimet, la più grande delle sette presenti ad Arbo. Si tratta di un villaggio assiro che sorge sulle pendici del monte Bagok, nel distretto di Nisêbîn nella provincia – attualmente a maggioranza curda – di Mardin.
Nel secolo scorso tale località è stata evacuata almeno tre-quattro volte, sia dagli ottomani che dai turchi: la prima nel 1914, l’ultima nel 1990. Le case e le chiese erano state demolite e centinaia di persone risultavano uccise o scomparse. Solo all’inizio del terzo millennio alcune famiglie assire della diaspora hanno ricominciato a ricostruire e ripopolare il paese.
Il merito di aver documentato per prima tale scoperta spetta all’Agenzia Mezopotamya.

Ce n’è per tutti
Come è forse noto, dopo aver sterminato assiri e armeni (un milione di vittime), la Turchia non aveva risparmiato nemmeno i curdi. Come appunto ci ricordano il massacro di Zîlan (1930) e quello di Dersim (1937-1938).
Successivamente, negli anni novanta, circa 5mila villaggi curdi (nelle regioni di Şirnex, Mêrdîn, Êlih, Amed…) vennero prima forzatamente evacuati e poi dati alle fiamme dai soldati turchi, lasciando sul terreno oltre 17mila vittime (senza spiegazioni ufficiali sulle cause, le modalità di tali decessi) e costringendo mezzo milione di persone a migrare verso le maggiori città turche.
Si presume che la maggior parte dei curdi deceduti siano rimasti vittime delle formazioni paramilitari (come jitem) responsabili delle operazioni di “guerra sporca”. Come era avvenuto per gli assiri (vedi appunto il recente ritrovamento nel villaggio di Arbo), così migliaia di cadaveri di curdi sono stati sepolti in fosse comuni, sotto le abitazioni o nei pozzi.