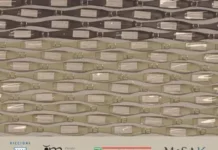Da qualche anno, la musica sta offrendo un apporto assai valido alla difficile e contrastata divulgazione del discorso etnico. Parliamo, naturalmente, della musica popolare nel suo senso culturale più completo, di quella musica che — rifuggendo dal popolaresco e dalla pittoresca vernacolarità — rappresenta il patrimonio nazionale e colto di una comunità ricca di lingua, storia e tradizione, ancorché non di dignità politica. Un’arte che potremmo definire sempre più “etnica” e sempre meno “folk”.
La tradizione musicale ha doti di resistenza e di conservazione nettamente superiori rispetto al fattore linguistico e, confinata com’è nell’ambito ristretto delle ricorrenze, risulta meno esposta della parlata alle campagne persecutorie del potere di importazione. Questa sua prima qualità permette, per esempio, di additare alla cultura ufficiale o a certi incauti esperti la vera provenienza di un popolo, anche laddove si è proceduto alla glottofagia della lingua locale o alla sua retrocessione al rango di dialetto. È il caso della Cornovaglia, terra in cui l’idioma cornico si è estinto da due secoli, ma dove la tradizione musicale è ben viva e inconfondibilmente celtica.
La musica, inoltre, ha doti di immediatezza e di penetrazione nei gusti della gente comune molto più efficaci di qualsiasi altro veicolo culturale: è ascolto, ma anche spettacolo; è suono, ma anche colore; è, insomma, un’occasione per proporre a un pubblico spesso poco avvertito un aspetto della realtà umana (etnica, nel nostro caso) che altrimenti sarebbe di diffìcile comprensione.
L’attuale rinascita della civiltà padana deve molto a questa indubbia capacità di aggregazione della musica, e la radice non certo “latina” di tale patrimonio rafforza sensibilmente le tesi di chi rivendica per queste terre un carattere di estrema singolarità.
Formazioni strumentali e vocali specializzate — come La Lionetta, i Prinsi Raimund, i Bes Galilì e i Celtag — comunicano a un pubblico composto in larga maggioranza da giovani i valori di un’antica tradizione celtica che è in netto contrasto con la propaganda della cultura ufficiale, la quale, come è noto, tende a gravitare su altre latitudini, decisamente estranee alla Padania.
![Prinsi-Raimund_saraceno300[1]](https://rivistaetnie.com/wp-content/uploads/2013/02/Prinsi-Raimund_saraceno3001-300x300.jpg)
Non c’è da stupirsi, quindi, se gli studiosi ben introdotti nell’ortodossia centralistica tentino di neutralizzare, da un po’ di tempo a questa parte, i principi storici, musicologici ed etnici che rivelano chiaramente l’origine dei popoli padani. Un esempio interessante è l’intervento di Roberto Leydi su La Stampa del 23 maggio 1981. Si tratta di un attacco nei confronti della nascente passione per la musicologia di area celtica, di cui vale la pena citare qualche passaggio: “I celti redivivi hanno violini, ghironde, chitarre, flauti e percorrono i sentieri dei concerti e dei festival di musica cosiddetta ’folk’ portando il loro ’messaggio’. Questi celti musicali sono di due categorie. Quelli che appartengono a un’area almeno un po’ celtica (…) e quelli che con la cultura celtica non c’entrano per niente e s’immaginano una patria perduta popolata appunto di celti”.
Va spiegato che gli “almeno un po’” celtici sono nientemeno che i bretoni e gli irlandesi, mentre i “per niente” sarebbero i padani, piemontesi in testa (per ironia della sorte, le loro lingue sono dette celtoromanze). Ma continuiamo: “Gli ansiosi ricercatori del celtismo italiano, infatti, vogliono a ogni costo affermare l’esistenza, fino alla musica popolare d’oggi, di una eredità celtica anche da noi. E ciò per dichiarare un valore di etnia contrapposto a quello latino, o gallico, o ligure, o veneto”. È interessante, qui, notare — oltre ad un sibillino accenno ai veneti — come l’articolista ignori candidamente che i galli erano celti. Ciò si palesa pienamente quando egli confessa che, in anni di indefesso lavoro sulla musica popolare del Settentrione, non ha “mai trovato segni di relazione con quanto altrove rimane della musica celtica”; peccato, perché anche il più sprovveduto orecchiante è in grado di carpire le sonorità comuni a un’ampia area europea nei reel del Carnevale di Bagolino o nelle danze del Piemonte.
Se gli incas sono latini…
Ora, tralasciando di abbandonarci a complicate disquisizioni paletnologiche sui celti, viene spontaneo denuciare piuttosto l’atteggiamento di chi, dal pulpito di una cultura ufficializzata, usa due pesi e due misure per affrontare i problemi etnici. Questi lamentatori all’italiana tollerano benevolmente i raggiri più iniqui, ma si indignano per ogni tentativo di reazione alla fertile inventiva di marca statale: perché, ci si domanda, si ha l’ardire di definire “latino” mezzo mondo, dalla Manica alla Patagonia, e poi si storce il naso di fronte alla celticità dei bretoni? Perché la celticità di un popolo che si è evoluto armonicamente e autonomamente — come l’irlandese — deve limitarsi alle memorie dell’antichità classica? Mentre, di converso, si continua a definire latini popoli le cui vestigia di romanità si limitano a qualche acquedotto o alla semplice tassonomia linguistica… E, parimenti, vorremmo che gli studiosi ci spiegassero chi abitava la Padania prima… degli italiani; i celti, concedono i fortunati possessori di una cultura protostorica; e dunque, o essi si sono estinti, o sono stati soffocati da un’invasione allogena ben diversa da quella politico-militar-amministrativa dei romani. Fatti scientificamente improponibili.
Di siffatte tematiche garibaldine sembrano del tutto disinteressarsi i giovani che assistono ai concerti sempre più affollati dei gruppi musicali celtopadani. Molti provengono dall’area della sinistra e si stanno convincendo che il triccheballacche e la caccavella non sono gli unici strumenti progressisti, e che la ghironda e la cornamusa piemontese non servono gli interessi di Agnelli.
Le formazioni più apprezzate sono composte da ammirevoli figure di musicisti-ricercatori, sempre in caccia di brani abbarbicati alla memoria dei vecchi e, per questo, estremamente aderenti alla tradizione. C’è anche chi, come La Lionetta (un complesso torinese), arricchisce i pezzi con una personale, gradevolissima musicalità, tacciata, ovviamente, di mistificazione dai soliti bacchettoni in quanto l’allofonia è tollerata come recupero archeologico, ma non come viva manifestazione del presente (diverso è il caso della musica italiana, definita tale e senza traumi da Verdi a Renato Zero). La riappropriazione del proprio passato non è un’operazione fantasiosa e velleitaria: tale passato sarebbe il presente se non fosse stato combattuto con tutti i mezzi dalla propaganda dei vari regimi italiani, ed è lecito rimediare alla forzata interruzione con una reazione altrettanto decisa.
In questa direzione si sta muovendo — oltre a un buon numero di ricercatori locali — l’etnomusicologo Michele L. Straniero il quale, a parte quanto riesce a far trapelare attraverso i severi microfoni della RAI, ha tenuto un ciclo di trasmissioni alla Radio Svizzera Italiana sulla tradizione dei paesi celtici o di origine celtica, non tralasciando la Padania (e quindi anche il Ticino).
Quando i contadini vestivano casual
Un eccellente risultato di critica e di pubblico ha ottenuto lo spettacolo organizzato dalla rivista “Etnie” e da Nanni Svampa nell’ambito delle manifestazioni di “Milano d’Estate”; il titolo poco austero — “Quando i contadini vestivano casual” — ha attirato migliaia di cittadini che per la prima volta hanno potuto conoscere la musica colta della Padania, accanto — e non in contrapposizione — ai temi più conosciuti e popolareschi delle canzoncine maliziose e dei cori da osteria. Hanno partecipato formazioni di ottimo livello tecnico, quali La Lionetta, i Prinsi Raìmund e La ciappa russa (Piemonte), La Kinkerne (Savoia), i Bes Galilì (Lombardia) e il Gruppo Emiliano di Musica Popolare. Lo spettacolo sarà replicato in altre province ed è allo studio un accordo con la Rete 3 per una riduzione televisiva.

Evidentemente, queste iniziative si rivelano un ottimo strumento per far breccia nell’ignoranza generale di popolazioni costrette a digerire menzogne storiche e culturali fino dalla prima età scolare. E di ciò dobbiamo ringraziare proprio la grande forza trainante della musica: un contributo sul quale dovremo puntare con sempre maggiore impegno per permettere alla Padania di guadagnare una dignità nazionale — paritaria e non subalterna — in una futura, auspicabile e deliziosamente utopistica “Europa dei popoli”.
Pubblicato nel 1981 su “Musicalbrandé”