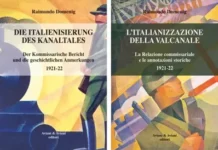Non è cosa semplice riuscire a sintetizzare quanto si è appreso dal corposo convegno intitolato La Repubblica tutela l’ambiente e gli animali – Stato dell’arte e avanguardia della tutela giuridico-sociale degli animali e dell’ambiente, tenuto lo scorso dicembre a Villa Lattes, Vicenza. Ricchissimo di spunti e stimoli, è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Vicenza da varie associazioni protezioniste: enpa, Ass. Alveare – Recupero animali selvatici, Oasi Fortuna odv, Ass. Operatori del diritto per gli animali, Ass. osa – Oltre la sperimentazione animale, Il Pettirosso – Centro soccorso animali, Ass. Link Italia.
Una intensa giornata di approfondimento dedicata alla tutela giuridica e sociale degli animali e dell’ambiente, che la Costituzione italiana ha sancito con l’articolo 9, comma 3, elevando la protezione dell’ambiente e degli animali a principio costituzionale, rafforzandone il valore giuridico. Si sono succeduti interventi di docenti universitari, veterinari, ispettori di polizia e attivisti su vari temi: il diritto ambientale, la protezione della fauna selvatica, il benessere animale, la distruzione della biodiversità e degli habitat naturali, la vivisezione, gli illeciti sul trasporto degli animali, il maltrattamento, l’utilizzo dei richiami vivi, il bracconaggio, la tutela degli uccelli migratori, le realtà dell’associazionismo che si occupa della protezione e del salvataggio degli animali.
Nei primi interventi introduttivi scivolava furtiva qualche nota polemica sulla disparità di trattamento tra quello subìto dai blocchi stradali organizzati dalle lobby di allevatori e agricoltori (in qualche caso piuttosto “infuocati”, come a Bruxelles) e quelli, tutto sommato “ghandiani”, di ambientalisti e animalisti. Eppure, nonostante ciò, bisogna riconoscere che ormai si assiste, se non ancora a un vero e proprio “cambio di paradigma”, comunque alla diffusione di una diversa sensibilità sia nei confronti dell’ambiente, sia dei diritti degli altri animali. Anche da parte della pubblica amministrazione e in campo giuridico (vedi art. 9, art. 41, eccetera). Per cui, ribadiva la moderatrice dell’incontro, “la strada è piena di curve, ma comunque procede, va avanti…”.
Se un esponente di sos Anfibi lamentava che “per ragioni meramente economiche, magari viene installato il cartello che segnala il passaggio di anfibi, ma non viene costruito il sottopasso”, Luca Dal Monte, ispettore della polizia stradale, si soffermava sulla sofferta questione del trasporto degli animali vivi.
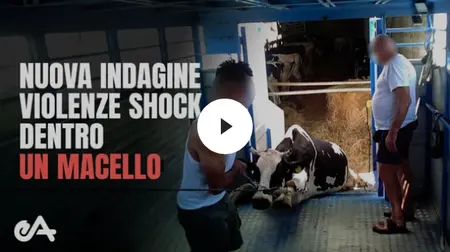
Nel suo intervento (Gli illeciti amministrativi penali nel trasporto degli animali durante i controlli di polizia stradale) spiegava che gli agenti intervengono in un primo momento visionando le autorizzazioni, l’idoneità del mezzo, i tempi di percorrenza tra partenza e destinazione – in genere il macello purtroppo – e i documenti di accompagnamento degli animali a livello sanitario. Per passare poi al controllo vero e proprio di quello che viene definito forse eufemisticamente. visto il contesto, “benessere animale”: ossia “se sono vivi, se hanno spazio, se possono accedere al cibo e all’acqua, se il veicolo è stato pulito, disinfettato, se è scivoloso (in quanto potrebbero ferirsi)…”.
Insomma, verificare se stanno “bene” per quanto possibile data la situazione.
Tra le violazioni ricorrenti, le condizioni delle “mucche inviate al macello per fine carriera (altro impietoso eufemismo che suscita ribrezzo se non orrore, sapendo che attualmente si prevedono 4-5 anni di ‘vita produttiva’ quando il bovino potrebbe viverne una trentina) deperite, sfinite da uno sfruttamento intensivo per produrre latte, vitelli… Anche animali ormai agonizzanti di cui sarebbe vietata la macellazione, messi nel camion utilizzando la pala meccanica o il verricello… Casi che il veterinario dovrebbe rifiutare”. Le ammende sono sia amministrative (intorno ai 2mila euro) sia penali, per maltrattamento animale con multe da 5mila a 30mila euro.
Per quanto riguarda il trasporto delle galline ovaiole, molte volte “le gabbie non risultano idonee”; così come per i conigli che spesso, osserva il funzionario, “non hanno spazio sufficiente: troviamo infatti animali morti o sotto stress. Per eccesso di carico (multa prevista 2-3 mila euro) e quindi per l’impossibilità di sdraiarsi o mangiare”. In realtà – e vale per i bovini come per i polli – essi talvolta “muoiono letteralmente per mancanza d’aria. A volte, oltre che tra di loro, lo spazio risulta insufficiente anche tra gli animali e il tetto”. Si tratta infatti di viaggi lunghissimi, anche di 30-40 ore, su mezzi non idonei, magari privi degli impianti per consentire alle bestie di abbeverarsi.
Verificato ciò, si chiama l’autorità competente e il veterinario può far fermare il trasporto. La denuncia riguarda sia il trasportatore sia l’allevatore e può comportare, oltre a una pena di tre mesi, la sospensione dell’attività per sei mesi.
In particolare l’ispettore Luca Dal Monte ha illustrato con immagini il caso di una mucca ormai non deambulante (necrosi delle zampe posteriori) e di un vitellino con una zampa fratturata che la madre cercava di sostenere, entrambi impietosamente destinati al macello. Per la cronaca, la cosa aveva comportato 3mila euro di multa.
Del resto spesso nelle visite post-mortem si riconoscono ancora i segni del verricello con cui gli animali, impossibilitati a muoversi autonomamente, erano stati caricati sui camion.
Per chi, imbevuto di antropocentrismo, si giustifica dicendo che “è naturale che muoiano”, si consiglia un ripasso della legislazione in materia. Dato che “la Repubblica tutela l’ambiente e gli animali”, questo dovrebbe garantire per lo meno “la libertà dalla fame e dalla sete”.
Invece bisogna amaramente riconoscere che non solo la situazione attuale è identica a quella di 30-40 anni fa, ma probabilmente è peggiorata. Tra l’altro il trasporto di animali vivi viene considerato una delle principali cause della resistenza agli antibiotici sempre più diffusa.
Le torture
Dario Buffoli, medico veterinario, consulente tecnico in attività antibracconaggio, specialista in etologia applicata e benessere animale, con il suo intervento (Uccelli da richiamo detenuti nelle gabbiette per utilizzo venatorio: configurazione di maltrattamenti o detenzioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze) ha affrontato l’annosa e irrisolta questione dell’imprigionamento in gabbiette a scopo venatorio. Consulente tecnico della Procura di Brescia (in una realtà che definisce “macello dei dolori”, tra veterinari conniventi, vacche trascinate a terra col muletto, eccetera) sullo specifico argomento ha ricordato che “per una legge del 2015 gli uccelli da richiamo non si possono catturare”. Tuttavia “sia nel bresciano che nel bergamasco la richiesta è ancora alta” – e non solo nelle Prealpi lombarde ma anche in Veneto – per cui essi in gran parte provengono da catture illecite con le reti, da prelievi effettuati direttamente nel nido o dai Paesi dell’Est, Polonia in testa.
Si crea così un traffico illegale che si configura come un modo per depauperare il patrimonio dello Stato.
Le piccole creature vengono allevate e vendute in gabbiette dalle esigue misure di 30 cm per 25 (ancora meno per le allodole). In realtà le gabbiette sono consentite soltanto nel periodo venatorio (da settembre a gennaio) e per il resto dell’anno (dal 1° febbraio alla terza domenica di settembre) i volatili prigionieri dovrebbero poter usufruire di voliere in quanto, come da sentenza del tar, le gabbiette penalizzano troppo il loro comportamento naturale.
Con gli accertamenti si valuta anche l’odore, la qualità dell’aria, la luminosità, lo stato igienico (Buffoli ricorda che “gli uccelli sono puliti”, per cui l’impossibilità di un bagno di sabbia o di acqua ne acuisce la sofferenza).
Posto che l’attività venatoria costituisce una “concessione dello Stato”, gli abusi – come ali tarpate, accecamenti, detenzione al buio, mancanza di cure adeguate, uso di ormoni, carenza di acqua e cibo – si configurano quali autentici reati “contro il sentimento per gli animali” (una norma che potrebbe evolvere valutando la sofferenza animale in sé e per sé).
Tra le varie infamie talvolta tollerate, la somministrazione di ormoni maschili (androgeni a uso umano) per farli cantare in autunno, incorrendo nel 544 Ter, “somministrazione di sostanze stupefacenti”. Spesso, ha denunciato Buffoli, “si riscontrano fratture delle ali, zampe spezzate, lesioni che si procurano sbattendo sulle sbarre per fuggire, presenza di parassiti, lesioni agli occhi. Fermo restando che l’assoluta impossibilità del volo è incompatibile con le esigenze primarie dell’animale”. Aggiungendo una “nota di colore “ (o di dolore): capita che dei ladri penetrati in casa aprano la gabbia per liberare un volatile recluso. In genere si tratta di persone che hanno già sperimentato le patrie galere e “sanno cosa si prova”: infatti gli uccelli sono “esseri senzienti che provano sia paura che contentezza, posseggono intelligenza e consapevolezza”.
Tutto ciò riporta alle “Cinque libertà” del Brambell Report. Pubblicato in Inghilterra nel 1965, esso rappresenta possiamo dire il “minimo sindacale” visto che non mette in discussione l’allevamento in quanto tale: “Libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione. Libertà di avere un ambiente fisico adeguato. Libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie. Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali. Libertà dalla paura e dal disagio”. Senza ignorare il Trattato di Lisbona del 2009, con cui si è riconosciuto che gli animali sono esseri senzienti e che l’Unione Europea ha la responsabilità di prevenire maltrattamenti, dolore e sofferenza.
Di tutto ciò, ha precisato Buffoli, “il magistrato dovrebbe esserne a conoscenza”, e in effetti il dato confortante è che “attualmente le procure tendono a essere più sensibili”, come confermerebbero varie sentenze della Cassazione.
Criminali e inquinamento
È quindi intervenuto Fabio Peluso, commissario capo della Polizia Provinciale di Brescia, sul tema Deterioramento e inquinamento degli habitat e perturbazioni negative per la fauna selvatica: i controlli ambientali che non si fanno più, affrontando vari aspetti delle devastazioni in corso a livello planetario: deforestazione, inquinamento, turismo, cementificazione, modifica del paesaggio, produzione industriale, allevamenti, navi da crociera… per non parlare dei danni irreparabili prodotti dalle guerre.
Egli ha denunciato come l’inquinamento si diffonda in maniera subdola, continua… arrivando all’assurdo dei capannoni stipati di plastica (raccolta differenziata in mano a organizzazioni di fatto criminali) per poi venir incendiati. O – restando nei casi concreti verificati personalmente – i caseifici che producono e diffondono ammoniaca, magari bypassando il depuratore e smaltendo direttamente nelle fognature. O l’utilizzo di scorie siderurgiche (“valorizzazione” da scoria a “risorsa”?) nei sempre più invasivi vigneti, ormai quasi una monocultura.
Un inciso per l’inceneritore della sua città, Brescia. Dove, pur con il 70% in differenziata (o magari grazie a questo), i rifiuti vengono ugualmente bruciati, ma appunto in maniera “differenziata”. Ossia in base alla necessità di produrre più o meno calore per l’acqua calda. A parte i copertoni, utilizzati per impermeabilizzare, praticamente tutto il resto è combustibile. Ricordando – per completare il quadro alquanto fosco – che in provincia di Brescia ci sono circa 190 grandi imprese e 420 allevamenti avicoli.
Risalgono al 2015 le modifiche al testo unico ambientale con cui si mantengono soltanto le contravvenzioni, con riduzione delle multe, e viene archiviata la parte penale. Per cui chi inquina se la cava con qualche migliaio di euro. Per non parlare dello “spappolamento” del corpo forestale e dell’ipotesi di abolizione delle province.
Curare i selvatici
Il Centro fauna selvatica “Il Pettirosso” di Modena si occupa prevalentemente della tutela degli animali selvatici, spesso affiancando i carabinieri forestali. L’intervento del direttore del centro, Pier Francesco Milani, verteva su Aspetti riabilitativi e prospettive di reinserimento degli animali sequestrati. Come riportato nel loro sito: “La fauna è tutelata dalle leggi nazionali e regionali che avvisano di contattare, al ritrovamento, l’Amministrazione Provinciale o un centro di recupero fauna. Questo perché la proprietà dell’animale selvatico è dello Stato, e le leggi che le tutelano sono molto severe. Ma ancora più importante per noi è la salute e la tutela dell’animale: se non si ha né il tempo sufficiente da dedicargli in questa fase fondamentale per assisterlo né l’esperienza per accudirlo, si rischia di fargli solo del male, e portarlo a un centro successivamente potrebbe essere inutile perché troppo tardi.
Un animale, male alimentato o imprintato, lo si condanna a morire e a essere pericoloso per lui e per la gente che gli starà intorno (non tutti possono avere il vostro buon cuore). È un animale che non saprà cacciare, non saprà di chi fidarsi o da chi guardarsi, non saprà a che specie appartiene e, non sapendo come comportarsi con i propri simili, potrebbe rischiare di venire ucciso proprio da loro: insomma, sarà un animale facile preda per tutti.
Se veramente siete interessati e avete voglia di completare l’opera di salvataggio del vostro amico, potrete farlo presso il Centro sotto la guida di operatori e volontari esperti, e insieme a loro lo potrete seguire fino al momento della liberazione. Questo è il vero amore per gli animali!”.
A tale scopo nel Centro (dove vengono curati sia caprioli sia lupi infortunati, anche con fratture serie) si fa ampio uso di telecamere, evitando per quanto possibile l’esposizione con gli umani, per scongiurare imprinting e addomesticamento, per poi ovviamente rimetterli in libertà.
Le indagini sulle morti sospette
La patologa forense, medico-veterinario e independent researcher Cristina Marchetti (Il danno alla salute negli uccelli da richiamo) è intervenuta su bracconaggio e uccisioni intenzionali di animali selvatici, sottolineando “la difficoltà di individuare le alterazioni su uccelli deceduti”, per lo meno nel fornire risultati significativi in tribunale. Ossia rilevare le lesioni interne derivate dalla condizione di cattività in quanto tale. Non potendo volare, le conseguenze fisico-patologiche possono arrivare fino al decesso anche indipendentemente dai maltrattamenti. Intervengono infatti vari fattori di stress: mancanza di luce, rumori improvvisi, presenza di persone o animali, senza che l’uccello possa sottrarsi con la fuga. Oltre ai trattamenti sanitari.
Se in natura lo stress ha una funzione positiva, in quanto porta a reagire (attaccare o fuggire), in stato di detenzione permanente diventa cronico, patologico. Con conseguenze evidenti quali la perdita delle penne, turbe psicologiche, danni al microbiota intestinale, calo delle difese immunitarie, infiammazioni, lesioni, zampette necrotiche (a causa dell’anello), malessere grave fino alla morte.
Insomma il patologo forense deve essere in grado di “vedere l’invisibile”, senza confondere le apparenze con le prove. Da qui l’importanza della documentazione fotografica con le lesioni ben visibili e un metro di riferimento.
Interessante quanto Marchetti ha illustrato (con immagini un po’ inquietanti, soprattutto nel confronto con il caso analogo di una persona anziana caduta senza potersi rialzare) sulla morte per “asfissia posizionale” di un’orsa che era stata sedata. Spiegando che “il sopralluogo è fondamentale, tanto quanto l’autopsia”.
Altro esempio, l’importanza delle radiografie nel caso di lupi morti poiché, secondo i responsabili, sarebbero stati “investiti”. In realtà. individuando i frammenti di piombo si dimostrava che prima erano stati intenzionalmente presi a fucilate. Oppure di lupi trovati riversi in autostrada, ma con fratture, non dovute all’impatto con l’auto, risalenti a giorni prima. O anche l’individuazione dell’anticongelante nel corpo dell’animale (forse per incentivare la perdita di sangue) o dei residui da sparo. Tutti indizi che escludevano l’incidente casuale.
Se per accertare l’ora del decesso sono fondamentali le uova di mosca (ma la verifica deve essere fatta sul luogo del rilevamento), in caso di presunto annegamento è doveroso cercare la presenza di diatomee. Così come è possibile verificare se l’uccello sia nato in natura o in cattività cercando nelle penne la presenza di isotopi stabili (legati al tipo di alimentazione).
Quanto alla ricerca di elementi nei campioni salivari, ricordava che “nei carnivori svaniscono in fretta. Dopo 72 ore non c’è più niente”. E, riprendendo il discorso già affrontato da Dario Buffoli sulla somministrazione di testosterone esogeno, suggeriva di analizzare le feci anche senza ricorrere a prelievi. In maniera rapida, efficace, per esempio nelle fiere espositive.
La storia di Cristina
Particolarmente toccante la testimonianza della scrittrice Cristina Rovelli (L’ultimo volo), prima donna guardiacaccia in Italia. I suoi dieci anni di lavoro sono stati “dieci anni di lotta con l’Ente per cui lavoravo, anni di acceso contrasto con la provincia di Lecco”.
Quella degli uccelli da richiamo è stata “la battaglia che mi ha fatto soffrire di più”: negli anni novanta si potevano catturare i migratori nei roccoli “con persone appositamente pagate con denaro pubblico per questo preciso scopo (oggi sarebbe bracconaggio)”. Rinchiusi in gabbiette di 28 cm, gli uccelli venivano portati al centro di smistamento dove orde di “cacciatori esaltati” erano in febbrile attesa. Praticamente “venivano regalati ai cacciatori”, con soldi pubblici, beninteso. A Cristina era capitato soltanto una volta l’ingrato compito di trasportarli al centro di smistamento. E ascoltandola si percepisce come le “profonde emozioni” di quella esperienza le siano rimaste ben incise nella mente nel cuore: “Alcuni sbattono le ali contro le sbarre, altri si rannicchiano come rassegnati”.
Racconta Cristina che andando a prenderli al roccolo rallentava sempre di più, e al ritorno andava ancora più piano. Finché si era decisa a fare una sosta, quasi per concedere alle piccole creature recluse un ultimo sguardo sui boschi. Mentre stava lì a rimuginare osservava i gancetti delle gabbie pensando che in fondo non erano poi tanto sicuri. Alla fine, com’era giusto, al centro di smistamento gli uccelli (quelli, almeno) non erano mai arrivati. Vi lasciamo immaginare i commenti o peggio dei cacciatori rimasti a bocca asciutta… Da allora non venne più incaricata di prelevare gli ucceli dai roccoli, ma la sua lotta da “dentro il sistema” in difesa delle piccole vittime non fu per questo meno dura. Lettere minatorie e gomme tagliate diventarono ordinaria amministrazione. Quando in Lombardia si parlò di finanziare l’apertura di altri roccoli e, anche per il suo impegno, il progetto venne bloccato, incendiarono l’auto di sua madre.
Se in un primo tempo “avevano tentato di comprarmi con la promozione”, racconta, in seguito cominciarono a fioccare i provvedimenti disciplinari. Finché si trattava di provvedimenti civili “potevo difendermi da sola”, ma poi, con false testimonianze, venne accusata addirittura di truffa. A questo punto “ho dovuto prendermi degli avvocati”; poi “mi hanno requisito la casa, finché non potendo più pagarli mi son dovuta licenziare”. Ma comunque, assicura, “rifarei tutto”.
Diventata guida naturalistica, ha scritto diversi libri su tematiche ambientali e animaliste (Il sapere e il sapore delle piante selvatiche, La mia vita con Bambi, Siamo andate dove il tempo si è fermato, Il grande cuore di Kim) il cui ricavato viene interamente utilizzato per attività di salvaguardia e protezione degli animali e dell’ambiente naturale nei progetti dell’Associazione Shangri Là.

Tra gli altri relatori, tutti encomiabili, Maria Concetta di Giacomo, medico internista isde-Medici per l’ambiente, lo scrittore Gianfranco Ferron (La bellezza della biodiversità), Diego Camisani e Federica Marangi (“18 anni di esperienza nella gestione di animali normalmente definiti ‘da reddito’ che entrando in un rifugio tornano a essere individui”), il consigliere regionale Andrea Zanoni (La fauna selvatica sacrificata per fini elettorali e l’obiezione di coscienza all’uccisione di animali per il personale di polizia), le guardie zoofile enpa Renzo Rizzi, Roberta Peroni e Paolo Pizzati (Uccelli da richiamo: come impiegare la giurisprudenza per proteggerli), la giornalista Giada Zandonà (Criticità e conflitti ambientali nella Bassa Padovana), Francesco Miazzi (per il Comitato Lasciateci Respirare di Monselice), il luogotenente dei carabinieri forestali Nicola Pierrotti (Uccelli: come riconoscere i segni di contraffazione degli anelli, le novità apportate nel corso degli anni), Francesca Sarcinelli, presidente Ass. Link-Italia (Crudeltà su animali e pericolosità sociale), Elena Buoso, docente di Diritto dell’Ambiente all’Università di Padova (La tutela dell’ambiente tra imperativo giuridico e prassi).