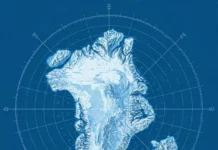Se non proprio malevola, almeno superficiale. Così almeno mi era apparsa la semplificazione mediatica con cui si proiettava lo spettro jihadista sull’ultima – per ora – ribellione tuareg. Arrivando a sostenere che certe etnie del Mali non potevano essere altro che “vittime o complici dell’islamismo più feroce”. Tertium non datur.
In realtà credo che la questione sia più complessa. Si doveva quantomeno precisare quale fosse – e quale sostanzialmente sia – la condizione in cui versano i tuareg: quella di una “nazione senza Stato” che vive, si sposta e se del caso combatte ben oltre i ristretti confini del Mali. Per inciso, appare evidente l’analogia con la nazione curda, ugualmente frantumata da vari confini statali, più o meno artificiosi, a seguito dei ben noti processi di “decolonizzazione controllata” del secolo scorso.
Invece si è cercato di interpretare la diffusione, il dilagare dell’islamismo radicale come effetto collaterale del “rientro” (in realtà una dispersione) delle “milizie nomadi” (in parte costituite da combattenti tuareg) già “alleate del beduino Gheddafi”. Senza interrogarsi in merito alle ragioni che avevano spinto molti tuareg, legati o meno al MNLA (Movimento Nazionale di Liberazione dell’Azawad) in Libia.
Alla fine del ‘900 le lotte per l’indipendenza (o almeno per l’autonomia, il decentramento) e gli scontri armati tra le milizie tuareg e gli eserciti di Mali e Niger risultarono deleteri soprattutto per le popolazioni civili, oggetto di repressione e brutali massacri. Come per esempio nel 1990 a Tchin Tabaraden in Niger.
E forse non è un caso che anche attualmente nel Niger permangano gruppi armati che lottano per l’autodeterminazione. Tra questi il MNJ (Mouvement des Nigériens pour la justice). Oltre alla liberazione dei prigionieri politici tuareg e alla possibilità di svolgere liberamente attività politica, il MNJ esige dal governo di Niamey la fine dello sfruttamento coloniale dei territori abitati dai tuareg (vedi le miniere di uranio, devastanti per la salute della gente, in mano alle multinazionali straniere come la francese Areva).
Altra organizzazione armata in parte ancora operativa (o almeno fino al primo decennio del XXI secolo) il Front des forces de redressement. Avrebbe (meglio il condizionale in attesa di conferme) invece deposto definitivamente le armi il Front patriotique nigèrien.
Comunque, tornando alla caduta di Gheddafi, all’epoca buona parte dei tuareg prese la via del ritorno. Talvolta portandosi appresso una discreta quantità di armamenti sofisticati. Salvo poi, magari incautamente, venderli a gruppi jihadisti ben riforniti di petrodollari. Peggio ancora: qualche ex esponente del MNLA (vedi Iyad Ag Ghali) si era avvicinato da tempo alle milizie jihadiste, anche in contrapposizione con gli ex compagni di lotta. Più che una conversione religiosa, la vedrei come il risultato di personalismi, concorrenze e faide interne.

Risaliva al 6 aprile 2012 la dichiarazione unilaterale di indipendenza dell’Azawad che di fatto aveva temporaneamente spaccato il Mali in due. Ma dopo nemmeno venti giorni – forse per inesperienza, stupidità o sotto minaccia come nei matrimoni forzati – alcuni referenti del MNLA presenti sul campo firmavano un accordo capestro con Ansar Al-Din, gruppo islamista finanziato da Al Qaida nel Maghreb islamico. Con la velleitaria creazione di un “Consiglio transitorio dello Stato islamico dell’Azawad” formato da 40 membri, 20 del MNLA e 20 di Ansar Al-Din.
Risvolto grave, l’applicazione della sharia e la costituzione della polizia islamica (hisba).
A sua parziale giustificazione Bilal Ag Sherif, segretario del MNLA e firmatario dell’accordo, sosteneva di aver agito per evitare una guerra interna tra tuareg e convincere i fratelli integrati in Ansar Al-Din ad abbandonarne i ranghi. Un accordo che era lecito definire una “mostruosità” e appunto come tale veniva sconfessato dal coordinamento dei responsabili del MNLA.
Il portavoce del MNLA Habaye Ag Mohamed riteneva “inconciliabile con la linea politica del MNLA l’atteggiamento fondamentalista e in particolare il jihadismo salafita portato avanti da Ansar Al-Din”.
Bilal Ag Sherif, firmatario del documento, veniva richiamato all’ordine e costretto a rompere tale accordo. Per Nina Valet Intalou, esponente dell’Ufficio esecutivo del MNLA, bisognava “rigettare categoricamente questo accordo, perché cercare di evitare una guerra fratricida non significa accettare il diktat imposto da gruppi oscurantisti”.
Il documento, spiegava, “era stato firmato pensando che i nostri fratelli tuareg schierati con Ansar Al-Din avrebbero lasciato questa organizzazione terroristica. Avremmo potuto accettare uno Stato islamico democratico, pensando che noi siamo già musulmani. Ma il documento proposto da Iyad Ag Ghali è veramente contrario agli obiettivi del MNLA e alla nostra cultura. Quello che lui vorrebbe è uno Stato talebano”.
Ovviamente nel 2012 il confronto veniva spontaneo con i talebani. Oggi probabilmente si evocherebbe lo spettro dell’ISIS.
A conferma dell’estraneità tra il movimento per l’autodeterminazione tuareg e l’integralismo islamista, già il 5 e il 6 giugno 2012 centinaia di donne e di giovani della città di Kidal scendevano in strada per protestare contro i fondamentalisti. Successivamente, nella notte tra il 7 e l’8 giugno, si registravano scontri armati tra militanti di MNLA e di Ansar Al-Din.
Purtroppo la storia della lotta tuareg per l’autodeterminazione (sia indipendentista sia autonomista) è da sempre attraversata da scissioni e conflitti interni. Lo stesso leader di Ansar Al-Din, Iyad Ag Ghali, in precedenza si era distinto come promotore delle rivolte degli anni novanta del secolo scorso. Ma, almeno fino al 2012, le istanze dell’islamismo radicale non avevano – pare – trovato spazio significativo all’interno del movimento tuareg, da sempre sostanzialmente laico.
Successivamente, nel giro di qualche mese, il Nord del Mali finiva quasi completamente in mani jihadiste (oltre ad Ansar Al-Din, erano entrati in azione anche il Muiao e direttamente AQMI). Ma con la riunione internazionale di Bamako del 19 ottobre 2012 si avviava quel “progetto di intervento militare credibile” richiesto nella settimana precedente alla Comunità economica degli Stati dell’Africa dell’Ovest (CEDAO) e all’Unione Africana.
La Francia riusciva a coinvolgere i 15 Paesi membri del Consiglio di Sicurezza e porre la questione sotto il capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, in quanto la situazione del Paese africano costituiva “una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale”. Il resto è cosa nota. Prima l’intervento diretto dell’esercito francese (aviazione e forze speciali) per riprendere il controllo di Gao, Timbuctù, Kidal, Tessalit, con l’operazione Serval (dal nome di un felino africano) dal gennaio 2013 alla metà del 2014. Operativi da gennaio anche alcune centinaia di soldati africani (provenienti da Niger, Benin, Nigeria e Togo) della Missione internazionale di sostegno al Mali (MISMA). Poi – dopo la costituzione della missione onusiana MINISMA (Mission Multidimensionelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali) e una serie di operazioni dai nomi più o meno pittoreschi (Dragon, Constrictor, Centaure, Epervier) – dall’agosto 2014 l’intervento contro le bande salafite assumeva la veste di un dispositivo regionale con l’operazione Barkhane (dal nome di una duna migrante nel deserto) a cui partecipavano Mauritania, Burkina Faso, Ciad, Mali e Niger, comunque sottoposti alla direzione dell’Esagono.
Ma la guerra non si è fermata. Nemmeno dopo migliaia di morti e centinaia di migliaia di sfollati. Un tragico bilancio a cui si deve aggiungere la denuncia di sistematiche violazioni dei diritti umani. Opera soprattutto di soldati africani nei confronti di civili arabi e tuareg, sbrigativamente – e comodamente – identificati come salafiti.
Nel frattempo ha visto la luce anche Takouba (“spada di legno”, quella dell’Onore, in tamashek, la lingua dei tuareg), denominazione per le forze speciali europee che dovrebbero sostenere le truppe maliane nella lotta contro il terrorismo jihadista. Stando alle dichiarazioni della ministra della difesa francese Florence Parly, Takouba era già stata preannunciata da Macron in occasione dell’incontro di Pau, quello indetto proprio per tacitare le voci sul dissenso africano all’intervento francese.
Quanto al governo di Bamako, va riconosciuto che fin dal 2012, in prossimità dei territori occupati dalle milizie jihadiste, venivano allestiti alcuni campi di addestramento. Tuttavia, vuoi per mancanza di mezzi, vuoi per imperizia, risultavano alquanto scadenti. Con i volontari alloggiati in strutture provvisorie, senza armi e addirittura scarsamente riforniti di generi alimentari (letteralmente “alla fame” secondo alcuni visitatori, nemmeno in grado di compiere l’addestramento). Com’era prevedibile, molti disertarono per raggiungere Ansar Al-Din e il Mujao (Movimento unicità e jihad nell’Africa dell’Ovest). Organizzazioni ben finanziate, in grado di garantire “assistenza economica alle famiglie di ogni combattente vivo o morto e un’abitazione fino al momento in cui i figli saranno in grado di sposarsi”.
Un copione che si va ripetendo su larga scala anche in questi giorni.

Contraddizioni in seno ai popoli
Un bel casino, certamente. Senza dimenticare che oltre ai durevoli, tenaci contenziosi tra popolazioni indigene e governi statali, ne permangono altri non meno devastanti tra le popolazioni stesse. Troppo spesso strumentalizzati dai governi (e anche in questo Gheddafi aveva fatto scuola) in nome del sempre attuale divide et impera. Come quello tra tuareg e tebu (il “popolo delle rocce”) chiamati ikaraden dai Tuareg.
Un breve riepilogo.
Nei suoi 40 anni di permanenza al potere, Gheddafi aveva abilmente alimentato le reciproche ostilità tra le tribù arabe e alcune “minoranze” (in realtà popolazioni minorizzate in quanto separate dai confini statali, come avviene per i curdi o anche i baschi) presenti nel sud della Libia: tebu e tuareg. Utilizzando gli scontri interetnici per controllare, discriminare, emarginare e reprimere. E sfruttando i tuareg, in particolare nelle zone di frontiera, per far pressione su Algeria, Niger e Mali.
Dopo il 2011, con la caduta del regime, esplodevano le istanze di maggior autonomia politica da parte dei tebu per il controllo delle zone petrolifere e aurifere e delle vie di comunicazione. In particolare dei check point utilizzati per sfruttare proficuamente i vari traffici legali e illegali (armi, medicinali, derrate alimentari, droga, alcolici e anche esseri umani).
Mentre la Libia sprofondava nel conflitto, in questo decennio i tebu si sono imposti, talvolta anche violentemente, alle altre tribù (sia arabe sia tuareg, se pur in diversa misura e in maniera differenziata) per trarre benefico dalla nuova situazione generatasi con la caduta ingloriosa del Colonnello. Nei territori meridionali della Libia, lì dove coabitano le varie etnie, sono presenti in grande quantità non solo l’ambita risorsa petrolifera, ma anche minerali rari e persino l’acqua per la presenza di vaste falde freatiche. Acqua di cui usufruiscono le popolazioni (il 90% dei libici) che vivono nel nord del Paese.
Non si deve comunque generalizzare. Occorre valutare la complessità delle relazioni che si vanno instaurando di volta in volta, di luogo in luogo. Relazioni, si diceva, varie e variabili sia politicamente sia economicamente. Per esempio nel contenzioso per il controllo delle risorse tra tebu e tuareg nel Fezzan (sud-ovest del Paese), per un certo periodo sembrava prevalere l’aspetto militare, lo scontro armato. In passato, in quanto minoranze non arabe, i tebu come i tuareg avevano subìto evidenti discriminazioni (entrambi manipolati in funzione della politica “panafricana” di Gheddafi), ma in diversa misura.

Così, mentre migliaia di tuareg e di tebu si ritrovavano sostanzialmente nella medesima condizione di apolidi, per i primi esisteva la possibilità di integrarsi vantaggiosamente nel sistema della sicurezza interna. Godendo quindi della possibilità di armarsi adeguatamente e di facilitazioni in campo economico (permessi di lavoro, accesso all’amministrazione, eccetera). Del resto Gheddafi si presentava talvolta come un “garante”, un “sostegno”, un protettore anche dei tuareg del Mali e del Niger. Perfino nei confronti dei loro governi dai quali effettivamente subivano discriminazioni e repressione.
Questo può spiegare la posizione assunta nel 2011 dai tuareg libici (a cui si aggregarono molti altri provenienti da Mali e Niger) che si schierarono con il regime. Una scelta che in seguito avrebbero pagato duramente.
Ad aggravare ulteriormente il conflitto tra le due etnie, la chiusura nel 2014 della frontiera tra Libia e Algeria fino ad allora vantaggiosamente controllata dai tuareg. Di colpo questi si scoprivano privati di una preziosa fonte di reddito in quanto flussi commerciali, traffici e contrabbando venivano dirottati sulla frontiera con il Niger, tradizionalmente controllata dai tebu. L’altra frontiera del sud della Libia, quella con il Ciad, dal 2013 è interessata da un imponente traffico di oro estratto, spesso artigianalmente, dalle miniere del Fezzan. Anche questo un traffico gestito principalmente dai tebu.
La scelta infelice di una parte dei tuareg (ormai in difficoltà anche sul piano sanitario) di allearsi militarmente con elementi integralisti forniva ai tebu l’occasione per tacciarli di “terrorismo”, assimilandoli ai salafiti, e di presentarsi all’opinione pubblica internazionale come garanti della lotta al medesimo nel sud della Libia. Così per esempio vennero interpretati gli scontri sanguinosi, con decine di vittime, del settembre 2014 a Ubari (storicamente feudo tuareg del Fezzan, ma con una forte presenza tebu) tra milizie tebu e tuareg. Scontri scoppiati inizialmente non certo per questioni ideologiche o religiose, ma semplicemente per il controllo dei check point e di una stazione di servizio (oltre che, beninteso, dei cospicui giacimenti petroliferi della zona).
Per la cronaca. In un primo momento i tuareg ebbero la meglio, ma successivamente, nel 2019, persero nuovamente il controllo dei giacimenti, stavolta per mano dell’Esercito Nazionale Libico (ANL). In questa circostanza le milizie tuareg e tebu si “riconciliarono” e costituirono un fronte comune per combattere contro l’esercito del generale Haftar.
Ennesimo paradosso del conflitto libico, talvolta benevolmente definito un ginepraio, ma più spesso un “autentico pantano”? Forse non proprio se pensiamo all’accordo di pace faticosamente conseguito e sottoscritto dalle due comunità nel 2015.