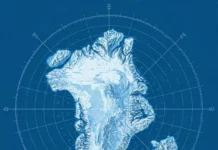Molte lingue non ufficiali – cioè senza un governo e una flotta alle spalle – sono composte da svariate parlate locali. Ma è un falso problema. Basta unificare la grafia e incoraggiare l’intercomprensione tra le varianti, e poi si potrà benissimo insegnarle a scuola. Ma qualcuno non è d’accordo…
Sul “Corriere della Sera” (6 maggio 1981) Gavino Ledda ha aperto il dibattito sulla legge regionale sarda che istituisce il bilinguismo, ed ha velenosamente attaccato l’iniziativa che, invece, costituisce per noi, da trent’anni non rassegnati militanti della causa per le lingue e le culture minacciate, un grande conforto. Soltanto alcuni anni fa, era utopico sperare che l’amministrazione regionale si aprisse al “dialetto” (ché il Sardo tale era considerato).
Con la Sardegna si è mossa anche la Sicilia dove una recente legge regionale istituisce corsi di Siciliano (e di Albanese e parlari gallo–italici nelle rispettive aree) nelle scuole. Ciò inferocisce tutti coloro che si sono schierati con il Palazzo (eleganti lacchè in livrea rossa, pronti a camminare rispettosamente indietro per non voltare le terga al potere: gamber ross sono, infatti, chiamati in piemontese siffatti valletti incaricati di servire su piatti dorati le lingue in salsa agli eccellentissimi glottologi) ed i ricercatori accademici cui servono non soggetti creativi di cultura ma manichini da museo docili ed immobili oggetti dei loro studi.
Naturalmente, equiparare il Siciliano al Sardo (una delle 12 lingue tagliate dell’elenco “ufficiale”: ma perché non dovrebbero essere i mutilati a decidere se la propria lingua è mozza o meno?) urta la suscettibilità di chi preferisce stare al riparo dei propri schemi nazionalitari, rifiutando il discorso della riappropriazione dell’identità etnica.
Già il Còrso (ritenuto “dialetto” italiano contro il sacrosanto diritto dei Còrsi di elevare la loro parlata a dignità di lingua) li aveva messi in crisi. Ed ora ci si mette anche la Sicilia! Ed ecco la ricorrente obiezione: ma quale Sardo? Quale Siciliano sarà “lingua”, posto che non esiste una lingua, ma “dialetti” che mutano da città a città, da borgata a borgata, da persona a persona? Essere o non essere lingua? Ci si dimentica che la stessa domanda potrebbe porsi per tutte le lingue bandite dai Palazzi e condannate, come Cenerentola, a morte di focolare. Infatti: quale Catalano, Basco, Gaelico, Frisone, Occitano, Ladino e, perché no, quale Kurdo, Quechua, Aymarà…?
Soltanto le lingue dei colonizzatori e del potere non hanno questo che, in realtà, è un falso problema. L’importante, infatti, dovrebbe essere alfabetizzare nella lingua materna, unificando la grafia ed incoraggiando l’intercomprensione tra le parlate locali, nel rispetto delle mille culture.
Eppure, il problema è stato risolto a livello ufficiale in Frisia, nel Galles, nell’Eire, in Catalogna, in Euskadi; in Perù pochi anni fa, si è decretato il bilinguismo ufficiale Castigliano-Quechua.
Alcune nazioni proibite hanno favorito una koiné (lingua comune) che si innesta sulle parlate locali, base dell’apprendimento scolare, come propongono ad esempio gli Occitani (unificazione della lingua scritta sul modello trobadorico, e lingua parlata su base linguadociana); altre codificano i vari dialetti locali, pur elevandoli a dignità di lingua: ed è la soluzione dei Retoromanci svizzeri, la cui lingua è “nazionale” per l’ordinamento giuridico federale, e “ufficiale” per quello cantonale; nei Grigioni, infatti, la scuola, l’amministrazione, le chiese usano regolarmente uno dei cinque dialetti: Sursilvano, Sutsilvano, Surmirano, Ladino dell’alta e della bassa Engadina.
La Confederazione utilizza ufficialmente, ad anni alterni, il Sursilvano o il Ladino engadinese, mentre la radio incoraggia il Surmirano il quale, benché parlato soltanto da 3000 persone, è comprensibile sia ai Renani dell’Oberland che agli Engadinesi. Perché, allora, quanto è possibile nel Cantone dei Grigioni per meno di 50.000 Retoromanci, non dovrebbe esserlo in Sardegna, per un milione e mezzo di Sardi?
Infatti, se il Sardo presenta alcune varietà locali (Campidanese, Logudoresa, Gallurese, Sassarese) come il Retoromancio, quanto quest’ultimo (ed il Catalano, Basco, ecc.) presenta un’unità linguistica indubbia che assomma un numero di caratteristiche distintive (cfr.Max Leopold Wagner. La lingua sarda, Berna Francke 1950); prescindendo, ovviamente, dalle minoranze catalana (Alghero) e tabarchina (Carloforte e Calasetta). Per il Sardo e per il Siciliano (come già per il Friulano, il Piemontese, il Veneto, ecc.) qualcuno eccepisce il pretestuoso argomento per cui i dialetti si dovrebbero parlare e non insegnare, ribadendo così una distinzione quale quella della falsa coppia teorica lingua/dialetto, che scientificamente non ha alcun fondamento avendolo, invece, su un piano meramente politico. Forse che l’Olandese dei Paesi bassi non appartiene al Basso Tedesco, e non è diviso in dialetti come lo è il Plattdeutsch in Germania? Eppure in Olanda quella parlata, e non il tedesco, è lingua nazionale, mentre nella Repubblica Federale Tedesca è umilissimo dialetto.
Invece di una pelosa preoccupazione per la “Scuola che uccide” il compatito dialetto, non sarebbe meglio denunciare la Scuola ingiusta e crudele, qual è quella italiana, che pur pretendendosi democratica continua ad offendere nel profondo dell’animo le classi popolari, perché ribadisce il pregiudizio del dialetto come segno di arretratezza culturale e di povertà sociale; e degrada la parlata da valore di lingua romanza (quali sotto appunto il Sardo ed il Siciliano, tutti, a ben guardare dialetti del latino come l’italiano) a minusvalore di dialetto, confinandola così nel ghetto del vernacolo (buono per pascolare le pecore o i porci, e per le poesie d’occasione).
Avvenuta questa degradazione, l’esproprio è molto più semplice, come nel baratto in cui l’antiquario si porta via la madia di noce, e chi vende ne ricava un tavolo di plastica. L’uso capitalistico della lingua si realizza appieno, ed il “dialettofono” creatore di cultura alternativa diventa consumatore di una cultura omogeneizzata, premasticata, congeniale al sistema consumistico del capitalismo maturo.
Certo, rimangono comunque gli Istituti universitari (quelli, per esempio, di linguistica sarda) quali unici abilitati a trascrivere (ma non certo a creare) la lingua della povera gente, che mai potrà apprenderla nelle Scuole dove le dovrebbe rimanere proibita… per amore di patria e matria, perché “l’abbraccio con l’istituzione scolastica sarebbe mortale”, perché “l’italiano è quello che conta”, perché “la parlata locale è una sovrastruttura aderente ad una società preindustriale obsoleta” (come se la lingua della Bibbia non fosse divenuta quella di uno stato modernissimo) ed altre tristezze pretestuose del genere.
Ma, di grazia, perché non dovrebbe esser consentito al bambino sardo o siciliano (o piemontese, lombardo, veneto…) di poter esprimere i propri pensieri, ANCHE PER ISCRITTO, nel volgar’eloquio, e cioè nella lingua della famiglia, del lavoro, dell’amicizia? D’accordo, occorre imparare l’italiano, l’inglese, il francese, il tedesco e quante altre lingue del padrone è necessario; ma occorre anche promuovere la cultura originaria, la riappropriazione dell’identità culturale, rivendicare la dignità della lingua che l’esprime, favorire quanto può essere lievito di autonomia, premessa di autogestione culturale, antidoto all’alienazione, momento di “lotta contro quel nuovo fascismo che è l’accentramento linguistico italiano”, come disse Pasolini nel suo ultimo pubblico intervento. Nessun ostacolo verrà alla conoscenza dell’Italiano e delle altre lingue di Palazzo: l’esempio dei Retoromanci è ancora lì per ricordarcelo, perché essi sanno scrivere la propria “piccola” lingua ed imparano molto bene il tedesco e l’italiano.
Padrone sia Gavino Ledda di non voler scrivere in Sardo; ma non di pretendere paternalisticamente che i suoi gusti (e retrogusti amari, giusta penitenza per un glottofago) diventino quelli di un popolo che non deve più servire gli interessi economici e culturali della metropoli.