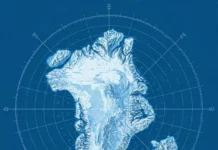“Frontiera”: nozione artificiosa, non definibile in termini oggettivi, perennemente mobile, come la storia ci ha sempre dimostrato, mai “naturale”. Soprattutto, mai linea di divisione culturale e linguistica… fino a quando gli Stati burocratici e centralisti, per una deliberata scelta politica basata su puri rapporti di forza, non hanno deciso di conseguire compattezza e potenza anche attraverso l’opposizione, artatamente costruita, di popoli che non si erano mai sentiti né separati né diversi. Sulle Alpi possiamo verificare tutto ciò in modo emblematico: da ovest a est, il “confine” non riesce a spezzare, e non potrà mai farlo, ciò che la storia dei popoli ha irrevocabilmente intrecciato. E ciò nonostante l’intolleranza e lo spirito di prevaricazione di chi continua a escogitare ogni possibile pressione per ottenere l’assimilazione e l’omogeneizzazione, incurante del fatto che la sola possibile Europa di domani sarà, finalmente, quella “dei popoli”.
La frontiera è, essenzialmente, una linea che separa due Stati, retti da leggi e da amministrazioni differenti al punto che, al di là e al di qua di detta linea, si esercitano delle tensioni, percepite nettamente, anche se in modo differente, da coloro che la superano. Da una parte e dall’altra della linea esiste una zona, più o meno estesa, i cui abitanti, per ragioni geografiche, economiche e sociali, sono particolarmente condizionati dalla presenza delle frontiere. Ed è proprio questa zona, lungo le frontiere alpine, l’oggetto di questa riflessione. L’“effetto frontiera” si manifesta sotto forma diversa a seconda dell’organizzazione degli Stati in contatto e le loro relazioni politiche, a seconda della storia, dell’economia o della cultura delle popolazioni della zona di confine e a seconda delle caratteristiche geografiche.
Comunque, la linea di frontiera presenta sempre un grado di permeabilità più o meno elevato che permette gli scambi fra le popolazioni. Il grado di permeabilità ha subìto delle variazioni nel tempo, e cosi pure la nozione stessa di frontiera.
Durante il Rinascimento, e sicuramente anche prima, l’idea di frontiera non era particolarmente legata all’idea di cambiamento linguistico. Sul piano politico, le rivendicazioni territoriali basate sull’identità linguistica praticamente non sono attestate e quelle talvolta citate, per altro rare, sono dubbie. L’equazione “una lingua = uno Stato” è, dunque, relativamente recente. In definitiva, la funzione della frontiera è quella che gli Stati interessati le accordano ed evolve in parallelo con gli Stati stessi: non era una linea di divisione linguistica e culturale, ma lo è divenuta quando l’ideologia dominante degli Stati l’ha voluto, quando l’uniformazione culturale e linguistica è diventata una scelta deliberata dalla maggior parte degli Stati.
La frontiera non è una linea fissa e intangibile, come si tende a far credere: la storia, anche recente, ci dimostra come l’instabilità delle frontiere sia un dato costante. E questi cambiamenti hanno segnato, più o meno profondamente, a seconda delle epoche e dei luoghi, il tessuto linguistico e culturale delle zone interessate. Non essendo fisse, le frontiere non sono nemmeno definibili in termini oggettivi: tutte le frontiere sono artificiali, in quanto prodotto di decisioni umane. L’espressione “frontiera naturale” è senza senso poiché i fiumi, i mari, i deserti e le montagne non dividono i popoli come una certa letteratura vuol far credere, ma tendono piuttosto a unirli. Sono gli Stati che, nel loro sforzo di uniformazione, utilizzano, a posteriori, gli accidenti naturali per giustificare i loro limiti territoriali e cercano di creare al loro interno una “coscienza nazionale” fondata sull’opposizione di popolazioni che non si sono mai sentite separate da fiumi, mari, deserti o montagne.
Sulle Alpi, ancora al giorno d’oggi, in pratica non esiste coincidenza tra frontiera linguistica e frontiera politica. Da ovest a est, incontriamo parlate galloromanze sui due versanti delle Alpi occidentali, parlate germaniche a sud delle Alpi Pennine (Walser), isole romanze anteriori alla germanizzazione delle Alpi centrali e orientali (Romanci, Ladini e Friulani) sui due versanti, parlate germaniche a sud e a nord del Brennero, italiani e sloveni a est e a ovest delle Alpi Giulie, dove la catena si abbassa e le comunicazioni sono particolarmente agevoli.
Le frontiere alpine, che tagliano gruppi linguistici omogenei, non coincidono nemmeno sempre con le pretese “frontiere naturali” poiché, in più casi, non seguono rigorosamente la linea di spartiacque. Le frontiere sulle Alpi non sono dunque né linguistiche, né culturali, né tantomeno “naturali”: sono, come tutte le frontiere, di origine politica. Sono linee tracciate da Stati, il più sovente a conclusione di un conflitto, espressione della volontà degli Stati interessati e del rapporto di forze esistenti al momento dello scorporo.
Le parlate autoctone ancora ben vive sulle Alpi hanno radici profonde. Quelle romanze sono la risultante dell’evoluzione del latino parlato in loco, impregnato di un sostrato pre-latino e arricchito da contributi posteriori. conseguenza di contatti con le popolazioni che, periodicamente, la storia ha spinto verso le Alpi. Il tedesco, nelle sue varietà alemanniche e bajuvare, cosi come le parlate slave, sono il risultato dell’emigrazione di popolazioni che, stabilitesi attorno all’anno 1000 sui loro territori attuali, in virtù del numero o della loro posizione egemonica nella società, hanno progressivamente assorbito le popolazioni romanze e preesistenti. Eccezione fatta per il ladino e per il romancio, le lingue parlate sulle Alpi non sono specifiche delle popolazioni alpine: il provenzale alpino non rappresenta che la frangia orientale di un vasto dominio che dalle Alpi meridionali va sino all’Atlantico, il francoprovenzale era parlato a Lyon e a St Eticnne, il tedesco raggiunge il Mare del Nord, il friulano p parlato fin sulle coste adriatiche, lo sloveno nelle pianure dell’alta valle della Sava, il croato interessa solo marginalmente la regione alpina. Dal punto di vista linguistico, le popolazioni alpine non sono dunque che una parte di insiemi più vasti e geograficamente eterogenei.
Comunque, sulle Alpi la parlata autoctona è sempre una variante locale, un dialetto se vogliamo, che si adatta perfettamente all’ambiente. Questo loro carattere dialettale rende le parlate alpine particolarmente permeabili e instabili. Essenzialmente orali, non normalizzate o tardivamente normalizzate, senza tradizione scritta o con tradizione scritta recente e poco generalizzata, queste parlate sono molto ricettive di fronte alle innovazioni linguistiche conseguenti ai cambiamenti socioeconomici e politici. Soprattutto nelle loro frange estreme, i vari gruppi hanno subìto dei cambiamenti linguistici profondi, talvolta addirittura una sostituzione linguistica, già in epoche remote: XVII e XVIII secolo. Ma il vero momento di crisi delle parlate locali alpine coincide con l’affermazione delle lingue ufficiali all’interno degli Stati.
Le lingue ufficiali sono nate come tali con l’abbandono del latino da parte dell’amministrazione (tra il XIV e il XVI secolo) e l’hanno progressivamente sostituito in tutte le sue funzioni. Naturalmente esse esistevano già prima: la produzione letteraria antecedente ne é una prova, ma erano psicologicamente e praticamente subordinate alla lingua classica e, non essendo ancora normalizzate, erano un referente incerto, non in grado di opporsi al rigore del latino. L’assenza di una norma linguistica ben definita, norma che s’affermava progressivamente nel corso dei secoli, garantiva una certa libertà linguistica poiché le frontiere tra dialetti e lingua ufficiale erano abbastanza vaghi. Il lessico, le strutture grammaticali e sintattiche dialettali infiorano regolarmente i testi in lingua fin verso la fine del XVIII secolo, senza peraltro ingenerare reazioni da parte dei puristi.
Il conflitto, quando c’è stato, tra lingua ufficiale e parlate locali della stessa famiglia è tipico degli ultimi due secoli, quando, per i cambiamenti profondi a livello socioeconomico e la generalizzazione dell’insegnamento scolastico, i dialetti hanno assunto una posizione subalterna. La regressione dei dialetti nei confronti della lingua ufficiale non è stata uniforme: sulle Alpi esistono zone dove essi sono ancora perfettamente conservati e altre da dove sono spariti da tempo. In linea di massima i dialetti romanzi sono quelli la cui situazione è più compromessa, mentre quelli di origine germanica sono meglio conservati, eccezion fatta per le isole linguistiche (Walser, Mocheni, i 7 Comuni d’Asiago, i 13 di Verona). Anche all’interno di aree linguistiche omogenee la situazione è variegata: in Valle d’Aosta il francoprovenzale è meglio conservato che nella Svizzera Romanda, in Francia e in Piemonte.
Le Alpi stanno dunque attraversando un momento di trasformazione linguistica profonda. Il declino della parlata autoctona rappresenta un impoverimento drammatico del patrimonio linguistico universale. E se, quando la parlata è una variante della lingua ufficiale, il declino avviene senza conflitti profondi, quando la parlata autoctona si riconosce in una lingua, altra da quella dello Stato, assistiamo al dramma delle comunità nazionali autoctone “minorizzate”. Sulle Alpi, dette comunità sono numerose, soprattutto sul versante italiano. Ma se ritroviamo, su due versanti, popolazioni con gli stessi tratti linguistici e culturali, significa che esse hanno avuto un passato comunitario. Esse, infatti, non sono sempre state in un rapporto minoritario con lo Stato di appartenenza.
Da quando si trovano in un rapporto minoritario? Ogni comunità ha una sua storia. Le comunità galloromanze delle Alpi occidentali hanno fatto parte, per la loro quasi totalità, fino al 1861, degli Stati sabaudi, regno biculturale a cavallo delle Alpi con due lingue ufficiali: il francese e l’italiano. Il francese era lingua ufficiale per la Savoia, la Valle d’Aosta e le valli valdesi del Piemonte. Esso, seppur numericamente minoritario all’interno dello Stato, godeva tuttavia di un più grande prestigio culturale rispetto all’italiano.
Le comunità occitane, sotto la legalità sabauda o francese, non hanno mai visto riconosciute le loro prerogative linguistiche.
I francoprovenzali del Piemonte, dopo l’abbandono del latino, hanno utilizzato l’italiano come lingua di cultura, mentre i valdostani, il francese.
I walser del versante alpino meridionale facevano anch’essi parte degli Stati sabaudi e la loro parlata non è mai stata oggetto di attenzioni particolari. Comunque, a Gressoney, il tedesco era lingua del culto e dell’amministrazione, mentre a Issime lo era il francese.
Il Tirolo meridionale, con la sua popolazione germanica e ladina, è entrato a far parte dello Stato italiano dopo la prima guerra mondiale. Il Friuli, alla fine del dominio veneziano, è stato smembrato: una parte all’Austria e una alla Francia napoleonica. Con il Congresso di Vienna passa sotto l’Austria, dopo la III guerra per l’indipendenza italiana (1866) la parte centrale e occidentale è attribuita all’Italia, e solo con la prima guerra mondiale ritroverà la sua unità sotto la legalità italiana.
Gli Sloveni delle Alpi Giulie, dove le frontiere hanno subìto frequenti correzioni nel corso dell’ultimo secolo, sono il residuo di una comunità molto più numerosa nel periodo tra le due guerre mondiali. La frontiera attuale, pur riducendo la consistenza numerica degli Sloveni in Italia, ha creato dei gruppi italiani minoritari in Jugoslavia.
Tutte queste comunità, divenute minoritarie, hanno subìto sul piano linguistico e culturale delle pressioni finalizzate alla loro assimilazione al gruppo maggioritario. L’efficacia delle pressioni va messa in relazione con la struttura dello Stato, più o meno centralizzatore, e con la consistenza e compattezza delle comunità. Gli Stati centralizzati hanno fatto sentire più o meno pesantemente la loro azione secondo le epoche, la loro organizzazione e le filosofie ispiratrici dei governanti. Se l’impero austroungarico era relativamente tollerante sul piano linguistico, non si può certamente dire altrettanto dell’Italia risorgimentale o della Francia giacobina. L’azione gallofoba, condotta contro la Valle d’Aosta e le valli francofone del Piemonte all’indomani stesso della proclamazione del Regno d’Italia, sono sintomo d’uno spirito d’intolleranza, in chiaro contrasto con gli ideali che hanno guidato l’Italia nella sua lotta per l’indipendenza.
Questa volontà di assimilazione forzata nei confronti degli alloglotti toccherà il suo apogeo nel periodo fascista, quando la persecuzione linguistica assume aspetti brutali e nel contempo ridicoli. Tutti i canali possibili sono utilizzati: la scuola, l’amministrazione, la stampa, l’intimidazione personale, la discriminazione sul lavoro… Le comunità linguistiche minoritarie delle Alpi hanno conosciuto, e conoscono tuttora, una serie di problemi socioeconomici comuni che indeboliscono il loro tessuto linguistico. Il loro territorio è spesso economicamente sottosviluppato o, comunque, il suo sviluppo non è armonico: accanto a centri dove l’opulenza, dovuta al turismo, sembra regnare, ce ne sono altri, la maggioranza, che languono. L’agricoltura di montagna, risorsa tradizionale degli autoctoni, è in crisi e provoca l’abbandono della montagna e il flusso progressivo dei contadini verso i centri del fondovalle ove, spesso, la componente etnica autoctona ò minoritaria (l’emigrazione è una piaga comune, ma nel Tirolo del Sud e in Valle d’Aosta registriamo pure due fenomeni, apparentemente in contraddizione: gli autoctoni sono emigrati verso Paesi linguisticamente affini e sono stati sostituiti sul territorio da immigrati italici).
Questi fenomeni, in parte legati a fattori oggettivi, sono comunque conseguenza di scelte politiche, poiché constatiamo che le loro conseguenze sono meno acute dove le comunità minoritarie fruiscono di una maggiore autonomia politico-amministrativa, come nel Sudtirolo e, in minor misura, in Valle d’Aosta. Tutte queste comunità, unilingui (o quasi) qualche generazione fa, sono attualmente bilingui o plurilingui quando le lingue letterarie si accompagnano a dialetti ancora vivi. Quando si dice plurilinguismo non si deve pensare che i parlanti abbiano una uguale competenza nelle diverse parlate: conoscono meglio quelle che utilizzano più spesso, e non è sempre la lingua materna quella che praticano meglio e più sovente.
Sul piano individuale, il plurilinguismo costituisce senza dubbio un arricchimento, ma per le comunità minoritarie rappresenta una “debolezza”. Tutte, chi più chi meno, hanno perduto la loro omogeneità linguistica, e il multilingue autoctono è naturalmente portato ad adattarsi alle esigenze linguistiche del monolingue immigrato, che perde cosi uno stimolo importante per imparare la parlata autoctona. Il plurilinguismo generalizzato di una popolazione è, in sostanza, un momento di transizione sul cammino che va verso l’alienazione linguistica.
Un altro problema che pregiudica lo sviluppo delle parlate alpine è quello della koiné linguistica, che ha una funzione stabilizzatrice capitale. La questione della koiné occitana è ancora oggetto di dibattiti; i romanci ne hanno adottate cinque, i ladini l’hanno concordata recentemente e in Friuli è la varietà di Udine che tende ad affermarsi, non senza polemiche. Per i sudtirolesi, i valdostani e gli sloveni il problema non sussiste in quanto le tre comunità si riconoscono in lingue letterarie affermate: il tedesco, il francese e lo sloveno.
Ma tutte queste comunità hanno anche un altro problema, più generale ma ugualmente importante: la salvaguardia delle varietà dialettali locali. Un membro di una di queste comunità dovrebbe avere la conoscenza attiva della sua lingua, del dialetto locale e della lingua dello Stato: situazione linguistica che, attualmente, non può essere definita normale! Allo stato attuale, senza alcuna protezione giuridica adeguata, le comunità alpine hanno scarse possibilità di conservare la loro lingua.
Il panorama giuridico è molto variegato a seconda degli Stati di appartenenza e anche all’interno dello stesso Stato il trattamento per le varie comunità non è uniforme. In linea di massima, le comunità nazionali minoritarie appartenenti a Stati federali, come la Svizzera e la Yugoslavia, godono di una salvaguardia più efficace. In Svizzera, la composizione plurietnica dello Stato, la presenza di quattro lingue riconosciute ufficialmente, l’organizzazione cantonale, la stessa filosofia che è all’origine della Confederazione, garantiscono un sufficiente rispetto per le differenze. In Yugoslavia, le popolazioni italofone sono garantite dagli stessi accordi di Osimo che garantiscono gli Sloveni delle province di Trieste e di Gorizia. La Provincia di Bolzano è retta da uno statuto che riconosce la presenza sul territorio di tre gruppi linguistici (tedesco, italiano e ladino) che esercitano i loro diritti linguistici a tutti i livelli (o quasi) della vita civile. Lo statuto valdostano riconosce la parità di due lingue, francese e italiano, ma l’esistenza di due gruppi etnici sul territorio (tre gruppi se si tien conto dei walser) non è riconosciuta, generando una situazione di instabilità a tutto vantaggio dell’italiano.
Occitani, walser, isole germanofone e ladine non comprese nella provincia di Bolzano, sloveni di Udine, non godono di alcuna tutela da parte dello Stato e ciò che si fa, largamente insufficiente, è devoluto alla buona volontà delle amministrazioni locali o a quella di gruppi spontanei meritevoli. Per le comunità dello Stato italiano si attende una legge dello Stato di appli cazione dell’articolo 6 della Costituzione. Quest’intervento, con tutte le sue imperfezioni, rappresenterebbe un progresso nel senso della tutela, ma è ben lungi dal garantire la sopravvivenza delle lingue interessate. Anche a livello della Comunità Europea si lavora per la promozione delle lingue minoritarie. Attualmente, si parla molto del 1993 e dei risvolti economici susseguenti all’applicazione dell’Atto Unico. Ma nel 1993 ci saranno pure risvolti a livello culturale e linguistico? È possibile.
Cosa significherà l’abbattimento delle frontiere e la costituzione dell’Europa unita per le popolazioni alpine? Certo, tutto dipenderà dal tipo d’Europa che si formerà. Un’Europa risultato della somma degli Stati attuali non migliorerà certo la situazione, ma un’Europa federale, ridisegnata tenendo conto delle comunità naturali, con lingue e culture proprie, che garantisca a tutti i popoli le possibilità di autogestirsi, potrebbe rilanciare le comunità attualmente in crisi. Certo, la realizzazione di questo progetto non sarà per domani, ma le popolazioni alpine devono farsene portatrici. È forse questo il contributo più importante che possono dare per l’Europa di domani.