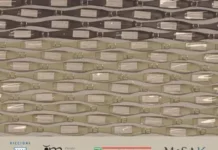Le modificazioni del concetto di regione dall’ “epopea” delle annessioni ai nostri giorni. L’eterna incompatibilità fra centralismo statalistico-burocratico e l’antica e mai sopita necessità di camminare con le proprie gambe. Come alla Costituente, in un clima di generale improvvisazione, vennero deluse le aspettative di una corretta divisione regionale, che tenesse conto delle singole realtà etno-linguistiche.
“L’Italia non la si voleva e non la si vuole dalle masse”. L’affermazione, obiettivamente tranchant, è del 1866; dunque non appartiene, come potrebbe parere, alla cronaca ma alla storia. A pronunciarla e a scriverla a chiare lettere, in una stagione probabilmente più vivace e “rissosa” di quanto si creda, Stefano Jacini, aristocratico proprietario terriero, di sentire moderato e formazione cattolica, figura di primissimo piano nel mondo politico-culturale dell’Italia postunitaria. Jacini, e con lui gran parte dei padani, guardava con perplessità venata di sfiducia ai modi che avevano presieduto alla formazione dello Stato unitario. Certo, non gli sfuggiva il valore di quell’approdo, necessario per collocare l’Italia a livello delle nazioni più evolute o, per dirla con l’espressione cara a quei tempi, per garantirle un posto nel “concerto europeo”… Ma le luci non erano sufficienti per giustificare le molte, moltissime ombre. In verità “l’epopea delle annessioni”, come veniva spesso definita la dinamica dell’unificazione, aveva soffocato ogni dibattito sul miglior assetto da darsi all’Italia indipendente. E c’erano in quel giudizio tutti i sentimenti e i risentimenti d’un mondo lombardo di fine cultura, di consumata esperienza amministrativa, d’antico e non gratuito scetticismo verso orientamenti non indigeni, dunque estranei al felice risultato storico indotto dall’innesto della lezione asburgica sul solido tronco del civismo lombardo.
Ora, invece, lo stile subalpino dettava legge. Ma si era poi certi che avesse vinto il migliore? Iniziava così a esprimersi, entro un serrato contrappunto polemico con la forma centralistica del nuovo Stato, quella difesa del valore delle particolarità locali e del loro diritto a una compiuta autorealizzazione che avrebbe connotato la cultura politica di matrice cattolica fino all’inserimento della voce “regione” nel testo costituzionale dell’Italia repubblicana. La passione per la vita locale (il genius loci, dicevano loro) e il disagio verso la forma-Stato, i cattolici se la portavano nel sangue insieme a una predilezione tenace per la civiltà medievale, fatta di maglie finemente intessute (la famiglia, la pieve, il municipio, le corpo- razioni di arti e mestieri,,.): un dispiegarsi di vita civile in cui ogni cellula aveva proprio dinamismo e propria voce. Al contrario lo Stato, con la sua logica accentratrice, con la sua etica di potenza, ma soprattutto con la profonda laicizzazione del costume che comportava storicamente il suo imporsi, non piaceva e non convinceva. Veniva di lì l’eterna, e a suo modo suggestiva, ambiguità dell’autonomismo di matrice cattolica, in difficile equilibrio fra antico e moderno, fra reazione e profezia. Moderna era in Jacini, per esempio, la consapevolezza dell’incompatibilità fra accentramento statale, gigantismo burocratico e bisogni di efficienza e produttività di uno Stato moderno. Lucida, e legata a una faticosa gestazione concettuale, era la ricerca di una democrazia non formale, dunque di una partecipazione politica che non fosse ritualismo svuotato di peso specifico ma espressione di una concreta dialettica di forze storiche. “Governare da lontano, amministrare da vicino”, amava ripetere il “gran lombardo”. Tuttavia a far ricadere il progetto sul suo versante antimoderno giocava una sorta di inibizione profonda a intendere e accettare la irreversibilità della rivoluzione industriale, allora incipiente, e dei dilaceranti effetti che avrebbe avuto sui tradizionali rapporti produttivi ed equilibri sociali. Era, quello, un autonomismo in larga misura nostalgico che, detto in termini psicanalitici, negava il moderno perché avvertiva, più o meno consapevolmente, che ne sarebbe stato emarginato. E così fu. La nuova Italia, con le sue ciminiere, le sue strade ferrate, il suo proletariato industriale, la sua inquieta realtà antropologica segnata da schiaccianti omologazioni, vinse. Per fortuna, secondo alcuni. Per disgrazia, secondo altri. Il dibattito in sede storiografica, ma non solo lì, è più che mai aperto. Quando col Partito popolare di Sturzo l’autonomismo cattolico tornò alla ribalta politica, lo fece in termini profondamente riveduti. Era il 1919 e fra il nostalgico “piccolo è bello” di jaciniana memoria e il regionalismo agguerrito del siciliano Sturzo c’era di mezzo il conflitto mondiale. Lasciata alle spalle ogni “mistica” municipale, il nuovo partito guardava al futuro e si nutriva d’un realistica conoscenza delle strutture sociali e produttive del paese. Forze d’ispirazione religiosa, ma di metodo politico laico, ponevano ormai il problema della successione alla vecchia classe dirigente, non più in termini della vecchia querelle filopapale di fine secolo, ma come proposta di un modello amministrativo meglio aderente alle caratteristiche di una società di massa.
Dunque, discorso postliberale, non antiliberale. La riforma dello Stato ne era il cuore: la lotta all’accentramento burocratico, ai torpori e agli inquinamenti di viete pratiche clientelari passava per di lì. Gli esempi della mobilitazione agraria e di quella civile durante la guerra stavano a dimostrare la improponibilità (e il rischio politico!) di continuare a regolare la vita nazionale col sistema delle formule livellatrici e centralistiche. In nome di una “libertà più liberale” Sturzo chiedeva la smobilitazione dello Stato. E da Milano Filippo Meda, “pezzo da novanta” dell’opinione lombarda, faceva eco e acconsentiva, carezzando quell’antico bisogno ambrosiano di camminare con le proprie gambe che a Roma non cessava di parere foriero di pericolose impennate autonomistiche… Il segretario politico del Partito popolare, che veniva, non a caso, da una lunga esperienza amministrativa, riusciva a leggere le trasformazioni della società senza paralizzanti attaccamenti alla scolastica cattolica ed era già proteso a disegnare un più ampio organismo sovramunicipale in grado di imprimere alle situazioni locali una direttiva di più ampio respiro. Covava l’idea di regione. Ma il governo centrale, nel travagliato triennio fra la fine della guerra e la marcia su Roma, aveva altro per la testa. Tutto un mondo era al tracollo con i suoi valori, il suo stile politico interno e internazionale. L’Italia risorgimentale era agli sgoccioli. Altro urgeva alle porte. E non era una stagione di libertà. Sturzo col suo progetto di autonomia regionale, ampiamente travalicante il mero decentramento amministrativo, marciava ormai controvento. Il progetto, nato e pensato come una sorta di legittima difesa della società civile rispetto alla società politica, doveva conoscere negli anni della dittatura la sua stagione più buia. Fu soffocato, non conculcato. Covò sotto la cenere, in attesa. Alcide De Gasperi, stendendo fra il 1942 e il ’43 le notissime Idee ricostruttive, le articolò intorno al tema della libertà politica come unico criterio in grado di assestare su basi meno friabili la rinata democrazia. Interrogandosi su come la società italiana avesse potuto conoscere una così rapida involuzione autoritaria, molte coscienze di differente ispirazione ideologica erano ormai concordi nel puntare il dito accusatore contro la forma centralistica dello Stato unitario. “La più efficace garanzia organica della libertà – scrisse De Gasperi – sarà data dalla costituzione della regione.” Una robusta e articolata vita locale appariva dunque il miglior antidoto contro la tirannide del Moloch statale. È con tale convinzione che i democratici cristiani si accinsero ai lavori della Costituente. Ma fu proprio allora che qualcosa, o molto, doveva cambiare. La sensazione che si ricava nel trapasso dalla fase preparatoria al biennio costituente 1946-47 è di una sensibile diversità di clima politico-culturale, destinata a condizionare profondamente l’identità progettuale e propositiva di ciascuna forza politica. Proprio l’itinerario del regionalismo (problematicamente segmentato in stasi e accelerazioni) risulta particolarmente espressivo di un progressivo imporsi della “ragion politica” rispetto a valutazioni di più ampio respiro culturale. Il catalizzatore del dibattito, come della finale decisione favorevole al nuovo ente, finiva col coincidere con il tipo di rapporto che ogni partito, ma in particolare la DC e il PCI, individuava fra opzione regionalista e personali esigenze di mantenimento ed espansione del consenso politico. Il progetto, in altre parole, fu ghermito dall’incipiente dialettica bipolare fra DC e sinistre e si mosse all’interno di una tattica simmetrica fin troppo eloquente. Il partito di De Gasperi ne difese l’iscrizione nel dettato costituzionale, ma ne rimandò la realizzazione a una stagione di minore virulenza comunista… Il PCI togliattiano inizialmente ne osteggiò l’accoglimento prevedendo una propria imminente occupazione delle leve centrali del potere; in seguito, sfumata tale prospettiva, si espresse favorevolmente per garantirsi attraverso il nuovo livello autonomistico aree di opposizione periferica. All’interno di tale dinamica, oggettivamente delicatissima, ben poco spazio rimaneva per affrontare il “problema regione” in termini tecnicamente adeguati e culturalmente aggiornati. Tale processo, che è difficile non ritenere complessivamente involutivo, si espresse con particolare evidenza nel dibattito (o mancato dibattito) circa i criteri da adottare per la definizione delle nuove circoscrizioni regionali. La commissione incaricata di formulare le proposte iniziali aveva concluso (non senza forti dissensi interni) a favore dell’adozione del criterio storico tradizionale e non era andata oltre l’indicazione di massima circa l’opportunità di istituire come nuove regioni il Molise, il Salento e il Friuli e di procedere alla divisione dell’Emilia in due regioni: l’Emiliano-appenninica e la Romagna. Tuttavia, nel consegnare quelle conclusioni, era stata la commissione stessa a rilevarne il carattere provvisorio, dovuto all’assenza di adeguati studi tecnico-geografici e, pertanto, di alternative fondatamente praticabili. Era un chiaro invito rivolto alla Commissione dei 75 a promuovere le ricerche permettendo di impostare il problema in termini meno lacunosi e sorpassati. Da parte di qualcuno (C. Mortati, E. Vanoni…) si parlò non solo di insufficienza ma di irrazionalità delle divisioni regionali tradizionali rispetto ai fini cui dovevano servire. Occorreva, insomma, mobilitare economisti e geografi, linguisti, antropologi e storici per pervenire alla individuazione di unità socialmente ed economicamente omogenee che riflettessero lo stato delle singole realtà locali. Ma tali studi non vennero. La sostanziale sospensione di giudizio adottata dagli interessati lasciava intendere la scelta del quaeta non movere come risposta all’oggettiva spinosità del problema. Fu l’imminenza elettorale dell’autunno a riportare improvvisamente alla ribalta il problema: la sollecitazione veniva dal Ministero dell’interno che chiedeva un responso in vista delle votazioni. Ma il terreno degli studi non registrava sensibili passi avanti. In un clima di imbarazzata improvvisazione si arrivò a una votazione a sorpresa che vide prevalere di un solo voto la tesi della divisione tradizionale delle regioni storiche. Si era determinata così una sorta di consacrazione “a scatola chiusa” de passato gravida di esiti problematici. La grande distanza fra “paese reale’ e “paese legale”, tenace male oscuri dell’Italia postunitaria, era lontana dall’essere colmata. S’affidava invece al le generazioni successive, che solo ne 1970 avrebbero realizzato le regioni ; statuto ordinario, una eredità di difficile adempimento cui il travaglio dell’industrializzazione e l’esigenza tutti moderna della pianificazione economica avrebbero impresso connotazioni funzioni del tutto impreviste.