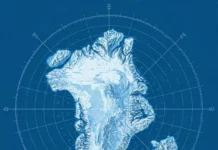Le recenti elezioni in Turchia, forzatamente anticipate, possono aver dato – a un osservatore superficiale – l’impressione di essersi svolte, almeno formalmente, in maniera ineccepibile. Ma forse parlare di una “simulazione ben riuscita” non sarebbe del tutto fuori luogo.
In realtà le elezioni si sono svolte in un clima di insicurezza, di tensione e in un contesto di stato d’emergenza amplificato dalla reazione al (mancato) colpo di Stato del 15 luglio 2016. In particolare con l’estensione del controllo esercitato dal governo sul sistema giudiziario (e sulla relativa giurisdizione amministrativa, giudiziaria e militare), l’arresto di centinaia di sindaci nelle regioni curde (sostituiti con amministratori nominati dalla Stato e non eletti).
Ovviamente, a essere colpiti sono stati soprattutto gli esponenti di HDP (novemila arresti e almeno tre omicidi). Da parte sua il Parlamento Europeo aveva ritenuto di sospendere l’invio di delegazioni. Così l’OCSE nelle zone di confine per “ragioni di sicurezza”.
Eppure la situazione avrebbe richiesto un severo monitoraggio.
Con una legge votata all’ultimo momento erano stati autorizzati spostamenti di seggi nelle zone curde, costringendo molti cittadini a percorrere decine di chilometri (senza auto) per andare a esercitare il diritto di voto. Inoltre uno dei maggiori gruppi mediatici superstiti, Dogan Haber, veniva acquisito da personaggi legati a Erdogan (anche da vincoli di parentela) permettendogli di estendere ulteriormente il suo controllo sull’informazione.
Gran parte dei membri delle delegazioni indipendenti, formate da rappresentanti di partiti politici e associazioni, sono stati arrestati e trattenuti fino alla conclusione dello scrutinio per impedir loro di controllare le alquanto probabili frodi elettorali. Analizzando i risultati delle precedenti elezioni (7 giugno 2015) il partito al potere aveva ritenuto di potervi leggere una malcelata forma non solo di protesta, ma di vera e propria ribellione contro lo Stato.
E non solamente (Gezi Park docet) da parte dei curdi. Molte persone in ogni angolo del Paese si erano ritrovate attorno al Partito Democratico dei Popoli (HDP, in turco Halklarin Demokratik Partisi, in curdo Partiya Demokratik a Gelanin) e al concetto che “noi possiamo; con le nostre differenze, insieme e liberi”: turchi e curdi, alawiti e sunniti, credenti e atei, etero e omosessuali… e poi femministe, ecologisti, pacifisti, libertari… insomma soggetti provenienti da ogni àmbito della società (donne e giovani soprattutto). Nella convinzione che anche in Turchia “un altro mondo è ancora possibile” nonostante le politiche razziste, militariste e neoliberiste di Erdogan.
Da questa situazione, inaccettabile per Ankara, era derivata una serie di decisioni. In primis, impedire lo svolgimento di normali elezioni democratiche; o almeno non fino a quando lo Stato non avesse posto in essere regolamenti e procedure a lui convenienti. Questo, secondo alcuni osservatori, è quanto è avvenuto il 24 giugno con l’applicazione di nuove regole.
I risultati sono noti. L’AKP (Partito per la Giustizia e lo Sviluppo, in turco Adalet ve kalkinma Partisi), ha ottenuto la maggioranza in Parlamento grazie alle componenti più razziste della società turca. Infatti l’estrema destra non aveva designato suoi candidati alla presidenza per favorire l’AKP.
Erdogan però ha sì ottenuto la maggioranza, ma non quella “maggioranza qualificata” che gli avrebbe consentito di modificare la Costituzione. Infatti al 52% delle presidenziali corrisponde un 42% alle legislative per cui l’AKP dipenderà dal sostegno di MHP (Milliyetci Hareket Partisi, considerato il braccio politico dei Lupi Grigi) e dal suo 11,1%.
Quanto al partito HDP, nonostante il candidato Selahattin Demirtaş sia rimasto in cella a Edirne durante la campagna elettorale e nonostante il clima di guerra in Bakur, ha superato la soglia di sbarramento del 10% passando da 59 a 68 seggi (per essere prontamente accusato dalla stampa di regime di “aver fatto entrare nuovamente in Parlamento i terroristi del PKK”).
Per quanto riguarda il CHP (Partito Popolare Repubblicano, in turco Cumhuriyet Halk Partisi), ha ottenuto il 22% dei voti alle legislative mentre il suo candidato alle presidenziali, Muharrem Ince, si è visto attribuire un significativo 30,6%.
Stranamente, l’ex docente di Fisica (laico e “kemalista puro”, diventato una leggenda tra i frequentatori del web per le sue passate invettive contro Erdogan e che fino alla sera prima aveva mantenuta inalterata la sua posizione di “resistenza” nei confronti del governo) nelle ore immediatamente successive alle elezioni non era più intervenuto.
Cosa può essere accaduto nel frattempo?
Tra le varie ipotesi, si è parlato di “contatti” tra Muharrem Ince e l’AKP. Sembrerebbe confermarlo l’inaspettata dichiarazione del portavoce del partito di Erdogan che rispettosamente aveva definito Ince “leader naturale del CHP” invitandolo alla reciproca comprensione e lasciando balenare la possibilità di un’alternanza al potere per le prossime elezioni. Il candidato del CHP si sarebbe quindi inchinato alla ragion di stato accettando pubblicamente i risultati elettorali.
Insomma Muharrem Ince si starebbe ritagliando un ruolo di “opposizione istituzionale” più che altro di facciata. A conferma che il CHP attuale non è un quel partito di sinistra che talvolta pretende di essere. Ricorda piuttosto quello degli anni settanta di Bulent Ecevit. Con Ice, Erdogan potrà marciare, se non a braccetto, almeno per mano. È presumibile che le cose sarebbero andate diversamente se il candidato premier di CHP fosse stato Kemal Kilicdaroglu: alawita, curdo e meno disponibile a collaborare con l’AKP.
Proprio un anno fa, il 9 luglio, si concludeva a Istanbul la grande marcia pacifica organizzata da Kilicdaroglu (e partita in giugno da Ankara) “per un sistema giudiziario in cui la legge non venga utilizzata come strumento di oppressione” in quanto, sosteneva Kilicdaroglu, “dobbiamo unire questo Paese così lacerato attorno al diritto alla giustizia e a valori democratici”.
Da oggi sarà ancora più difficile.