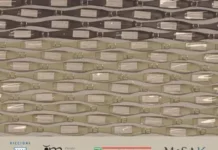Un paio di mesi fa avevo denunciato le ignobili sevizie a cui veniva sottoposta la giovane curda Garibe Gezer dai suoi carcerieri. Torturatori e aguzzini che ora hanno completato l’opera di annientamento nei confronti di questa prigioniera politica, rinchiusa nel carcere di massima sicurezza (di tipo F) di Kandira a Kocaeli, in Turchia. Secondo la versione fornita dall’amministrazione carceraria, la ragazza, arrestata a Mardin nel 2016, si sarebbe “suicidata”.
Numerose donne, esponenti delle Madri della Pace, del Movimento delle Donne Libere (TJA), dell’Associazione di aiuto alle famiglie dei prigionieri (TUHAY DER) e dell’HDP, si sono riunite davanti all’ospedale di Kocaeli per riavere il corpo della giovane vittima. Hanno poi portato a spalla la bara scandendo slogan contro la repressione, nonostante la polizia intervenisse per impedirlo.
Nella tarda serata del 10 dicembre, la ragazza è stata sepolta a Kerbora, la città dove era nata 28 anni fa.
 Ma la versione ufficiale sulla morte di Garibe Gezer non ha convinto Eren Keskin. In quanto avvocato e co-presidente dell’Associazione dei Diritti dell’Uomo (IHD), si è chiesta come la detenuta abbia potuto suicidarsi visto che si trovava in isolamento per una sanzione disciplinare, sotto lo sguardo perenne delle telecamere.
Ma la versione ufficiale sulla morte di Garibe Gezer non ha convinto Eren Keskin. In quanto avvocato e co-presidente dell’Associazione dei Diritti dell’Uomo (IHD), si è chiesta come la detenuta abbia potuto suicidarsi visto che si trovava in isolamento per una sanzione disciplinare, sotto lo sguardo perenne delle telecamere.
Nell’ottobre scorso, con una iniziativa parlamentare delle donne del Partito Democratico dei Popoli (HDP), veniva segnalato che Garibe era stata posta in isolamento per 22 giorni dopo il suo trasferimento, il 15 marzo, dalla prigione di Kayseri in quella di Kandira dove in queste ore ha perso la vita. Il 24 maggio, agenti penitenziari, sia uomini che donne, erano entrati nella sua cella per picchiarla. Si leggeva nel rapporto che “mentre le guardiane le tenevano le braccia bloccate, gli uomini la percuotevano sulla schiena. I suoi abiti venivano strappati, le venivano tolti i pantaloni per essere quindi trascinata per i capelli, seminuda, nell’area riservata ai detenuti maschi”.
Scaraventata in una “cella imbottita completamente isolata e controllata 24 ore su 24”, subiva “violenze sessuali da parte dei carcerieri”.
A causa delle violenze, secondo il rapporto di HDP, la prigioniera avrebbe cercato di porre fine ai suoi giorni. Portata nell’infermeria del carcere, vi pativa altri maltrattamenti e non veniva curata.
Messa in isolamento, il 7 giugno tentava di appiccare il fuoco alla sua cella e veniva gettata nuovamente in una cella imbottita. In una conversazione telefonica con la sorella era riuscita a informare i familiari che sarebbe stata posta ancora in isolamento e che nei suoi confronti venivano esercitate ulteriori restrizioni disciplinari. Quanto alle sue lettere, alcune sono state censurate, altre mai spedite.
Nonostante le sue proteste e le denunce degli abusi subiti in carcere fossero note da tempo, nessuna inchiesta era mai stata avviata. Agli avvocati dell’Ufficio di aiuto giuridico contro la violenza sessuale e lo stupro, che si erano recati al carcere insieme a quelli dell’Associazione degli avvocati per la libertà (OHD), non veniva concessa la possibilità di assistere all’autopsia.
Una vicenda quella di Garibe Gezer purtroppo analoga a tante altre.
La sua famiglia in particolare ha pagato un prezzo molto alto nella lotta di liberazione. Un fratello, Bilal, era stato ucciso durante le proteste che tra il 6 e l’8 ottobre 2014 videro decine di migliaia di curdi scendere in strada da Diyarbakir a Vario e in una trentina di altre località, anche sul confine tra Suruc e Kobane. Assediando caserme e commissariati e incendiando alcuni edifici governativi in Bakur (Kurdistan del Nord sotto occupazione turca). Quella che sotto molti aspetti fu una vera e propria insurrezione, derivava dalla richiesta di aprire un corridoio per portare soccorso a Kobane assediata dall’ISIS. L’abbattimento di un largo tratto della frontiera consentì a molti curdi provenienti dalla Turchia di raggiungere i fratelli di Kobane. Da parte sua Erdogan ordinò il coprifuoco e schierò i carri armati. Le vittime accertate, quasi tutte curde, furono oltre 50, almeno 700 i feriti.
Un altro fratello, Mehemet Emin Gezer, si era recato al commissariato di Dargeçit per poter recuperare il corpo di Bilal, ma era stato colpito dalla polizia delle operazioni speciali rimanendo paralizzato. Altri membri della famiglia erano poi stati parimenti incarcerati.