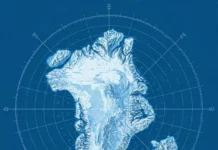Il termine “Giubileo” deriva dall’ebraico yobel, il quale indicava inizialmente il montone alla guida del gregge, poi il corno del montone, il suono del corno stesso e infine la festività che con esso si sarebbe annunciata. Nel capitolo XXV del Levitico, uno dei testi dell’Antico Testamento, si racconta di come Dio parlasse sul monte Sinai a Mosè dandogli le prescrizioni da osservare per la Terra Promessa. Tra queste c’era un anno sacro di riposo, detto appunto Giubileo, che sarebbe ricorso dopo sette serie di un anno sabbatico (corrispondente a sei anni di lavoro), e quindi dopo cinquanta anni; un anno che gli uomini avrebbero dovuto santificare con il riposo e con il ripristino dei possessi familiari e delle libertà individuali di cui solo Dio era comunque “proprietario”.
Nella tradizione cristiana, a partire dal 1300, anno nel quale papa Bonifacio VIII lo istituì per la prima volta, il senso del Giubileo fu invece direttamente accostato al viaggio dei pellegrini da effettuare verso i luoghi sacri, soprattutto quello sacro per eccellenza, cioè Roma, simbolo del cristianesimo per la tomba di Pietro e la sede papale.
Sappiamo poi tutti come alla base dell’istituzione del primo Giubileo ci fossero anche motivi squisitamente economici (chi non ricorda il ritratto che di papa Bonifacio VIII fece Dante Alighieri nel suo Inferno?), ma può essere utile ripercorrere per sommi capi anche la storia e il significato religioso dell’evento nei secoli, così legato, quanto meno nella sua logica sacra, al tema della riconciliazione tra l’uomo e Dio.
L’inizio nel 1300
Dicevamo che il primo Giubileo cristiano fu istituito da papa Bonifacio VIII nel 1300. Questa decisione diede al pellegrinaggio a Roma, presso le tombe degli apostoli Pietro e Paolo, una nuova dimensione e un nuovo significato. L’inizio di un nuovo secolo aveva spinto a Roma un eccezionale numero di pellegrini per venerare la più famosa delle reliquie romane, quella della “Veronica”, che rappresenta il volto sofferente di Gesù nella Passione, custodita a San Pietro.
Il continuo afflusso di pellegrini spinse Bonifacio VIII a indire il Giubileo ogni cento anni e a promulgare l’indulgenza plenaria. “Non ci fu fin dai tempi antichi così grande devozione e fervore di fede nel popolo cristiano”, scrisse con entusiasmo un commentatore dell’epoca.
Ma ben presto la secolarizzazione temporale dei Giubilei fu scardinata dalla richiesta, avvenuta nel 1343, di una delegazione di romani recatasi da Clemente VI ad Avignone, in Francia, dove il papa era in esilio dal 1309, per chiedere un Giubileo straordinario nel 1350, quindi con una più breve scansione temporale, cioè di soli cinquanta anni. La richiesta si fondava proprio sull’antica usanza ebraica di cui parlavamo all’inizio, quella contenuta nel Levitico, dei quarantanove anni dopo i quali il cinquantesimo sarebbe stato giubilare.
I romani erano anche spinti a chiedere un Giubileo dal crescente disagio provocato nella città dalla prolungata assenza del papa, mentre l’evento giubilare sarebbe stato un’occasione opportuna per il ritorno del pontefice nella sua sede episcopale. Clemente VI indisse quindi questo Giubileo anticipato, concesse l’indulgenza plenaria a chi si fosse recato presso le tombe degli apostoli Pietro e Paolo e – novità rispetto al 1300 – anche nella basilica di San Giovanni in Laterano. Tuttavia, per motivi politici, il papa non poté recarsi a Roma.
 La sequenza dei Giubilei dopo quello del 1350 fu perturbata dal grande scisma d’Occidente del 1378, legato al conflitto sulla legittimità della scelta e dell’elezione del papa. Anche per questo Giubileo ci fu un cambiamento nella scadenza. Urbano VI lo promulgò per il 1390, mentre la sua intenzione era di introdurre una nuova scadenza temporale nei Giubilei: quella di trentatré anni, in ricordo della vita di Gesù.
La sequenza dei Giubilei dopo quello del 1350 fu perturbata dal grande scisma d’Occidente del 1378, legato al conflitto sulla legittimità della scelta e dell’elezione del papa. Anche per questo Giubileo ci fu un cambiamento nella scadenza. Urbano VI lo promulgò per il 1390, mentre la sua intenzione era di introdurre una nuova scadenza temporale nei Giubilei: quella di trentatré anni, in ricordo della vita di Gesù.
Diversi motivi portarono però allo slittamento di tale scansione temporale e il Giubileo ebbe luogo nel 1390, celebrato da Bonifacio IX, successore dello scomparso Urbano VI (quello attualmente in corso, quindi, non è affatto il primo Giubileo promulgato da un papa e poi “gestito” in tutto o in parte da un altro pontefice dopo la sua morte). In questo Giubileo, tra le basiliche romane che i pellegrini dovevano visitare a Roma, venne aggiunta anche Santa Maria Maggiore.
Nonostante fossero trascorsi solo dieci anni, papa Bonifacio IX volle che si celebrasse anche il Giubileo del 1400 per rispettare la scadenza dei cinquant’anni decisa nel 1350. La Chiesa era, in quell’anno, ancora divisa tra Roma e Avignone, dove tuttavia ormai regnava un antipapa. I cristiani francesi, spagnoli e parte di quelli italiani non presero parte al pellegrinaggio giubilare poiché i loro sovrani, aderendo alla parte scismatica della Chiesa, impedirono la partecipazione al Giubileo dei loro sudditi.
Bonifacio IX estese la visita per acquistare le indulgenze alle basiliche di San Lorenzo fuori le Mura, Santa Maria in Trastevere e Santa Maria Rotonda, che si aggiungevano così alle quattro basiliche maggiori già scelte negli anni precedenti. Nel Giubileo del 1400 ebbe inizio anche un nuovo tipo di pellegrinaggio penitenziale che, partendo da varie contrade dell’Italia settentrionale, si dirigeva a Roma sotto l’insegna di “pace e misericordia”.
Dopo il Giubileo del 1450, durante il quale Roma fu messa a dura prova dalla presenza di un numero assai grande di pellegrini – per i quali si posero per la prima volta problemi di ordine pubblico, sanitario oltre che di approvvigionamento – a partire dal 1475 la scadenza dei Giubilei diventò venticinquennale. Dietro questa scelta ci fu l’astuzia di papa Sisto IV il quale, per far convergere a Roma tutto il mondo cattolico, sospese durante il periodo giubilare tutte le indulgenze plenarie già concesse nel corso dei pellegrinaggi fuori di Roma.
Fu anche il primo Giubileo che utilizzò la nuova tecnologia della stampa, scoperta nel 1444 da Gutenberg: le Bolle giubilari, le istruzioni per la giornata del pellegrino e le preghiere da recitare nei luoghi sacri vennero presentate, per la prima volta, con i moderni caratteri di stampa. Da questo Giubileo, inoltre, entrò in uso la semplice e significativa denominazione di “Anno Santo” giunta fino ai nostri giorni.
Poco tempo dopo la scoperta del nuovo mondo si celebrava l’Anno Santo del 1500. Alla vigilia del Natale dell’anno precedente Alessandro VI presenziò alla sua inaugurazione con nuova solennità compiendo un nuovo rito: l’apertura di una Porta Santa nella basilica di San Pietro a cui, da allora, venne trasferito il ruolo tradizionale che per secoli aveva svolto la porta aurea di San Giovanni in Laterano. Il papa volle, inoltre, che l’apertura delle porte sante fosse prevista in ciascuna delle quattro basiliche maggiori fissate per la visita giubilare. Da quel momento la Porta Santa e il passaggio attraverso di essa divenne uno dei fatti più importanti dell’Anno Santo.
Riforma e Controriforma
Il Giubileo successivo, nel 1525, gestito da papa Clemente VII, fu il primo ad aprirsi in un tempo di conflitti religiosi e politici legati alla Riforma luterana, iniziata nel 1517. Il monaco agostiniano aveva, tra l’altro, messo in discussione il principio stesso delle indulgenze. Veniva così ridiscusso uno dei cardini dell’Anno Santo. Più in generale si chiedeva, da molte parti, una Riforma della Chiesa. Ma anche nel campo politico lo scontro era grande: il conflitto tra Carlo V e Francesco I aveva dato vita alla prima grande spaccatura politica dell’epoca moderna in Europa. Anche la Chiesa ne faceva le spese: Roma venne invasa e saccheggiata, due anni dopo l’Anno Santo, dalle truppe imperiali di Carlo V.
Cinquant’anni dopo, il Giubileo del 1575 fu il primo dopo il Concilio di Trento ad aver di fatto rappresentato la risposta del mondo cattolico romano contro la Riforma luterana. Roma si era preparata all’evento con particolare cura e austerità e questo fu anche il primo Giubileo caratterizzato da nuove presenze di aggregazioni laicali e religiose, tra cui la Confraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini e dei Convalescenti fondata da Filippo Neri. Questa istituzione organizzò l’accoglienza ai pellegrini fin nei particolari più umili.
Col Giubileo del 1625, in seguito a una drammatica ondata di peste diffusasi in tutta Europa, gli effetti spirituali del Giubileo vengono estesi a coloro che, per ragioni di salute e precauzione non possono giungere a Roma: si tratta di un’importante innovazione che modifica in profondità il concetto ispiratore di questa indulgenza, originariamente legata al solo viaggio a Roma.
Mezzo secolo dopo, mutate le cose, il Giubileo del 1675 accoglie per la prima volta i pellegrini all’interno del colonnato di Piazza San Pietro, realizzato dal Bernini. Le braccia allargate del colonnato sono il simbolo più compiuto della nuova disposizione della città verso le folle dei pellegrini che la visitano ogni Anno Santo. Alla vigilia Clemente X canonizza la prima santa dell’America del Sud, Rosa da Lima; poi erige la prima diocesi dell’America del Nord, quella del Québec. Il Giovedì Santo, il papa si reca nella sede della Confraternita dei Pellegrini per lavare i piedi a dodici poveri e fa servire una cena per diecimila persone. La regina Cristina di Svezia partecipa, nello stesso luogo, alla “lavanda dei piedi” delle pellegrine.
Nell’edizione del 1750 il papa dell’epoca, Benedetto XIV, nella Bolla di indizione (Peregrinantes a Domino), sottolinea la necessità di fare penitenza affinché l’Anno sia veramente “Santo”: un anno di edificazione e non di scandalo. Il papa richiama il valore del pellegrinaggio come superamento delle dimensioni quotidiane di peccato. Il Giubileo ha, così, una forte caratterizzazione spirituale.
Un secolo insolito
Nel 1800 il Giubileo non viene invece celebrato a causa dei profondi rivolgimenti che attraversano l’Europa dopo la Rivoluzione francese. Nel 1797 le truppe francesi occupano Roma e la città diviene il centro della Repubblica romana. Il papa che avrebbe dovuto convocarlo, Pio VI, muore esule nel 1799. L’anno giubilare trascorre così tra l’assenza forzata del pontefice da Roma, le difficili condizioni politiche generali, l’incertezza degli eventi bellici. L’insieme di questi fattori impediscono così a Pio VII di pensare alla celebrazione dell’Anno Santo, che così salterà per la prima volta nella storia.
Ma è un po’ tutto l’800 a essere un secolo “strano”: quello del 1825 è l’unico Giubileo celebrato; quello del 1850 non viene né indetto né celebrato poiché papa Pio IX è esule da Roma, e un vasto fenomeno di agitazione generale investe la città e lo Stato pontificio a partire dal 1848, inizio della cosiddetta “questione romana” in cui veniva messo in discussione il potere temporale del papa.
Neppure nel 1875 il Giubileo viene celebrato: Roma è divenuta capitale d’Italia da qualche anno, il papa ha perso il potere temporale sulla città e sullo Stato pontificio e decide di restare a Roma chiudendosi in Vaticano e dichiarandosi “prigioniero del re”. Alla fine dell’anno verrà celebrato all’interno della basilica di San Pietro e alla sola presenza del clero romano: un Giubileo, quindi, a “porte chiuse”.

Nel 1900, dopo settantacinque anni, la Porta Santa viene finalmente riaperta. Leone XIII inaugura la notte di Natale del 1899 il primo Anno Santo dopo la fine del potere temporale del papa, promulgando la storica Enciclica Rerum novarum. Roma si popolò, per l’occasione, di pellegrini da ogni parte del mondo. Lo stesso avverrà nei due Anni Santi successivi, nel 1925 e nel 1950, anni di “dopoguerra” dopo la conclusione dei due conflitti mondiali. In mezzo, nel 1933, un altro Giubileo straordinario, voluto da Pio XI, viene proclamato come Giubileo della Redenzione dopo aver istituito la festa del Cristo Re e consacrato l’umanità al Sacro Cuore di Gesù.
Nel 1975, dopo la chiusura del Concilio Vaticano II voluto da Giovanni XXIII e chiuso da Paolo VI, tutto il mondo della Chiesa romana si chiede se abbia ancora senso la celebrazione dei Giubilei, che sembra a molti anacronistica, legata a un’idea di cristianità medievale. Eppure passano pochi anni e Karol Wojtyla, il papa venuto da “oltre cortina”, nel 1983 ne proclama uno straordinario, segno della forza della religione sul mondo ateo comunista, immaginato altresì come un’anticipazione di quello di fine millennio. Con papa Wojtyla la lunga preparazione del Giubileo dell’anno 2000 viene vista come una grande revisione di vita incentrata sull’eredità del Concilio e insieme come una riflessione sui contenuti principali della fede cristiana. Rimarrà il Giubileo che ha portato a Roma la più grande massa di pellegrini da tutto il mondo: oltre trenta milioni di persone.
Al confronto quello in corso, indetto da papa Francesco e adesso proseguito da papa Leone, fatte salve alcune eccezioni, sembra proprio una disfatta tra polemiche sull’overtourism, sui costi delle strutture, sulla crisi dei trasporti e, soprattutto, sulla crisi identitaria dei cattolici e, in generale, dei cristiani nel mondo.