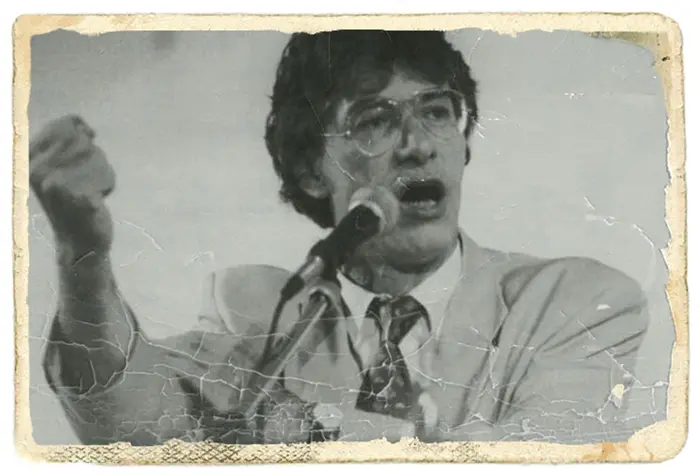La decisione della corte costituzionale, che ha di fatto smantellato la legge sull’autonomia differenziata e ha affermato che “i popoli regionali non esistono”, riducendo la “nazione italiana” a un’entità unica e indivisibile, analogamente al territorio dello Stato, ha rappresentato un colpo duro alle istanze di autonomia e al riconoscimento delle diversità culturali e storiche dei “popoli regionali”, come ad esempio quello veneto, esplicitamente riconosciuto nello statuto regionale.
Una sentenza, che smantellando ogni tentativo di autogoverno basato sulle identità etnoculturali, rischia di emarginare sia il dibattito politico sia quello culturale, come l’insegnamento nelle scuole e le radici storiche profonde che hanno caratterizzato le diverse popolazioni nel corso dei secoli, riducendole a un’asserita entità etnica omogenea. Esito paradossale di una riforma che, sorprendentemente, sembra tuttavia non aver turbato particolarmente i suoi sostenitori. Dopo trent’anni di discorsi, proclami e riforme non realizzate sul tema dell’autonomia e del federalismo, sarebbe forse opportuno avviare un serio percorso di autocritica prima di proporre nuovi progetti o di inseguire l’illusione di un terzo mandato perduto.
Un paradosso al quale, a breve, si aggiungerà un altro paradosso “autonomista”. La recente approvazione, avvenuta il 30 luglio 2025 da parte del consiglio dei ministri, del disegno di legge costituzionale che conferisce a Roma poteri “speciali” di livello regionale rappresenta un passo importante, ma solleva interrogativi sulla coerenza politica e sulle motivazioni: se l’autonomia si fonda su criteri storici e culturali, perché altre città con storie secolari, se non millenarie di capitale sovrana – come Venezia – non dovrebbero averne pari diritto?
Il disegno di legge riconosce Roma Capitale come un ulteriore ente autonomo della Repubblica, oltre ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni e allo Stato stesso, conferendole funzioni legislative concorrenti e residuali nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, governo del territorio, commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, turismo, artigianato, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica.
Per attribuire maggiori poteri a Roma, nei dibattiti che hanno preceduto l’approvazione del disegno di legge – come per esempio il convegno “Proposta di riforma costituzionale – Più poteri per Roma Capitale”, svoltosi l’11 febbraio 2025 presso l’aula dei gruppi parlamentari della Camera – tra i vari esempi di città capitali dotate di uno status legislativo e amministrativo particolare, è stato spesso citato anche Berlino. La capitale tedesca è una vera e propria Stadtstaat (città-stato), ovvero un Land autonomo nell’àmbito del sistema federale tedesco, con una propria costituzione.
La “città-stato” di Berlino ha poteri di rappresentanza nel parlamento tedesco e nel Comitato delle Regioni dell’Unione Europea. I rapporti tra la “città-stato” e il governo centrale sono regolamentati, per legge, attraverso “accordi contrattuali”. Si trascura, tuttavia, il fatto che anche altri centri tedeschi come Amburgo (seconda città più grande della Germania dopo Berlino e il più grande porto d’Europa) e Brema, pur non essendo capitali, hanno lo status di Stadtstaat.
L’autonomia, pertanto, potrebbe essere estesa anche ad altre città, non necessariamente capitali. Per quale motivo Milano, Venezia, Genova e Napoli, che sono state capitali per molti secoli, non possono avere gli stessi poteri, ispirandosi al modello delle città-stato tedesche di Amburgo e Brema, oltre che della capitale Berlino?
L’autonomismo moderno e attuale dovrebbe quindi orientarsi verso una nuova “mappa” politica, basata sulle città-stato, piuttosto che su un’ipotetica “autonomia differenziata” delle regioni, che appare ormai improbabile e poco perseguibile. L’autonomia dovrebbe partire dalle città, in particolare da quelle che sono state centri di potere e capitali per molti secoli, piuttosto che dalle regioni burocratiche in cui il cittadino ha difficoltà a identificarsi.
Le regioni sono un fenomeno relativamente recente; storicamente, soprattutto nella policentrica Padania, erano le città a rappresentare i veri centri di potere e di decisione, evidenziando come il modello delle città-stato sia più radicato nella nostra tradizione.
Il federalismo “cantonale” proposto da Miglio non si è mai veramente radicato nella cultura politica padana, caratterizzata dal policentrismo, come spesso ricordava Gilberto Oneto. In questa prospettiva, il vero “mattone” del federalismo padano non sono le regioni, ma le capitali storiche. Del resto, la stessa Lega Lombarda, che si opponeva a Barbarossa, rappresentava una societas di città della “Lombardia storica”, ovvero della Padania, evidenziando un senso di identità e autonomia condiviso tra le comunità locali identificate nelle realtà cittadine.
Oltre a evidenziare il paradosso di Roma che si rende autonoma dai territori e non viceversa, è in ogni caso importante partecipare al dibattito pubblico sui “poteri speciali” alla capitale e sviluppare programmi politici fondati sulle città-stato, per costruire un vero e proprio federalismo basato sulle radici storiche e culturali. L’obiettivo dovrebbe essere il superamento delle inutili contrapposizioni, delle polemiche politiche e delle prese di posizione opportunistiche ed estemporanee.
Si tratta un’importante occasione per rilanciare il dibattito sull’identità culturale e sull’autonomia politica.
I paradossi dell’autonomismo
La sentenza della corte costituzionale, i “poteri speciali” di Roma e il rilancio del federalismo con le città-stato.