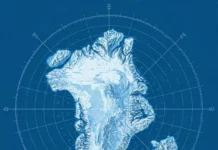Il 29 ottobre, mentre andava intensificandosi l’operazione per estirpare i masai dalle loro terre ancestrali, in Tanzania si svolgevano le presidenziali, ma con il capo dell’opposizione Tundu Lissu in carcere per “tradimento” e quindi di fatto escluso dalla consultazioni.
Elezioni segnate da forti contestazioni per la grave situazione sociale in cui versa il Paese, con manifestazioni a cui il governo, confermando l’attuale deriva autoritaria, ha risposto con una durissima repressione. Sono rimaste sul terreno alcune centinaia di vittime civili ed è stato imposto il coprifuoco a Dar es Salaam (oltre al blocco della rete mobile 4G). Nei giorni successivi la situazione si è aggravata coinvolgendo anche Arusha, Songwe, Kigoma e Mwanza.
Tornando ai masai, sacrificati sull’altare di una fasulla “difesa della natura” (in realtà su quella dei profitti derivati dal turismo), ancora nel febbraio dell’anno scorso Bruna Sironi su “Nigrizia” denunciava “gli abusi sui popoli nativi per estendere le riserve naturali a scopo turistico, anche grazie ai finanziamenti della Banca Mondiale”.
Risale infatti agli inizi del 2024 la notizia che “circa 100mila masai dovranno lasciare le loro terre, 20mila entro la fine di marzo. Intanto nel parco Ruaha un progetto di ampliamento delle aree protette prevede il trasferimento forzato di altre migliaia di persone”. Corollario scontato, gli abusi e le violenze per costringere le comunità ad andarsene diventavano pane quotidiano.
Stando alle testimonianze raccolte dal centro studi statunitense Oakland Institute (Tanzanian Government on a Rampage Against Indigenous People), i ranger della tanapa (Tanzania National Park Authority) si sarebbero resi responsabili di omicidi e violenze sessuali, oltre che di sequestri di bestiame, per costringere gli abitanti dei villaggi a traslocare.
Si sono così allargati e intensificati gli “sfratti” (al limite della deportazione) delle comunità rurali presenti nella zona di Ngorongoro: circa 100mila masai, in gran parte pastori, mai consultati in merito al loro destino.
Il Ruaha National Park (runapa, nella parte centrale del Paese) è uno dei quattro parchi per cui la Banca Mondiale ha messo a disposizione 150 milioni di dollari per finanziare il progetto “Gestione resiliente delle risorse naturali per il turismo e la crescita”.
Nel gennaio di quest’anno il governo aveva nuovamente inviato i ranger della tanapa contro un villaggio nei pressi del parco di Tarangire, dove avevano aperto il fuoco contro gli abitanti, arrestandone una decina e sequestrando un migliaio di capi di bestiame. Analogamente a quanto avvenuto nel 2024 con il sequestro di oltre tremila capi, poi venduti all’asta.
Prevista poi l’estensione dell’area protetta da un milione a due milioni di ettari (altro progetto approvato dalla Banca Mondiale nel dicembre 2017).
Per il governo, i provvedimenti sarebbero dovuti alla crescita demografica e allo “stile di vita” essenzialmente pastorale dei masai, ormai incompatibili con la sopravvivenza della fauna selvatica qui presente.
Incompatibilità ambientale?
Intendiamoci. Qui non si tratta di “superamento dell’antropocentrismo”, di restituzione dell’habitat a piante e animali selvatici, ma semplicemente della riproposizione di un modello già sperimentato (per esempio in Sudafrica) di “conservazione neocoloniale”, mettendo queste aree a disposizione dei turisti benestanti, cacciatori compresi. Del resto i safari rappresentano un fattore alquanto significativo nell’aumento del pil, e anche per questo il governo intende creare 15 nuove riserve di caccia entro il 2026. Vietando in queste aree la presenza umana – quella degli indigeni ovviamente – anche se, come ricordava Bram Büscher, “il sistema delle riserve favorisce solo la protezione di specie iconiche, come gli elefanti. Molti insetti, anfibi e piccoli mammiferi stanno scomparendo, ma non rientrano nelle priorità economiche del modello attuale”.
Ufficialmente per “migliorarne la gestione”, è prevista la realizzazione di infrastrutture per favorire i flussi turistici. Così, mentre aumentano i tagli a istruzione e sanità, si intensifica la costruzione di alloggi per turisti “inseriti nella natura” e di hotel. Provvedimenti simili erano già stati adottati dal governo in precedenza. Sempre l’Oakland Institute, nel maggio 2022, dopo un’approfondita ricerca sul campo aveva pubblicato un documento in cui definiva le nuove aree consegnate ai masai (in sostituzione di quelle ancestrali) come “non adeguate ai bisogni: terreno di pascolo assolutamente insufficiente, acqua scarsa”. Inoltre le promesse di migliorare i servizi risultavano “gravemente insufficienti, vaghe e inconsistenti”.
Un esempio da manuale di land grabbing in aperta violazione dell’articolo 10 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni.
In risposta a tale arbitrio, il 18 agosto 2024 circa 40mila masai, giunti percorrendo strade secondarie, avevano bloccato decine e decine di Land Cruiser carichi di turisti lungo la strada che unisce l’Area di Ngorongoro con il Parco Nazionale di Serengeti.
I manifestanti inalberavano cartelli e striscioni che rivendicavano “una vita sostenibile e un futuro sostenibile”, accusando la presidente Samia Syluhu di aver “soppresso i diritti sociali a Ngorongoro”, in riferimento sia alle drastiche limitazioni in materia di istruzione e sanità, sia all’intensificarsi delle restrizioni sulla mobilità (limitazioni nell’accesso ai pascoli, all’acqua…), oltre naturalmente agli attacchi dei ranger che avvengono in totale impunità.
All’iniziativa ha fatto eco un documento del misa (Alleanza Internazionale di Solidarietà Masai), elaborato da anziani, donne e giovani di 26 villaggi con l’intenzione di “sviluppare e promuovere una alternativa al modello di conservazione coloniale, potenziato, violento e capitalista che viene imposto alla nostra comunità”.
Ovviamente le legittime richieste degli indigeni si scontrano con il fatto incontestabile che ormai il turismo supera il 17% del pil nazionale, con quasi due milioni di visitatori stranieri per un valori di 3100 milioni di euro.