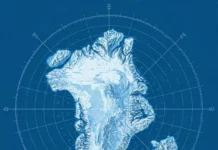Il Risorgimento impone la “lingua nazionale”. L’“Avanti!” e la sinistra nel ‘19 contro l’annessione di Bolzano. Goffe e macabre mascherature per rendere anche il Sudtirolo sacro alla Patria. La sconsiderata politica fascista contro ogni articolazione linguistica ed etnica. La Resistenza e la Dichiarazione di Chivasso. Le Alpi come “sacra barriera”. Il cinismo dei governi della Repubblica: niente tutela delle minoranze, se non per scongiurare il peggio. Ma, con ravvicinarsi dell’integrazione europea e con la fine della mistica risorgimentale e unitaria, qualcosa sta cambiando.
La problematica delle minoranze linguistiche in Italia è tipicamente risorgimentale; in effetti, nell’antico regno di Sardegna, comprendente aree linguistiche diverse, il bilinguismo, quando non addirittura il plurilinguismo, era pacifico. A cavallo delle Alpi, il dominio dei Savoia era stato da sempre bilingue: francese nella parte transalpina (per lo più franco-provenzale) e italiano nell’area cisalpina (dove però nell’area franco-provenzale e valdese era in uso la lingua francese); si aggiunga che il sovrano con i familiari scriveva anche in piemontese, e che l’inno ufficiale dello stato preunitario (Conservet Deus su re, salvet su regnu sardu) era in lingua sarda. Cavour, benché avesse più facilità a esprimersi in francese che in italiano (anche in Parlamento), diceva che, fatta l’Italia, occorreva fare gli italiani e in questa finalità rientrava la necessità di disporre di una lingua “nazionale”.
Il fatto che i Piemontesi fossero stati all’avanguardia nell’azione militare per l’unificazione d’Italia, e che fossero accusati di fare in realtà un’operazione imperialista, era oggettivamente una circostanza piuttosto imbarazzante perché la lingua piemontese di italiano ha ben poco: nella fonetica, nel lessico, nelle strutture. Preoccupazione degli stessi Piemontesi era quella di “spiemontesizzarsi” per dimostrare che non erano “stranieri conquistatori”, ma “italiani liberatori”. Questa ambiguità, questa contraddizione non era soltanto dei grandi leader ma anche — possiamo chiamarli così — dei piemontesi. Lo stesso Angelo Brofferio, irriducibile oppositore del Cavour dai banchi dell’estrema sinistra subalpina, uno dei maggiori scrittori in lingua piemontese, un “cantautore politico” perché componeva canzoni contestatrici che egli stesso musicava, si rifiutava nel 1861 di scrivere per il teatro piemontese perché, sosteneva, così facendo “renderemmo più difficile l’unità degli Italiani”.
In un volumetto stampato a Biella alla vigilia della prima guerra d’indipendenza (Aiutarello a parlare famigliarmente italiano) Agostino Fecia, autore di questo “metodo pratico e progressivo”, scriveva a mo’ di prologo : “Il grido prolungato di incitamento a lasciare lo sguajato linguaggio piemontese, ed a parlare familiarmente italiano, ha scosso non pochi…” Insomma, quasi un “grido di dolore” come quello che “non lasciò insensibile” Vittorio Emanuele II!
Alessandro Manzoni, nella sua famosa lettera al piemontese Giacinto Carena, propose di rifare i dizionari dialettali in quanto mancanti di coordinamento e di unità del tipo idiomatico a cui riferirsi; il che non era invero facile, visto che mancava sempre quel modello italiano che Manzoni aveva domandato alla Crusca: il primo volume del dizionario doveva apparire nel 1863 e soltanto nel 1923 si arrivò alla lettera O! A quell’epoca, sì e no il 2% della penisola parlava “italiano” e non, esclusivamente, una di quelle parlate popolari romanze degradate comodamente a “dialetti” della lingua nazionale.
Nel 1859, conclusasi la seconda guerra d’indipendenza, entra nel regno di Sardegna la Lombardia, e si apprestano a entrare l’Italia centrale (con le ex legazioni pontificie) e meridionale (spedizione dei Mille e crollo del regno delle Due Sicilie); nel 1861, quando ormai lo stato non sarà più il “Piemonte”, ma il “regno d’Italia” (rimanevano ancora esclusi il Veneto, il Friuli e il Lazio, oltre ovviamente alle “terre irredente”), l’on. Giovenale Vegezzi-Ruscalla, deputato di Scandiano (Reggio Emilia), ispettore generale delle carceri (!), presenta alla Camera un progetto di legge per “l’abolizione della lingua francese in alcune valli del Piemonte”. Si riferiva, evidentemente, alla Valle d’Aosta (dove il poeta patoisant abbé H. Cerlogne gli risponderà “per le rime”) e alle valli “valdesi” (Pellice, Germanasca e basso Chisone) di lingua occitana (cioè di lingua d’Oc, o provenzale), ma dove il francese era lingua di culto e di cultura ormai da più di due secoli.
Nel 1866, conclusasi la terza guerra d’indipendenza, il problema è ancora più grave poiché vengono a far parte del regno d’Italia pure il Veneto e il Friuli, dove vi sono anche popolazioni le cui parlate non sono romanze, e cioè neolatine e quindi ritenute naturalmente assimilabili al sistema linguistico italiano, ma tedesche e slovene; e poi il friulano, pur essendo neolatino, è così diverso dall’italiano… Ci si è allora trovati dinanzi al problema di insegnare l’italiano a chi non lo conosceva e d’imporre una lingua nazionale là dove tale non lo era affatto. Quando si trattò di accattivarsi per il plebiscito le simpatie degli “Slavi” (Sloveni) delle valli del Friuli orientale, si insistette, da parte governativa, sulla promessa delle scuole gratuite per tutti; per i montanari era ovvio supporre che l’insegnamento sarebbe stato “nella” e “della” lingua materna (tedesca e slovena), poiché l’Austria, dove aveva aperto scuole, aveva rispettato il principio di nazionalità. Il plebiscito fu votato la domenica, e il martedì già si diramavano le circolari del prefetto con le istruzioni per l’immediato processo di italianizzazione di quelle valli che oggi sono ritenute “italianissime”, mentre in realtà erano e sono slovene. Cosi non si faceva altro che continuare le direttive già espresse nel 1864 dal Presidente del Consiglio A. Lamarmora. “L’Italia è una: ha un’unica religione, un’unica lingua, una patria sola, a fronte di quella dell’impero austriaco che è un amalgama di popoli diversi di lingua, di religione e di tendenze.”
Dopo la I guerra mondiale
Se le minoranze linguistiche annesse dal 1859 al 1866 erano abbastanza sommerse e sconosciute ai più (Albanesi, Greci, Croati della diaspora centro-meridionale non avevano mai dato problemi “etnici”; proprio in quegli anni venivano scoperti e studiati con “curiosità” dai linguisti), la liberazione delle “terre irredente” e le annessioni successive al 4 novembre 1918 ponevano l’Italia in netta contraddizione con quella vantata “superiorità” proclamata dal Lamarmora. Tutta la sinistra negli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale si era pronunciata contro queste annessioni, soprattutto quella della provincia di Bolzano. Ci sono pagine dell’“Avanti!” che meriterebbero di essere rilette; si era prima della scissione di Livorno, e quindi il giornale socialista esprimeva ancora la volontà unitaria del partito operaio. Si ricordava come Cesare Battisti si fosse battuto per l’italianità del Trentino, e non per ridurre la provincia di Bolzano in Italia nelle condizioni in cui si trovava quella di Trento quando era soggetta all’Austria: una tale pretesa, nei due sensi, rimane infatti comunque immorale. Questa antinomia, questo contraddire il discorso della nazionalità che fu l’anima del Risorgimento e la motivazione dell’intervento nel 1915, dovrà notevolmente imbarazzare V.E. Orlando al tavolo della pace, dove non aveva giustificazioni per le conquiste italiane di regioni etnicamente tedesche e slave. Si giunse a goffe e macabre “mascherature”, come a trasportare salme di caduti italiani in Alto Adige, dove non vi fu un solo caduto, per crearvi cimiteri militari e rendere quella terra “sacra alla Patria”. Comunque, alla fine della guerra combattuta proprio contro l’Austria, l’Italia si trovava anch’essa a essere un “amalgama di popoli”, dove le “nazionalità” diverse diventavano italiane “per forza”, in quanto conquistate, e non certo per una libera determinazione come invece è avvenuto, nei secoli, nello stato confederale svizzero.
Il fascismo
Con l’inizio del regime fascista ci fu una contraddizione positiva: nel 1923, con la riforma scolastica Gentile (che più correttamente si dovrebbe chiamare Lombardo-Radice, poiché questi ne fu l’ispiratore), fu prevista l’utilizzazione del dialetto nella scuola e vi fu una fioritura di manualetti per le terze, le quarte e quinte classi elementari di traduzioni “dal dialetto alla lingua”, ricchi anche di proverbi, modi di dire, leggende popolari (a opera anche di linguisti illustri, come il prof. B. Terracini che curò un’edizione piemontese). Non si trattava, certamente, di insegnare il dialetto a scuola, ma di tener conto della cultura originaria dell’allievo secondo il dettame pedagogico “dal noto all’ignoto”. Era il risultato di un lungo lavoro iniziato nella seconda metà dell’800 dal maestro della dialettologia italiana, G.I. Ascoli (per il quale “la condizione dei figlioli bilingui” era una “condizione privilegiata nell’ordine dell’intelligenza”), e continuato agli inizi del secolo dai pedagogisti più aperti, come appunto G. Lombardo-Radice, E. Monaci, Crocioni, C. Trabalza… Il fascismo non tardò ad accorgersi della contraddizione tra il programma nazionalista (che si apprestava a diventare imperialista) del regime e il rispetto (sarebbe infatti improprio parlare di “tutela”) di fatto delle minoranze linguistiche: infatti, grazie a quella riforma della scuola, nelle comunità tedesche delle province di Bolzano e Trento l’insegnamento continuava a essere bilingue ancora nel 1925. Inoltre la presa di coscienza delle diversità etniche, culturali, è lievito per le autonomie locali e premessa per il bilinguismo e quindi per la comprensione internazionale: risultati a cui certo non mirava la politica mussoliniana! Nella scuola non si abrogavano le disposizioni introdotte con la riforma del 1923: fu sufficiente scoraggiare l’ulteriore pubblicazione dei “manualetti” dialettali, continuare nel forsennato spostamento degli insegnanti, per vanificare l’azione illuminata, umanistica, dei pedagogisti vicini a G. Lombardo-Radice (che si vide soppressa la rivista, poi fu privato della cattedra e infine costretto all’esilio dove morì).
Anche se il loro discorso era pedagogicamente moderato, ispirato all’idealismo e all’attualismo, era pur sempre una notevole premessa per il rinnovamento della scuola disponendola a essere “aperta” al territorio, e cioè a “pieno spazio”.
L’italianizzazione divenne sempre più goffa e violenta, massiccia e vessatoria. Divennero italiani i nomi di battesimo, i cognomi, i toponimi; per questi ultimi ricordiamo in Valle d’Aosta i Ponte San Martino, San Vincenzo, Castiglione, Cormaiore…; in Val Susa, Oulx, Sauze, Venaus diventarono Ulzio, Salice, Venalzio; anche in area piemontese, Druent diventò (e purtroppo è rimasto) Druento e in Val Chisone Duc… diventò Duce!
Nella Venezia Giulia si bruciarono i centri di cultura slovena (teatri, circoli); sui tram di Trieste vi era la scritta “Vietato sputare per terra e parlare sloveno”; vi furono insegnanti che giunsero fino a sputare in bocca allo scolaro cui era sfuggita una parola “slava”! I giovani di leva erano spediti all’altro capo dello stivale e, non conoscendo che la propria lingua (tedesca o slovena), non erano in grado di scrivere a casa, in quanto l’italiano era la sola lingua ammessa nella corrispondenza militare. La problematica delle minoranze linguistiche, che oggi appare a molti come marginale, quasi “esotica”, fu invece ispiratrice della più indomita resistenza, sin dai primi anni della dittatura. Gli sloveni hanno dato il più alto numero di condannati a morte e di condanne in seguito a processi politici per “reati contro la sicurezza dello Stato”.
La Dichiarazione di Chivasso
Arriviamo così alla seconda guerra mondiale e alla Resistenza. La problematica delle minoranze linguistiche costituì uno dei momenti fondamentali della lotta di liberazione, purtroppo dimenticato sia dalla politica del dopoguerra che dalle analisi storiografiche. D’importanza pari al “Manifesto di Ventotene”, che è alla base del federalismo europeo, è la “Dichiarazione di Chivasso”1 redatta il 19 dicembre 1943 da sei rappresentanti degli insorti delle vallate alpine (due valdostani, tra cui Emile Chanoux, martire della resistenza valdostana e ispiratore del documento, e quattro valdesi), nella quale si richiedevano, per il nuovo Stato che sarebbe sorto dalla Liberazione, autonomie politiche, amministrative, culturali, realizzando la sintesi delle istanze di autonomia e di federalismo tradizionali per la civiltà alpina. Le Alpi infatti sono viste dall’Italia ufficiale (e cioè da una prospettiva “romana”) come confine naturale, come “sacra barriera”… mentre, in realtà, non hanno mai diviso “naturalmente” le popolazioni che vi abitano: dalle Alpi Marittime alle Giulie, abbiamo le medesime etnie nei due versanti; occitani (provenzali), franco-provenzali, tedesco-vallesani (“walser”), retoromanci e ladini, tirolesi, tedeschi carinziani, sloveni. L’economia è sempre stata complementare per i due versanti alpini, e “di là” si passava, senza passaporto, per la ricerca di nuovi pascoli e per le transumanze, per i lavori stagionali e nomadi (taglialegna, carbonai, spazzacamini, tagliapietre, selciatori, muratori…) o magari anche per cercar moglie. I confini politici spezzarono poi questa comunanza di vita e di cultura, affrettando la decadenza e il degrado della società alpina. Il contrabbando fu la logica reazione popolare all’imposizione delle barriere doganali e a un’economia che privilegia le scelte protezionistiche e autarchiche a scapito degli scambi, vitali per le popolazioni di montagna.
Nel 1945 alcune di queste istanze si presentarono prepotentemente sulla scena politica: in Valle d’Aosta si parla sempre più di annessione alla Francia, ed è per scongiurarla che le viene riconosciuto con decreto luogotenenziale lo statuto d’autonomia. L’Assemblea costituente affronterà con impegno il problema delle minoranze linguistiche, affidandolo ad apposita sottocommissione presieduta dall’on. Lucio Luzzatto. E molto interessante leggere la conclusione di questi lavori.
I costituenti distinsero le minoranze in due categorie: la prima (che poi sarebbe seconda, come rilevanza politica e giuridica) e la seconda.
Minoranze di serie A e di serie B
Le minoranze della prima categoria sono costituite dalla diaspora degli albanesi nell’Italia meridionale (un centinaio di comunità, per un totale di circa 100.000 persone, sparse dagli Abruzzi sino alla Sicilia), giunti nella penisola a varie riprese (a cominciare dal XV secolo) per sfuggire ai turchi invasori dell’Albania; dalle tre superstiti comunità croate del Molise (Acquaviva Collecroce/Kruc, Montemitro/ Mundimitar, San Felice Slavo) giunte dalla Croazia sfuggendo, come gli albanesi, l’invasione dei turchi; le comunità greche della Puglia (Calimera – che in greco significa “Buon giorno” – Martano, Castrignano de’ Greci, Martignano, Zollino, Sternatia, Soleto, Corigliano, Melpignano, tutti in provincia di Lecce, nel Salento) e di Calabria (Roghudi, oggi abbandonata per gli smottamenti, con la frazione di Ghorìo; Roccaforte del Greco; Bova; Confoduri con la frazione di Gallicianò, villaggio senza strade e in tragica situazione di isolamento: tutti in provincia di Reggio, nella Jonica), circa 15.000 in tutto. Le origini di queste comunità sono molto dibattute: il famoso linguista Gerald Rohlf sostiene che si tratti di antichissimi insediamenti resti della Magna Grecia; altri invece le ritengono dovute a recenti immigrazioni, analoghe a quelle degli albanesi e dei croati. Sempre alla prima categoria appartengono le isole tedesche delle Alpi: i walser della Valle d’Aosta (i due Gressoney ed Issime) e del Piemonte (Alagna, Rima, Rimella, Macugnaga, Formazza), i “cimbri” (in realtà Austro-bavaresi) dei tredici comuni veronesi (di cui soltanto Giazza/Ljetzan rimane custode dell’antica lingua) e dei sette comuni vicentini (la lingua è conservata ancora a Roana/Roboan e a Rotzo/Rotz), i “mòcheni” della
Val Fersina/Feersental e i “cimbri” di Luserna (gli uni e gli altri in provincia di Trento), i carinziani di Sappada/Pladen (Belluno) e del Friuli (Timau/Tichelwang, Sauris/Zahre e Tarvisio); infine i catalani di Alghero (Sardegna). In totale circa 150.000 “alloglotti” che mai posero allo stato problemi “nazionali” dimostrandosi “italiani in tutto ad eccezione della lingua”.
Le minoranze della seconda categoria sarebbero tali nella pienezza del termine poiché hanno posto “seri e gravi problemi” all’Italia, come dimostra la storia contemporanea. Queste minoranze sono rappresentate dai “francesi” della Valle d’Aosta e delle valli “valdesi” (in realtà, non francesi ma occitane), dai tedeschi del Sud Tirolo e dai ladini delle Dolomiti, dagli sloveni dei confini orientali (a quel tempo ancora molto incerti). Per queste comunità, assommanti a varie centinaia di migliaia di cittadini, lo stato italiano sorto dalla Resistenza si poneva il problema del risarcimento morale, poiché si trattava di riparare ai soprusi e alle angherie patite dalle suddette popolazioni per il solo fatto di parlare ostinatamente la propria lingua materna e di contestare, nella maggioranza dei casi, il mancato riconoscimento della loro nazionalità diversa dall’italiana. Per queste minoranze non era sufficiente affermare la libertà di usare la propria lingua: occorreva altresì garantirne in senso positivo il libero sviluppo culturale, e assicurare loro una tranquillità economica e sociale con appositi strumenti, quali appunto l’autonomia.
“Tutela negativa” e “tutela positiva”
Per le minoranze della prima categoria era invece considerato sufficiente assicurare la tutela “negativa”, cioè garantire che non avrebbero patito discriminazioni a causa della loro lingua “diversa” che, comunque, esse avrebbero potuto continuare tranquillamente a parlare.
Questi concetti di “tutela negativa” e di “tutela positiva” furono poi recepiti dalla Carta costituzionale negli articoli 2, 3 e 6. L’art. 2 sancisce il principio pluralista: “La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nella formazione sociale ove svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
L’art. 3 scende nel particolare e afferma: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” Il “senza distinzione di lingua” assicura la “tutela negativa”, nel senso cioè che, per il fatto di parlare una lingua diversa dall’italiana, il cittadino non patirà alcun danno. Una tutela di questo genere va benissimo per le minoranze religiose (come i Valdesi, per esempio) le quali non richiedono affatto un intervento dello Stato a loro favore, ma soltanto che lo Stato non se ne occupi lasciandole libere di svolgere la loro testimonianza.
Ma per la minoranza linguistica una tutela siffatta non è sufficiente, perché deve garantire non soltanto una mera sopravvivenza, ma il libero sviluppo. L’art. 3 recita proprio tale importante principio: “È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’ordinamento sociale, economico e politico del paese.” Da questo proclamato impegno di “rimuovere gli ostacoli che impediscono il libero sviluppo” delle comunità che parlano lingue diverse scaturisce l’impegno conseguente sancito dall’art. 6 e cioè la “tutela positiva”: “La repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.
Se non ci fosse l’affermazione della volontà di “rimuovere…” eccetera dell’art. 3, comma 2, il lettore superficiale potrebbe vedere nell’art. 6, che prevede “apposite norme”, una contraddizione con il principio di eguaglianza sancito nel primo comma dell’art. 3 (“senza distinzione di lingua”). Ma, appunto, la legislazione speciale prevista dall’art. 6 è una necessaria tutela positiva per le minoranze in quanto, trovandosi in posizione di diversità e di debolezza (in quanto “minoranze”), per potersi assicurare il libero sviluppo necessitano di una apposita legislazione che riequilibri la situazione di partenza.
In uno stato di diritto, infatti, non è sufficiente assicurare che non ci sarà persecuzione, ma è necessario fornire gli strumenti affinché la comunità possa liberamente sviluppare la propria funzione, così importante sotto il profilo del pluralismo culturale. L’art. 6 è dunque una specificazione dell’art. 3. Ma se dall’affermazione dei “princìpi fondamentali” (quali appunto sono quelli sanciti dagli articoli 2, 3 e 6) passiamo all’attuazione pratica, e si scende all’analisi della tutela delle minoranze linguistiche in Italia, dobbiamo tristemente rilevare come l’art. 6 sia rimasto inattuato. Infatti la tutela realizzata dalla repubblica nei confronti delle minoranze è stata parziale e anche contraddittoria e discriminatoria.
Ma il dettato costituzionale è attuato?
L’attuazione non è mai derivata né motivata dal dettame costituzionale, dimenticato ma per “evitare il peggio”. La figlia del terrorista sudtirolese Klotz, deceduto alcuni anni or sono in Austria, rivendica al padre il merito di aver comunque giovato alla causa sudtirolese in quanto, senza l’azione dei terroristi, e cioè senza il ricorso alla violenza delle armi, il governo italiano non avrebbe concesso, poi, il “pacchetto” e cioè le misure concordate con le forze politiche e sociali di lingua tedesca per la tutela della minoranza.
Tale affermazione risulta tragicamente vera; sulle motivazioni della tutela abbiamo anche delle interpretazioni “autentiche”. Proprio negli anni caldi del Sud-Tirolo (1962), sindaci e amministratori delle cinque comunità tedesche del Piemonte rivolgevano una petizione al ministro della Pubblica Istruzione affinché fossero ripristinate, nelle rispettive località, le scuole bilingui così come era prima del 1915. Questa petizione fu consegnata all’on. Pastore, in quanto cittadino di Rima (Valsesia, provincia di Vercelli), e cioè di una delle comunità interessate.
Dopo essere stato più volte sollecitato, finalmente il ministro rispose a chi vi parla, su carta intestata “Consiglio dei ministri”, nel novembre (prot. n. 93500/cc4) in questi termini testuali: “La concessione di una seconda lingua oltre quella materna (sic!) è stata finora accordata esclusivamente a quelle regioni a statuto speciale che potevano rappresentare nell’immediato dopoguerra una grave minaccia per l’integrità dello Stato”.
A parte il fatto che si domandava proprio l’insegnamento della “lingua materna” e non di altra “seconda”, la morale è evidente: se non si “minaccia”, niente tutela; poiché i walser valsesiani sono bravi cittadini, e non minacciano, non avranno la lingua madre insegnata a scuola! In tal modo si dà evidentemente ragione alla signorina Eva Klotz: se suo padre non avesse “minacciato”, il Sud-Tirolo non avrebbe ottenuto nulla, alla faccia dell’art. 6 della Costituzione!
Abbiamo la controprova esaminando la tutela delle minoranze linguistiche in Italia: anziché derivare dal principio costituzionale, e da ragioni di intelligenza politica (nel senso che è una ricchezza per lo Stato il poter disporre di comunità naturalmente bilingui), è stata “concessa” alla Valle d’Aosta, come abbiamo detto, per scongiurare un’eventuale annessione alla Francia nell’immediato dopoguerra; alla provincia di Bolzano per tema che ottenesse di riunirsi al Nord-Tirolo, e in attuazione del trattato De Gasperi – Gruber che impegnava la repubblica italiana a concedere l’autonomia al Sud-Tirolo: il “pacchetto” sarà poi votato dal parlamento proprio per sconfiggere la piaga del terrorismo; agli sloveni della provincia di Gorizia, in quanto le scuole nella loro lingua furono istituite dai partigiani e già erano funzionanti quando la città fu definitivamente assegnata all’Italia; e agli sloveni della provincia di Trieste, perché l’Italia vi era obbligata dal trattato di pace (confermato da quello di Osimo).
Si tratta dunque di “costrizioni” dovute alla pressione internazionale, ai trattati o addirittura alla violenza: ma mai, purtroppo, ci si richiamò sovranamente alla Costituzione della repubblica che, in materia, è una delle più avanzate d’Europa (superata soltanto dalla Spagna odierna)! Tant’è vero che le altre minoranze, che abbiamo prima ricordato, non hanno avuto la benché minima tutela. Si giunge all’assurdo per cui la medesima comunità etnico-linguistica, ripartita in più province, ha un diverso trattamento a seconda delle località, persino quando esse facciano parte della medesima regione a statuto speciale!
Abbiamo così gli sloveni: tutelati in provincia di Trieste per gli obblighi di reciprocità con la Jugoslavia (tutela dell’italiano in zona B, e dello sloveno in zona A); meno tutelati in provincia di Gorizia, dove le scuole slovene sono una conquista della Resistenza; il nulla assoluto per gli sloveni della provincia di Udine. Eppure Trieste, Gorizia e Udine fanno parte della medesima regione Friuli-Venezia Giulia! Così neppure i ladino-friulani, compresi in quella regione, sono tutelati, benché l’art. 3 dello statuto regionale preveda la salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali di “tutti” i gruppi linguistici.
La provincia autonoma di Trento fa parte con quella di Bolzano della regione autonoma Trentino-Alto Adige: ma i gruppi ladini e tedeschi del Trentino sono privi di tutela (soltanto da pochi anni in Val di Fassa sono state istituite nella scuola dell’obbligo un paio d’ore di “cultura” ladina, del tutto inadeguate per il recupero e lo sviluppo della lingua). Alcuni comuni “finitimi” alla provincia di Bolzano furono annessi a quest’ultima; ma altri, perché più lontani, rimasero in quella di Trento, senza l’insegnamento della lingua materna a scuola: il diritto, dunque, è stato misurato non sul dettame costituzionale ma a chilometri! Ed è triste constatare che nessuna voce si sia seriamente levata per reclamare la tutela degli alloglotti del Trentino: neppure quella della “nuova sinistra” che si riproponeva un’azione libertaria al di fuori degli equilibri di potere etnico nelle due province.
I ladini della provincia di Bolzano (valli Gardena, Badia e Marebbe) sono invece tutelati evidentemente perché visti da Roma (e da Trento) in funzione di “disturbo” del gruppo tedesco; tant’è vero che non ci si cura dei ladini che rischiano, invece di intedescarsi, di italianizzarsi!
I tre comuni tedeschi della Valle d’Aosta non hanno alcuna tutela benché siano in una regione a statuto speciale; e così dicasi per gli albanesi di Sicilia e per i catalani in Sardegna (dove lo statuto speciale non prevede neppure la tutela della lingua sarda).
Abbiamo visto come la sottocommissione per le minoranze, in sede di Costituente, facesse la discriminazione tra minoranze di serie A, meritevoli di tutela, e di serie B, da ignorare. Ma siffatta discriminazione, fortunatamente, non compare nella Carta costituzionale: ne discende che tutte le minoranze vanno tutelate, e non soltanto quelle che “minacciano”. Le valli “valdesi”, considerate “francesi” (mentre sono occitane, cioè di lingua d’Oc: ma tale situazione era nota soltanto a pochi specialisti) in quanto il francese fu, come abbiamo detto, per tre secoli lingua di cultura, per i commissari costituenti meritavano di essere di serie A, probabilmente per il contributo dato alla Resistenza (anche con la “Dichiarazione di Chivasso” citata), ma furono invece totalmente dimenticate; così come ignorati (a livello politico non se ne conosceva neppure l’esistenza) gli altri Occitani delle valli di Cuneo e Torino.
Le minoranze resistono
La mancata attuazione del dettame costituzionale non ha dato luogo però unicamente alla resistenza violenta dei sudtirolesi; e vi sono stati casi di resistenza pacifica che meritano di essere ricordati: mi limiterò ai più emblematici e più strettamente legati all’opera di sensibilizzazione che dal 1964 svolse in Italia l’Associazione internazionale per la difesa delle lingue e delle culture minacciate (AIDLCM). Dopo aver partecipato alla sessione di lavoro del “Comitato federale per le comunità etnico-linguistiche e per la cultura regionale in Italia” (Sezione dell’AIDLCM per la repubblica italiana) a Roana/Roboan (Vicenza), il sindaco di Sappada/Pladen (comunità tedesca del Cadore, Belluno), G.Piller Puicher, ebbe l’iniziativa di scrivere “Gemeinde Haus” accanto a quella di “Municipio” sulla Casa del comune, nonché di mettere la tabella bilingue “Sappada/Pladen” (1974) anche in attuazione della legge regionale del Veneto dell’8-4-1974 per la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico del Veneto. Immediatamente il viceprefetto di Belluno, De Luca, intima (trasmettendo l’ordine anche alla compagnia dei carabinieri!) di rimuovere ogni scritta in tedesco (lettera protocollo n. 987 del 23 agosto 1974). Due anni dopo, rinnovatasi
l’amministrazione, il Consiglio comunale delibera ancora di mettere le iscrizioni bilingui (deliberazione n. 52 del 2.8.1976). Questa volta è il Comitato regionale di controllo (prot. n. 1821) che con una comunicazione, in cui la grammatica italiana era violentata senza pietà, boccia la delibera e giunge persino a “epurare” la legge regionale da ogni finalità “linguistica” facendo propria la iniziativa illegittima del viceprefetto De Luca di cattiva memoria: l’art. 6 della Costituzione non riguarda i Tedeschi di Sappada! Il caso fu ampiamente riportato dai giornali e il Comitato federale dell’AIDLCM fece, proprio a Sappada/Pladen, un memorabile convegno in quello stesso 1976.
Nel 1978 lo scrittore e poeta di Alghero Rafael Carria, dipendente dell’aeroporto di Sassari, ebbe l’iniziativa di aggiungere al benvenuto in inglese e francese anche quello catalano: lingue “povere”, ma di casa, e quindi particolarmente gradite ai rimpatriati sardi, i quali hanno diritto a sentire nella propria lingua benvenuto almeno quanto le “colonie” di lingua inglese e francese dell’Aga Khan e della sua corte. Il fermo atteggiamento del Carria, che non voleva desistere dai suoi principi, originò una causa di lavoro: la magistratura gli diede torto; solo le lingue ricche e potenti hanno diritto di essere usate all’aeroporto (così come sulla copertina dello statuto del PR, dove non vedo catalano, basco, gaelico, bretone, frisone…).
Il sindaco sardista di Bauladu, eletto nel 1980, rifiuta di giurare in italiano e pretende invece di esprimersi in sardo. Il prefetto glielo vieta: sapete chi è il solerte prefetto nemico dell’art. 6? De Luca! Salvo sia un improbabile caso di omonimia, si tratta del “vice” di Belluno – quello che voleva mandare i carabinieri a rimuovere le scritte tedesche a Sappada – che ha fatto carriera e che, probabilmente, non si aspettava di incontrare in Sardegna una “grana” analoga a quella scoppiata in Cadore. Ben gli sta.
A Trieste il profrssor Samo Pahor, docente in una scuola media superiore slovena , il 10 gennaio 1974 diede a un vigile urbano a Trieste le proprie generalità in sloveno, rifiutandosi di darle in italiano, avvalendosi dunque delle disposizioni sul bilinguismo comprese nel trattato di pace, pretendendo nel contempo un interprete ufficiale. Con sentenza del 13-12-1974, il pretore di Trieste lo condannava, decretando che Samo Pahor, essendo insegnante dipendente dal ministero della Pubblica Istruzione, “non poteva ignorare l’italiano”. Ne consegue che egli è l’unico cittadino italiano che può vantare la conoscenza della lingua italiana per sentenza della magistratura. Malgrado ciò, nel processo d’appello, il professor Pahor insistette nell’esprimersi in sloveno, sicché il tribunale trasmise gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunciasse sulla legittimità dell’art. 137 del Codice di procedura penale. La corte con sentenza 20.11.1982 dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale sull’obbligatorietà dell’uso della lingua italiana, sostenendo però che gli appartenenti al gruppo etnico sloveno possono usare la loro lingua anche nei rapporti con i rappresentanti della pubblica autorità, ciò anche in assenza di una legge di tutela della minoranza. Ciò nonostante, il tribunale di Trieste con sentenza del 4-3-1982 conferma quella del pretore e condanna Samo Pahor a 60.000 lire di multa per aver rifiutato di rispondere in italiano a un vigile; non solo, poiché durante il dibattimento egli insisteva “per l’ennesima volta a esprimersi in sloveno, è stato allontanato dall’aula perché disturbava il regolare svolgimento del dibattimento” (testuale, dalla sentenza!). Da ciò deriva che gli appartenenti alla minoranza slovena non hanno il diritto di usare la lingua materna nei rapporti con l’autorità pubblica contro quanto disposto dai trattati internazionali, dalla Costituzione e dallo statuto regionale.
Ma la decisione della Corte costituzionale, se non è servita per Samo Pahor, subito dopo ha giovato a un altro cittadino imputato di un fatto analogo: Gorazd Vesel, direttore responsabile del quotidiano sloveno di Trieste “Primorski dnevnik”, si è trovato sul banco degli imputati perché nei due giudizi precedenti (risalenti rispettivamente a sette e cinque anni fa) si è rivolto alla corte nella propria lingua materna, violando così, secondo il parere del procuratore generale, l’art. 137 del Codice di procedura penale. Il 20 maggio 1982 il pretore Trampus, richiamandosi appunto all’interpretazione di tale articolo contestato, data dalla Corte costituzionale nella sentenza del 20 gennaio, ha prosciolto l’imputato perché l’appartenente alla minoranza slovena può parlare nella propria lingua in giudizio, trattandosi di un suo diritto inalienabile.
Che cos’è una minoranza linguistica
Abbiamo così, sullo stesso argomento, due decisioni della magistratura italiana di Trieste del tutto contrapposte, emesse nel succedersi di un paio di mesi! La questione del “diritto all’interprete” non è soltanto di “principio” ma ha anche un risvolto socio-economico, poiché è evidente che l’utilizzo di interpreti crea posti di lavoro per la minoranza ed è quindi uno stimolo a mantenere la lingua e a frequentare scuole dove l’insegnamento della lingua materna è garantito.
Ma le minoranze sono soltanto quelle che parlano tedesco, sardo, francese, occitano, sloveno, ladino (dolomitico e friulano), albanese, greco, croato? Quando una minoranza linguistica si può definire tale?
A mio avviso il dettame costituzionale non va interpretato restrittivamente (del resto il coinvolgimento di Friulani, Occitani e Sardi rappresenta di per sé un allargamento della problematica, poiché, come abbiamo visto, queste “minoranze” – tali nei confronti della maggioranza di lingua italiana – nell’intenzione del legislatore non erano comprese nelle due categorie e quindi, chiaramente, a esse non si riferiva l’art. 6 della Costituzione), ma in modo dinamico e, se vogliamo, in senso libertario: per cui non si deve attendere che i linguisti si mettano d’accordo sulla distinzione lingua/dialetto, cosicché alcuni idiomi sarebbero “lingua” e dunque meritevoli di tutela, mentre altri “dialetto” e quindi destinati a soccombere. Altrimenti si finirebbe per “contare” gli specialisti favorevoli a una tesi o all’altra, e per vantare, in difesa della propria “ lingua”, l’avallo di questo o quell’uomo di scienza (come se si trattasse di proporre una pasta dentifricia riconosciuta valida da 95 dentisti su 100). A un’interpretazione che ci porta alla “concessione” discesa dal Palazzo (octroyée, direbbero i Francesi) a favore di una comunità, preferisco quella che sottolinea l’importanza di “riconoscersi” nel dettame costituzionale. In altre parole l’art. 6 riguarda tutti coloro che, coscienti di possedere una lingua diversa, ne pretendono la tutela. Chi decide deve essere colui che patisce la discriminazione: non lo scienziato e neppure il politico; chi non vuole che la propria lingua sia “tagliata” ha diritto alla parola.
“Lingua” e “dialetto”
La tendenza di alcuni difensori delle “lingue tagliate” (come Sergio Salvi, autore di un famoso saggio omonimo edito da Rizzoli) è, per loro stessa definizione, “nazionalitaria”: sarebbero le “nazioni proibite” le sole legittimate ad avere una “lingua” che non si deve “tagliare”. Sembra invece ad altri (per esempio G. Barbiellini Amidei, autore del Minusvalore, Rizzoli; Ulderico Bernardi, di cui si veda, specialmente, Le mille culture, Coines, Firenze; e, tra i linguisti, Tullio De Mauro) che il discorso vada impostato sulla riappropriazione che le classi dominate hanno il diritto di richiedere; riappropriazione della lingua e della cultura degradate, e poi a poco a poco eliminate, dalle classi dominanti.
La distinzione lingua/dialetto è una trouvaille borghese: non c’è alcun criterio scientifico idoneo a stabilire quando una parlata sia “lingua” e quando “dialetto”; in effetti, a seconda dei tempi e dei luoghi, il medesimo strumento linguistico può essere, alternativamente, considerato nelle due diverse definizioni.
Storicamente possiamo per esempio ricordare le vicende della lingua d’oc; “lingua”, appunto, quando tra tutte le parlate romanze divenne la più illustre, al tempo dei trovatori, sino al XIII secolo, quando l’Occitania (oggi Francia meridionale) venne messa a ferro e fuoco dai “crociati” e cioè dal papa e dal re capetingio (Luigi IX, che per questi meriti poi fu fatto santo) i quali, presa a pretesto l’eresia catara (o albigese), conquistarono l’Occitania per sottometterla al potere regale di Parigi. Decadde quindi a povero dialetto ma, nella metà del secolo scorso, fu letterariamente riscattata da Frédéric Mistral e dai suoi felibri e oggi, grazie soprattutto alla sfida della giovane Occitania impegnata e militante, ha riacquistato la dignità di lingua.
Ma non soltanto nel tempo può variare lo status di un idioma; ciò può avvenire contemporaneamente in luoghi diversi. Così il catalano era dialetto nella Spagna franchista, ma è pur sempre stato lingua nel principato d’Andorra; il gallego era a livello di dialetto in Spagna, ma è la lingua del Portogallo dove, appunto, si chiama “portoghese”. L’olandese è la lingua ufficiale dei Paesi Bassi, e così pure (ma in seguito a un’esasperata conflittualità) è lingua (il fiammingo) nella metà settentrionale del Belgio; ma è dialetto nelle Fiandre francesi (Westoek) ed è volgare vernacolo, privo di rilevanza amministrativa e letteraria, in Germania (il Plattdatsch).
Il retoromancio (o ladino) è lingua “ufficiale” nel Canton Grigioni, è quarta lingua nazionale della Confederazione elvetica, è ancora lingua nella provincia di Bolzano, ma è dal potere italiano relegato al rango di dialetto nelle altre valli “italiane” (?!) delle Dolomiti e del Friuli. Se un giorno Ranieri si svegliasse con l’idea di redigere gli atti ufficiali del principato nel “dialetto” ligure del luogo, il monegasco diventerebbe “lingua” (tant’è vero che la chiesa cattolica, che ostacola la messa in friulano e in piemontese, così come prevedibilmente l’ostacolerebbe in ligure, celebra invece nel principato di Monaco anche in monegasco!)
Si tratta, allora, di un fatto squisitamente politico, perché è il potere che stabilisce quando una lingua è tale, oppure quando convenga lasciarla morire come dialetto. In termini pasoliniani, potremmo dire che la lingua è lo strumento linguistico del Palazzo, mentre il dialetto è lo strumento linguistico alternativo, la Cenerentola che si vorrebbe condannare a morte di focolare (il dialetto buono per il “mondo dei vinti”, per la società agricola arcaica; ma non per l’amministrazione pubblica, la scuola, la chiesa, la lirica autentica… eppure la lingua della Bibbia è divenuta quella di uno stato moderno!) mentre le sue sorellastre (le lingue romanze più fortunate) vanno, con la matrigna, alle feste (e ai fasti) del Palazzo reale, dove i valletti dalla livrea purpurea, usi per deferenza a camminare a ritroso, erano in piemontese chiamati gàmber ross…
Al potere fa comodo togliere di mezzo quanto ancora gli è alternativo, riducendolo prima in posizione subalterna per poi eliminarlo più facilmente. La lingua “mandarina” (cioè dei funzionari del potere accentratore) è, a tal fine, strumento tra i più idonei. Degradando la parlata da lingua a dialetto, le si toglie ogni utilità: si esercita così un’operazione tipica della tecnica del consenso, in quanto l’interessato, ormai convinto che la propria lingua non ha alcun valore, la sacrifica senza resistenza… credendo, anzi, di emanciparsi.
Esiste, a mio parere, un uso capitalistico della lingua che è consequenziale al sistema consumistico del neocapitalismo, bisognoso di trasformare i produttori di beni alternativi in consumatori, così i “produttori di cultura” (quali, appunto, sono coloro che parlano “diverso”) in “consumatori” di una cultura omologata, omogeneizzata, premasticata e diffusa dai mass media già controllati dal potere. Il fenomeno è palese sotto il profilo economico: le economie alternative (artigianato, agricoltura) sono disincentivate perché non funzionali ai grossi concentramenti di capitale. Così economia e cultura vengono fagocitate dal sistema. Là dove c’è una forte coscienza della diversità culturale e linguistica le dittature hanno avuto vita dura: infatti il franchismo ha trovato la resistenza più indomabile proprio in Euskadi (Paesi Baschi) e in Catalogna. Così pure la grandeur dell’Exagone francese, De Gaulle e i suoi successori, e la politica dell’Europa delle Patrie, contrapposta a quella dei popoli, debbono fare i conti con le realtà bretoni, occitane, corse, e in genere con tutte le “nazioni proibite” fagocitate dall’imperialismo capetingio, e le minoranze linguistiche tuttora presenti entro i confini della Francia.
Quando le classi dominate dovranno presentare il conto delle espropriazioni subite, sulla lista ci dovrà essere, oltre al valore dei beni prodotti (il plusvalore accumulato a profitto del capitale), alla salute, all’istruzione, alla dignità umana, anche il valore della cultura originaria, degradata (appunto: da “valore” linguistico a “minusvalore” dialettale; da “bilinguismo” a “diglossia”) e poi eliminata: la rapina del minusvalore dopo quella del plusvalore, come denuncia il sociologo Barbiellini Amidei.
Il concetto “tu non parli una lingua, ma un inutile dialetto; la lingua importante l’impari da noi nelle nostre scuole” è strumentale per il colonizzatore; una pratica collaudata nel Terzo Mondo quando si contrapponevano le lingue di Shakespeare, Racine, Cervantes, Camoes, Goethe, Dante, ai poveri linguaggi “barbari” delle popolazioni extraeuropee.
Un discorso analogo (recuperato ogni tanto anche dal professor Tristano Bolelli sulla “Stampa”, per cui il piemontese è un dialetto perché non può vantare capolavori letterari… A parte l’opinabilità di tale giudizio, frutto forse anche di scarsa informazione, una lingua è tale prescindendo persino dal fatto di essere scritta: così lingue sono sempre state il quechua e l’albanese, anche prima di avere le loro letterature recentissime) serve per declassare a dialetti le lingue estranee al Palazzo e per relegarle nella letteratura “vernacolare” e nell’utilizzo folkloristico essenzialmente “museificante” e quindi reazionario. Purtroppo anche taluni che si collocano a sinistra, avendo perduto ogni strumento linguistico alternativo, vedono nel passaggio dal “dialetto” alla “lingua” un momento di emancipazione: come se per acquisire una lingua fosse necessario dimenticare quella originaria (quindi un “o…o…” anziché un possibilissimo “e…e…”), e senza rendersi conto che oggi il problema delle classi dominate non si pone tanto in termini di “emancipazione”, quanto invece, di “alienazione”, contro la quale occorre recuperare ogni possibile antidoto.
Posta la tematica in questi termini, mi sembra erroneo, deviante e anche mistificatorio continuare a disquisire se questa o quella parlata siano lingua oppure dialetto. Quando si tratta di un idioma cui è praticamente vietato l’uso pubblico e ufficiale (amministrazione, scuola, chiesa), sebbene diverso dalla lingua statale (impropriamente chiamata “nazionale”), è chiaro come la posizione sia quella subordinata del “dialetto”… ma è chiaro, altresì, che tale status può essere dinamicamente riscattato; infatti, acquisendo la coscienza del “valore” di quello strumento, ogni comunità è legittimata a chiederne il riscatto con un impegno, con una lotta che costituiscono riaffermazione dell’integrità dell’individuo e della cultura della comunità.
Soffocare il bilinguismo naturale, oltre che una violenza inaccettabile, è anche un danno economico. Perché, per esempio, i walser (cioè i tedeschi del Piemonte e della Valle d’Aosta) non dovrebbero poter usufruire di una scuola bilingue, mentre chi abita a Torino e ha possibilità economiche può mandare i figli a imparare il tedesco nelle scuole private? Le nostre comunità, già così povere economicamente, potrebbero ricavare indubbi vantaggi da una scuola che sviluppasse le conoscenze tradizionali del luogo. Oggi il possedere una lingua straniera e, nel caso dei walser, il tedesco, non vale meno di una laurea… E così dicasi per i croati del Molise (l’Italia non abbonda di slavisti!), gli albanesi e i greci della diaspora meridionale, le cui conoscenze “spontanee” potrebbero essere recuperate per gli scambi diplomatici, economici, culturali con gli stati d’origine.
Pubblicato nel 1984 su: