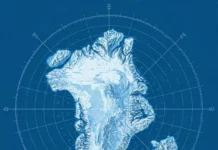Quand’è che un movimento di liberazione rischia di trasformarsi in milizia e dalla difesa della popolazione passa prima al controllo e poi magari alla repressione?
E quando avviene che un gruppo sorto per l’autodifesa diventa setta sanguinaria?
O anche: quand’è che un sindacato si trasforma prima in corporazione e poi (vedi negli usa) in organizzazione mafiosa?
Non sempre, ma talvolta succede.
Troppe volte a dire il vero, anche ai migliori (ma perlomeno in passato rimandavano alla presa al potere).
Ricordate le parole di Mandela appena uscito dal carcere dove si coglieva un preciso riferimento alle discutibili azioni intraprese dalla moglie Winnie (peraltro militante antiapartheid di primo piano)? Non mi riferisco a qualche “deviazione, sbavatura o deriva militarista”. Ma a qualcosa di strutturale, definitivo. Una degenerazione irreversibile. Come avvertiva ancora negli anni settanta Jean Ziegler quando scriveva che “il rivoluzionario è un uomo di passaggio”, non certo immune o vaccinato dai virus del potere, della violenza.
Detto questo, ricordarsi di resistere, ma anche di vigilare.
È notizia recente che nei campi profughi rohingya in Bangladesh, soprattutto in quelli di Ukhia e Teknaf (nella zona di Cox’s Bazar dove in una trentina di campi vivono circa un milione e duecentomila rifugiati di religione musulmana), la milizia denominata arsa (Arakan Rohingya Salvation Army) agisce molto violentemente. Sia contro altri profughi rohingya, considerati dissidenti e oppositori, sia nei confronti degli abitanti del luogo (con sequestri a scopo di estorsione e saccheggi), una popolazione essenzialmente contadina e pacifica. Stando ai dati ufficiali, diffusi dalle forze dell’ordine, dal 2018 vi sarebbero almeno 120 casi di persone assassinate e oltre 200 sequestrate.
Una precisazione. L’arsa, nato come movimento indipendentista ma in seguito destinato a subire l’influenza del radicalismo islamico, si richiama all’Arakan (oggi denominato Stato Rakhine), una regione nell’ovest del Myanmar: abitata in prevalenza da rohingya, ma da cui in gran numero son dovuti fuggire a causa delle persecuzioni governative di natura settaria (etnica e religiosa). Non è poi irrilevante che il fondatore, Ataullah Abu Ammar Junjuni (nome di battaglia Hanz Tohar) sia nato in Pakistan. Così come altri esponenti, figli di rifugiati (quindi di seconda o terza generazione) che a migliaia si erano riversati in Pakistan vivendo in condizioni disagiate e precarie, sia dal punto di vista umanitario sia sanitario ed educativo.
Inoltre già da alcuni anni (almeno dal 2018) nei campi profughi si svolgerebbero attività di propaganda e reclutamento da parte del gruppo islamista Jamaat-ul-Mujahideen.

I fatti più recenti risalgono all’8 gennaio 2023 quando è stato assassinato Mohammad Salim. Invece un altro leader locale, Abdul Basar (dopo essere stato minacciato di fare la stessa fine del suo amico, Ahmad Rashid, ucciso recentemente) ha dovuto rifugiarsi in un luogo segreto. Risale invece a oltre un anno fa l’uccisione di un altro leader rohingya, Muhibullah.
Stando sempre ai rapporti ufficiali, le forze dell’ordine del Bangladesh non sarebbero in grado di agire efficacemente contro tale milizia che avrebbe le proprie basi, oltre che nel Myanmar, lungo la “Linea zero” (area di Tumbru) sul confine tra Bangladesh e Myanmar. Altre basi sarebbero nascoste nelle foreste di Teknaf.
L’arsa sarebbe in grado di autofinanziarsi con il contrabbando, soprattutto di oro, e il narcotraffico (vedi la “droga della pazzia”).
Nello stesso periodo di inizio anno, quattro contadini venivano sequestrati a Lechuaprang e – almeno finora – soltanto tre sono stati rilasciati dopo il pagamento di un riscatto di 600.000 taka (oltre 5000 euro). Per liberare anche l’ultimo veniva richiesto un milione di taka (9000 euro).
Ovviamente tutto questo non può far altro che alimentare l’ostilità delle popolazioni indigene nei confronti dei rifugiati. Molti dei quali comunque (a causa sia delle difficili condizioni in cui versano, sia per le prepotenze subite dall’arsa e da altri gruppi armati) vedrebbero favorevolmente un ritorno in Myanmar, nel Rakhine.
Significativo che le milizie si oppongano invece a tale soluzione. Temendo forse, qualora i campi profughi di svuotassero o comunque si ridimensionassero, di perdere una fonte di reddito e un potenziale “serbatoio” di aderenti.