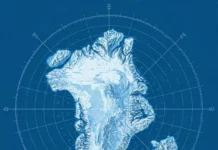Per secoli l’Europa centrorientale ha rappresentato il fulcro dell’ebraismo mondiale, dominato dalla componente aschenazita: si stima che nel ‘500 tre quarti degli ebrei vivessero nell’allora Confederazione polacco-lituana. Lo Yiddishland – regione storica in cui erano concentrate le comunità di lingua yiddish – abbracciava un ampio territorio che andava dalla Polonia alla Russia e dal Baltico fino al Mar Nero, all’interno del quale si contavano numerosi shtetl, i tipici insediamenti dove risiedeva gran parte della popolazione ebraica.
Tale panorama, sopravvissuto nei secoli nonostante le avversità, venne completamente stravolto dall’Olocausto nazista, la cui furia genocida spazzò per sempre gli shtetl aschenaziti. Inoltre, l’emigrazione di massa verso Israele – stimolata da fattori quali antisemitismo popolare, autoritarismo comunista e difficoltà socioeconomiche – diede il colpo di grazie alle comunità ebraiche sopravvissute, ormai ridotte al lumicino.
A oggi l’unico shtetl rimasto si trova in Azerbaigian, una nazione caucasica ai confini tra Europa e Asia. Il centro abitato di Qırmızı Qəsəbə (in russo Krasnaja Sloboda), in effetti, costituisce l’unico insediamento a maggioranza ebraica situato al di fuori del territorio israeliano e statunitense. Gli abitanti locali, nella fattispecie, appartengono a un gruppo etno-religioso noto come “ebrei della montagna”, radicato da oltre mille anni nel Caucaso meridionale.
L’ebraismo azerbaigiano
La comunità ebraica in Azerbaigian, i cui membri oscillano tra le 5000 e le 30.000 unità, è formata da tre gruppi distinti: ebrei della montagna, aschenaziti e georgiani. Gli ultimi due – stanziati soprattutto in città come Baku – migrarono nel Paese caspico tra XIX e XX secolo, quando il Caucaso meridionale era parte dell’impero russo e dell’Unione Sovietica. I primi, invece, rappresentano il gruppo ebraico più numeroso e antico residente sul territorio azero, distinto da quelli aschenazita e georgiano in virtù di storia, lingua e tradizioni.
La più remota attestazione di tale presenza è rappresentata dai resti di una sinagoga risalente al VII secolo d.C., rinvenuta dagli archeologi nel 1990. Eppure, la tradizione fa risalire le origini di questa popolazione alle dieci tribù perdute d’Israele, deportate nel cuore della Mesopotamia dall’impero assiro nell’VIII secolo a.C. Successivamente, questo gruppo diasporico si sarebbe trasferito nel Caucaso durante i periodi arsacide e sasanide, dando vita a una comunità dalle caratteristiche peculiari.
 Non mancano però teorie alternative: per esempio, alcuni autori sostengono l’ipotesi di una conversione al giudaismo da parte di autoctoni caucasici; talaltri, invece, collegano la minoranza israelita ai cazari, un popolo turcofono che abbracciò – seppur in parte – l’ebraismo durante il medioevo.
Non mancano però teorie alternative: per esempio, alcuni autori sostengono l’ipotesi di una conversione al giudaismo da parte di autoctoni caucasici; talaltri, invece, collegano la minoranza israelita ai cazari, un popolo turcofono che abbracciò – seppur in parte – l’ebraismo durante il medioevo.
Gli ebrei della montagna parlano il giudeo-tat o juhuro, un dialetto della lingua tat tradizionalmente impiegato da persone di fede giudaica. Il tat è l’idioma materno dell’omonimo gruppo etnico musulmano – diffuso in Azerbaigian e Daghestan – acquisito anche da semiti caucasici e piccoli gruppi cristiano-armeni. Si tratta di una lingua affine al persiano dal quale diverse tra tardoantico e medioevo, tanto che al momento le due parlate non risultano mutuamente intelligibili. Nello specifico, lo juhuro ha subìto non solo influenze turche, persiane e russe – riscontrabili pure nelle varietà adoperate dai musulmani – ma anche considerevoli apporti derivati da ebraico e aramaico.
Nondimeno, secondo l’Atlante delle lingue del mondo in pericolo – redatto nel 2009 dall’unesco – il giudeo-tat è considerato in pericolo di estinzione, dato che nell’ultimo secolo russo e azero si sono affermati a scapito della parlata tradizionale, spesso sconosciuta ai più giovani. D’altronde, né l’Unione Sovietica né l’Azerbaigian indipendente riconoscono ufficialmente le varietà tat, escluse dal sistema scolastico e dalla pubblica amministrazione.
La Gerusalemme del Caucaso
Nel 1742 Huseynali Khan, sovrano del Khanato di Quba, permise agli ebrei di costruire una nuova cittadina alle porte della capitale, garantendo protezione alla minoranza religiosa. Sotto la dominazione zarista la borgata assunse il nome di Ebrejskaja Sloboda (“insediamento ebraico”), mutato in Krasnaja Sloboda (“insediamento rosso”) durante il periodo sovietico. Attualmente, invece, il villaggio è conosciuto con il toponimo azero Qırmızı Qəsəbə (“cittadina rossa”), affiancato da soprannomi come “piccola Gerusalemme” e “Gerusalemme del Caucaso”.
Ancora oggi gli abitanti frequentano sinagoghe e scuole ebraiche, mantenendo fede e tradizioni trasmesse dagli antenati. Nella località vivono circa 3500 persone, soprattutto ebrei della montagna i quali, comunque, convivono armoniosamente con famiglie musulmane. I membri di questa minoranza si considerano prima di tutto azerbaigiani, tanto che ci tengono a sottolineare la fedeltà verso la nazione d’appartenenza, dimostrata dalle vicende di Albert Agarunov, famoso soldato azero di fede ebraica caduto in battaglia durante la Prima guerra del Nagorno Karabakh.
Eppure il futuro di questa comunità appare incerto, insidiato da vistosi fenomeni migratori. Infatti, Qırmızı Qəsəbə contava 18.000 residenti durante l’epoca sovietica, calati a 3500 negli anni successivi all’indipendenza dell’Azerbaigian. Tale contrazione demografica va attribuita principalmente alle difficoltà socioeconomiche del Paese caucasico, che hanno spinto la maggioranza degli ebrei a trasferirsi in Israele, Russia e Stati Uniti d’America.
Inoltre, non mancano famiglie trapiantate a Baku da Qırmızı Qəsəbə: in effetti, la crisi del settore industriale e l’assenza di attività agricole incentivano l’emigrazione verso centri urbani o addirittura l’espatrio. La località si ripopola soltanto in occasione del Tisha b’Av, una giornata a cadenza annuale dedicata alla commemorazione dei lutti patiti dal popolo ebraico. Nonostante ciò, il centro abitato appare in condizioni migliori rispetto ai borghi limitrofi, suscitando l’invidia di quanti vivono nei secondi. Effettivamente, i cittadini dell’ultimo shtetl beneficiano degli aiuti elargiti dalla diaspora, tra i cui membri figurano miliardari come Telman Ismailov e Zarakh Iliev. Pertanto, gli ingenti flussi di denaro hanno finanziato parecchi lavori conservativi, permettendo così la valorizzazione dello shtetl.
Un’oasi di tolleranza?
La pacifica convivenza interreligiosa che contraddistingue Qırmızı Qəsəbə è spesso presentata come un esempio lodevole, soprattutto se paragonata alla situazione di molti Paesi musulmani – come Libia, Egitto e Siria – responsabili della persecuzione di minoranze ebraiche. Ciononostante, gli elogi rivolti a Baku contribuiscono a nascondere gli aspetti più oscuri del regime di Ilham Aliyev, attuale dittatore della nazione caucasica. Le autorità azere, infatti, strumentalizzano questa minoranza per edulcorare l’immagine dell’Azerbaigian, presentandolo come uno Stato tollerante e multiculturale. In realtà, tali aggettivi difficilmente possono essere affibbiati al Paese caspico, responsabile dell’espulsione di tutta la minoranza armena e della conseguente distruzione di chiese, monasteri e khachkar prodotti dalla comunità scomparsa.

Peraltro, la condizione di altre minoranze non sembra rosea. Lesghi, avari e talisci, ad esempio, subiscono da decenni politiche di assimilazione forzata, avviate dal regime sovietico e mantenute dopo l’indipendenza. Inutile dire, l’autocrazia degli Aliyev impedisce la libera espressione di sentimenti autonomisti e separatisti, incarcerando o assassinando attivisti come Ali Antsukhskiy, Igbal Abilov, Alikram Hummatov, Fakhraddin Aboszoda, Atakhan Abilov e Novruzali Mammadov.
Insomma, la retorica promossa da Baku intende ingannare l’opinione pubblica internazionale, vendendo al mondo intero un’immagine positiva e rassicurante del Paese. Purtroppo, tale operazione ha incontrato volenterosi sostenitori in molte nazioni occidentali, come rivelato dagli scandali sulla “lavanderia azera”. Difatti, negli ultimi anni l’Azerbaigian ha speso milioni di dollari per corrompere politici, giornalisti e accademici stranieri, nel tentativo di costruire dei gruppi d’interessi filo-azerbaigiani. Di conseguenza, le figure cooptate dalla macchina propagandistica tendono a ripetere le tesi sostenute da Baku, presentando la repubblica caucasica come un’oasi di tolleranza e multiculturalismo.
Oltre a ciò, la minoranza ebraica viene strumentalizzata per conquistare il sostegno dell’Occidente e cementare i rapporti con Israele, importante partner militare di Baku. Invero, negli Stati Uniti e in Europa diverse organizzazioni insistono sulla presunta amicizia che legherebbe il popolo ebraico all’Azerbaigian, sottolineando il rapporto cordiale coltivato dal secondo con Gerusalemme. Al contrario, la vicina Armenia – acerrimo nemico di Baku – è accusata di antisemitismo, nell’intento di danneggiare la reputazione di Erevan.
In conclusione, le relazioni tra ebrei e musulmani azeri – per quanto indubbiamente positive – sono strumentalizzate dalla dittatura azera nel nome di fini tutt’altro che encomiabili.