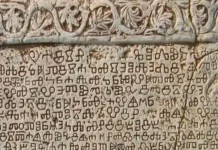Il tempo della festa che irrompe nella vita di tutti i giorni a carnevale è un momento straordinario di sospensione delle regole morali dominanti, ma è anche un tenace residuo di ataviche credenze spirituali, rimosse o contrastate dall’egemonismo borghese e urbanizzatore ma mai davvero estirpate.
Questa innegabile realtà di “cultura altra” viene oggi autorevolmente documentata dall’antropologo Mario Matto nel saggio sulle Tradizioni storico-antropologiche del carnevale, recentemente pubblicato dalle edizioni Botalla di Gaglianico: uno studio originale e rigoroso, per molti aspetti minuzioso e meticoloso.
 Pur incentrato sull’originalità del carnevale piemontese di Santhià, il libro approfondisce tutti i possibili aspetti delle feste popolari tradizionali che sono ancora ben vive anche nel Biellese, dove, spiega Matto, “i riti di carnevale derivano da antichi cerimoniali agrari di purificazione e propiziazione, connessi alle feste che segnavano l’inizio di un nuovo ciclo annuale o stagionale e che erano ispirate al bisogno naturale di ‘rinnovare il mondo’, espellendo il male (malattie, penurie agricole ecc.) accumulatosi durante il ciclo annuale e propiziando una fase nuova, migliore della precedente. Seppure con la naturale evoluzione che pervade tutte le cose, una parte di questi significati ancestrali è ancora presente nei carnevali attuali”.
Pur incentrato sull’originalità del carnevale piemontese di Santhià, il libro approfondisce tutti i possibili aspetti delle feste popolari tradizionali che sono ancora ben vive anche nel Biellese, dove, spiega Matto, “i riti di carnevale derivano da antichi cerimoniali agrari di purificazione e propiziazione, connessi alle feste che segnavano l’inizio di un nuovo ciclo annuale o stagionale e che erano ispirate al bisogno naturale di ‘rinnovare il mondo’, espellendo il male (malattie, penurie agricole ecc.) accumulatosi durante il ciclo annuale e propiziando una fase nuova, migliore della precedente. Seppure con la naturale evoluzione che pervade tutte le cose, una parte di questi significati ancestrali è ancora presente nei carnevali attuali”.
In effetti, il “Processo del Babi” (il rospo) iniziato con il carnevale di Biella del 1926, sembra essere la riesumazione e spettacolarizzazione d’una vecchia e non perduta pratica di tormento della povera bestia; ma potrebbe proprio riproporre un antico rituale comunitario del sacrificio del capostipite che s’immola, morendo, per garantire il rinnovamento e la continuazione della stirpe; e non per caso nella cerimonia si accusa il Babi d’aver fatto vanto d’essere “il più bell’uccello di Biella”, con evidente e maliziosa allusione al membro maschile.
Ancora più esplicito il richiamo sessuale nel carnevale di Occhieppo Inferiore, dove la maschera animista è il pettirosso, che nella parlata locale diventa il Picio ross dall’ambivalente significato e con un insinuante richiamo fallico (in piemontese picio é il membro virile).
Secondo la tradizione, i pettirossi richiamerebbero la burla dei popolani di Camburzano che avrebbero per celia liberato alcuni di questi uccelli mentre nella chiesa del confinante Cèp Sota (toponimo originale di Occhieppo) era in corso una cerimonia religiosa. Racconto fantasioso che memorizza simbolicamente l’intrusione di reali e carnali picio forestieri a infastidire le donne del paese.
Al carnevale di Occhieppo segue a Camburzano la Festa dla brëgna con il pretesto di salutare la maturazione dei numerosi alberi di prugne… ma che contiene un’esplicita allusione all’organo genitale femminile (in gergo, la brëgna). E in effetti per indicare un uomo molto sensibile alle grazie femminili s’usa dire che a-i pias la brëgna.
Nel folklore piemontese l’usel indica l’organo riproduttivo del corpo maschile, e non stupisce se a Chiavazza, ora quartiere periferico della città di Biella ma antica comunità autonoma “dë dlà dël Sarv”, fino al 1940 la maschera totemica carnevalesca era il “cuco”, il cuculo che al termine della festa finiva bruciato.
Altri “usèj” sono protagonisti indiscussi dei carnevali biellesi ancora legati ad antiche “conte” fantastiche e simboliche, e meno succubi di fasulle deformazioni dotte o cripto-politiche come quelle prevalenti nel corso mascherato d’Ivrea, che celebra i fasti della borghesia sulla soccombente nobiltà ostentando come segno distintivo il berretto frigio dei tagliagole francesi. Molto opportunamente, nel libro di Matto si sottolinea che la nascita del carnevale moderno nel periodo napoleonico è avvenuta proprio per piegare i riti antichi alle esigenze del nuovo ordine politico dominante.

Alla frazione Diana di Brusnengo si ricorda che in un lontano passato si sarebbe iniziato a festeggiare il carnevale quando un gruppo di giovani avrebbe catturato in un campo un “bel merlo” (altro nomignolo gergale del membro maschile), decidendo di mangiarlo tutti assieme. Dopo tre giorni d’inutile cottura, l’uccello si sarebbe rivelato disgustoso e i giovani di Diana, a stomaco vuoto, avrebbero consultato gli anziani stabilendo che la bestia non poteva essere un merlo ma… un’immangiabile e beffardo corvo del malaugurio che, miracolosamente rinato, venne “fatto cantare” con un processo carnevalesco. Collocate nella parte alta del Basnengh, la “Cà ‘d Dianna” e la vicina “Cà d’Uglié” sono oggi inglobate nel centro urbano del paese, anche se restano ai margini della grande foresta che comprende Roasio, Villa del Bosco e Curino; sicché non è troppo fantasioso pensare che il toponimo Diana, che direttamente rimanda alla dea romana delle selve, ricordi un’antica attività venatoria rituale con la cattura delle tante specie di volatili presenti nelle fitte foreste della regione.
Come il merlo di Diana, anche il Babi di Biella viene processato a carnevale dopo averlo obbligato a fare testamento “a maggior gloria di Gipino nostro”, montanaro e viton, finché non sale sul rogo, garantendo con il suo sacrificio la purificazione primaverile della comunità.
In un certo senso, le fiamme che dal 1926 ardono nel carnevale biellese ricordano l’ultimo grande processo delle streghe dei Paesi Baschi nel 1609, terminato con l’uccisione di centinaia di donne, bruciate vive finché “una nube di rospi uscì dalla testa dell’ultima al rogo. Il popolo si scagliò su di loro a sassate, e quella finì più lapidata che bruciata. Ma nonostante l’assalto, un rospo nero non venne raggiunto, sfuggì alle fiamme, ai bastoni, alle pietre, fu salvo, da demonio qual era, e nessuno seppe mai ritrovarlo”. Rispuntò l’anno seguente a Bordeaux, uscendo dal corpo di un’altra strega.
Mi piace pensare che, per vie misteriose, quel Babi sfuggito alla strage di donne libere e indipendenti sia magicamente riuscito a rifugiarsi nella mia città, dov’é il personaggio principale della festa del popolo.