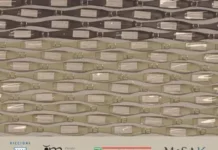Recentemente una militante iraniana anti-regime (di cui riporto solo le iniziali, D.Z., per ovvie ragioni) ha dichiarato che “nel 1979, in nome dell’antimperialismo, molti intellettuali francesi avevano dato il loro sostegno a Khomeiny [all’epoca rifugiato in Francia]. Attualmente gli stessi appoggiano il neofascismo iraniano in nome della difesa dei diritti delle donne d’Iran” (presumo si riferisca ai nostalgici della dinastia di Mohammad Reza Pahlavi, quella asservita all’Occidente, quella che reprimeva il popolo iraniano e con particolare brutalità le minoranze etniche e religiose, quella della Savak…).
In effetti stiamo già assistendo non a una, ma a una doppia espropriazione. A una sorta di confisca nei confronti della rivolta scoppiata dopo la morte della giovane Jina Amini (Masha era il nome imposto dai funzionari persiani, Jina quello curdo) nella città curda di Zaqqez. Almeno in Europa, talvolta i manifestanti con bandiere curde e ritratti di Ocalan sono stati fatti allontanare (o almeno ci hanno provato) dalle iniziative di solidarietà con gli insorti del Rojhilat (il Kurdistan sottoposto all’amministrazione di Teheran) e dell’Iran.
Non solo. L’utilizzo pressoché generalizzato dello slogan “Donna, vita, libertà” lo ha di fatto banalizzato, riducendolo a una generica richiesta di emancipazione, di “pari opportunità” eccetera e svuotandolo del suo significato profondo, frutto di un’elaborazione più che ventennale. Ossia la messa in discussione del patriarcato, del capitalismo, del potere comunque inteso e anche della forma Stato.
Un’elaborazione che vede nella subalternità imposta alle donne, coeva alla nascita dell’agricoltura e dell’allevamento, un evento le cui origini risalgono almeno a cinque-seimila anni fa (se non addirittura a diecimila). Qualcosa insomma di assai profondo e radicato. Per il cui superamento è richiesto un livello di consapevolezza – e di militanza, ça va sans dire – che vada ben oltre una generica presa di posizione in materia di abbigliamento o di accesso ai social.
Ovviamente ora come ora non è facile prevedere quali saranno gli sbocchi dell’estesa ribellione.
Sarebbe comunque paradossale che, qualora vittoriosa, anche l’odierna rivoluzione venisse svuotata della sua valenza progressista (come avvenne nel 1979 a favore della teocrazia).
In questi ultimi giorni del 2022 sono le componenti filo monarchiche notoriamente reazionarie, se non apertamente fasciste, rifugiate nei paesi occidentali, quelle che corteggiano con maggiore insistenza i governi europei e statunitense per ottenerne il sostegno. Quelle che maggiormente scalpitano, spacciandosi per difensori del popolo oppresso iraniano, senza che il popolo stesso li abbia mai delegati a ciò. Intravedendo forse una concreta possibilità di riprendersi il potere a Teheran.
Ma sono gli stessi dissidenti iraniani, sia quelli che si battono nelle strade, sia quelli rifugiati in Europa come molti curdi, a mettere in guardia l’opinione pubblica da questo equivoco. L’eventualità cioè di un “secondo Khomeiny, stavolta in giacca e cravatta”, spedito in Iran dall’Occidente. Magari in nome “dell’unità contro i mullah, per non dividere il movimento popolare” (lo slogan preferito in questa fase dai monarchici), ma in realtà per spogliare l’odierna rivoluzione dei suoi contenuti libertari.
L’opposizione monarchica in Iran viene considerata dagli altri oppositori al regime come “di destra e di estrema destra”. Impregnata di una mentalità ultranazionalista, sessista, neoliberista. E sicuramente poco tollerante nei confronti dei popoli minorizzati – come curdi e beluci – che vivono entro i confini iraniani. Popoli in prima linea, e non certo da oggi, nella lotta contro il regime.