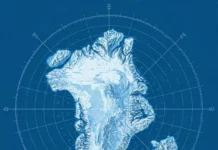Prima di tutto due considerazioni. Una scontata. Mentre l’anno scorso i media, non solo francesi. bene o male si erano occupati dei disordini scoppiati in Nuova Caledonia (situata a circa 16mila chilometri dalla Francia), la notizia che i recenti accordi raggiunti tra Parigi e gli indipendentisti sono stati rigettati il 13 agosto dal flnks (Front de libération nationale kanak et socialiste) non viene adeguatamente diffusa, pur essendo piuttosto rilevante.
Meno scontata l’altra considerazione. Piano con gli entusiasmi, tipo “questi sì che sono indipendentisti con le palle”… Non dimentichiamo che ormai da qualche anno (anche prima forse, ma si notava meno) viene regolarmente applicato il metodo delle “indipendenze a geometria variabile”. Come ricordava il sociologo catalano Manuel Castells, “ormai la strumentalizzazione dei movimenti di liberazione nazionale e di quelli autonomisti non è più appannaggio esclusivo dei servizi segreti. Le varie potenze planetarie operano alla luce del sole decretando la legittimità o meno delle rivendicazioni”. Una severa denuncia di come la comunità internazionale si dichiari “favorevole all’autodeterminazione di un popolo o difenda l’integrità di un Paese a seconda di chi, del come e del quando”.
Detto questo, il rigetto da parte del flnks non è cosa da poco. Visto e considerato che comunque il testo firmato il 12 luglio a Bougival – oltre che da governo francese e indipendentisti anche dai loyalistes contrari all’indipendenza – prevedeva, almeno formalmente, la creazione di uno “Stato della Nuova Caledonia” iscritto nella costituzione francese. Per entrare in vigore a tutti gli effetti, l’accordo doveva però sottoporsi alle consultazioni interne della base di ogni partito e movimento firmatario.
Dal comunicato diffuso in conferenza stampa a Noumea da Dominique Fochi, esponente del flnks, si apprende che l’accordo viene rifiutato in quanto risulterebbe “incompatibile con i princìpi e i risultati della nostra lotta”. Infatti, pur prendendo in considerazione la creazione di una “nationalité calèdonienne” e la possibilità di trasferire varie competenze (come moneta, giustizia, polizia), esso non prevede un nuovo referendum sull’indipendenza.
Anticipando tale presa di posizione ufficiale, forse prevista o almeno temuta, Manuel Valls (ministre des Outre-mer) aveva annunciato di volersi recare in Nuova Caledonia per tentare di salvare questo “compromesso storico, frutto di mesi di lavoro con tutte le delegazioni, compresa quella del flnks”.

Da parte loro gli indipendentisti mettevano in guardia Parigi da ulteriori tentativi di “passaggi forzati”, in riferimento alla solita questione della riforma del corpo elettorale, quella che aveva innescato i primi disordini del 13 maggio 2014 (proseguiti e alimentati da mesi di scontri che causarono almeno 14 vittime e danni per milioni di euro).
Ma per una maggiore comprensione di quanto sta ora avvenendo – e della natura stessa del conflitto caledoniano – può servire qualche passo indietro, agli eventi dell’anno scorso e alla loro interpretazione.
Nel maggio 2024, le forzature (lo “scongelamento”) al senato e all’assemblea nazionale in materia di modifiche al corpo elettorale avevano portato al riaccendersi della battaglia indipendentista, inizialmente nei quartieri popolari di Nouméa, con una ripresa dello storico conflitto che aveva travolto l’arcipelago soprattutto negli anni ottanta e che rischiava di radicalizzarsi ulteriormente. Come riconoscono parte degli osservatori, si tratta di un conflitto di natura eminentemente politica. Una contrapposizione che vede da un lato “lealisti” e Stato francese (soprattutto dal 2020), dall’altro gli indipendentisti indigeni Kanak (con tutte le varianti e sfumature intermedie dell’autonomismo). E ovviamente entrambi gli schieramenti forniscono narrazioni diverse, spesso contrapposte, del problema.
Criminalizzazione delle lotte
I primi, i lealisti, hanno tentato di circoscrivere – squalificandola e degradandola – la rivolta del 2024 a fenomeno criminale, delinquenziale. Pur mantenendo una qualche distinzione tra gli indipendentisti pacifici e quelli radicali, qualificati tout court come “terroristi”, negandone comunque la natura politica. Una posizione condivisa da vari esponenti politici: vedi le dichiarazioni (luglio 2024) di Sonia Backés, presidente della Provincia del Sud secondo cui “esiste una sorta di rabbia che anima questi individui, questi rivoltosi. Molti sono alcolizzati. Molti consumano prodotti stupefacenti. Per cui è difficile far intendere ragione a gente di tal genere”.
Più elegantemente ma sostanzialmente sulla stessa lunghezza d’onda, si esprimeva in un intervento alla radio rrb del giugno 2024 Louis Le Franc. Per l’alto commissario della Repubblica in Caledonia vi sarebbero “due strategie nel mondo indipendentista. Quella alla tahitiana, di palika [Parti de libération kanak, componente storica del flnks], democratica e con cui sono disposto discutere”. In contrapposizione all’altra, quella della ccat (Cellule de coordination des actions de terrain, considerata il braccio armato del flnks), definita semplicemente una “strategia del terrore”. Delineando una divisione interna allo stesso indipendentismo tra “politici” e “militaristi”.
 Inevitabile pensare ad altri scenari del secolo scorso quando, sia in Irlanda sia nei Paesi Baschi, talvolta si manifestavano analoghe – e altalenanti – contraddizioni tra chi privilegiava la via elettorale e chi si ostinava nella lotta armata (rispettivamente tra il Sinn Fein e l’ira, e tra Herri Batasuna e l’eta).
Inevitabile pensare ad altri scenari del secolo scorso quando, sia in Irlanda sia nei Paesi Baschi, talvolta si manifestavano analoghe – e altalenanti – contraddizioni tra chi privilegiava la via elettorale e chi si ostinava nella lotta armata (rispettivamente tra il Sinn Fein e l’ira, e tra Herri Batasuna e l’eta).
Ricordo tuttavia che nonostante le attuali posizioni moderate, in origine palika non era così “dialogante”. Il partito nasce nel luglio 1975 dalla fusione di vari gruppi della sinistra radicale indipendentista, tra cui i famosi Foulards rouge: un richiamo esplicito al fazzoletto rosso donato da Louise Michel (qui deportata dopo la Commune del 1871) agli insorti del 1878 nella grande rivolta degli indigeni kanak (guidata da Ataï) contro la spoliazione delle terre operata dai colonialisti.