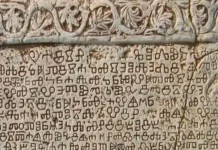Quando gli ignoranti credono di essere progressisti.
Ci risiamo. Ancora una volta, un’amministrazione comunale di centrosinistra (in questo caso Novara) ha deciso di rimuovere i cartelli che recavano il nome della città in lingua locale. Quest’atto si inserisce in una linea stilistica che accomuna anche Lecco, Arcore, Desenzano del Garda, Palazzolo sull’Oglio, Sorisole, Quinzano, Bergamo… e chissà quanti altri paesi sparsi per il nord Italia; paesi diversi e spesso lontani l’uno dall’altro, ma accomunati da un unico destino: aver visto succedersi una giunta di centrosinistra a una di centrodestra.
Fa ridere, in effetti, sentire alcune delle scuse accampate dai sindaci per giustificare la rimozione dei cartelli: si passa dal rispetto del codice della strada (è risaputo che leggere il cartello marrone con scritto Lecch può indurre a gravi incidenti, al contrario delle indicazioni tipo Comune denuclearizzato o Città per la pace) al rispetto verso la comunità straniera; dal puntiglio filologico (siccome nei documenti storici non c’è il nome espresso in una lingua orale, allora non esiste) alla necessità di integrarsi in Europa… e chissà quante altre baggianate.
Più sincero è stato allora il buon sindaco di Novara, Andrea Ballarè, che ha detto chiaramente che per lui i cartelli erano brutti e provinciali, oltre a essere un importante messaggio politico, una specie di Liberazione di Novara. Non per nulla, condividendo su Facebook una foto con l’operaio che rimuoveva il cartello, affermava ilare: via le ultime tracce del villaggio di Asterix.
Una persona coscienziosa e pignola potrebbe far notare a Ballarè che Novara è stata fondata dai Romani, e non dai Galli; che il nome stesso indica una palese origine latina (Novaria) anziché celtica; che presumibilmente è un nome che suggeriva la novità dell’insediamento, soprattutto rispetto ai villaggi gallici presenti nelle campagne circostanti (Novara venne fondata nel 89 a.C. come colonia di diritto latino); che il toponimo Novara è quasi sicuramente un’italianizzazione del nome locale, figlio del latino, No(v)ara, pronunciato [nu’ara]; che essere eventuali eredi di Galli e Celti non è motivo di vergogna. Ma questo genere di lezioncine sono noiose e non vengono molto ascoltate dall’uomo moderno, quindi lasciamo perdere.
Quello che traspare è una specie di volontà di ripicca verso la giunta precedente: voi mettete il cartello, noi ve lo togliamo. Una specie di gioco dell’asilo. E perché mai viene scelto proprio il cartello? Evidentemente, viene interpretato come un odioso simbolo della Lega: il pericolo della secessione, del razzismo xenofobo, del “’dico-che-non-mi-alleo-più-con-Berlusconi-e-poi-mi-ci-alleo-di-nuovo”’, del trotismo e del belsitismo, tutto questo s’incarna in un cartello che reca la scritta Noara, Lecch, Arcor, Desenzan, Palazzoeul, Sorisel, Quinzan, Berghem.
Tutto ciò è profondamente avvilente
È avvilente perché in questa triste faida c’è una sola vittima: la lingua locale. Ne esce umiliata perché ritenuta indegna di apparire su un cartello posto dinanzi al paese dove essa è stata per secoli parlata; ne esce offesa perché ridotta a una volgarissima questione di lotta politica. Siamo arrivati all’idea che difendere le lingue locali comporti essere un leghista, un razzista; chiunque sia un progressista e un democratico invece deve ignorarle o irriderle (il riferimento ad Asterix).
Il bello è che questa convinzione si basa su un equivoco di proporzioni ciclopiche: non sta scritto da nessuna parte che la difesa delle identità locali sia una cosa di destra (anche perché le lingue non sono né di destra né di sinistra; il russo non è una lingua comunista, il tedesco non è una lingua nazista). Basterebbe mettere fuori il naso dalla nostra stanzetta per accorgerci del contrario: in tutta Europa, la difesa delle lingue minoritarie è un orgoglioso vessillo della sinistra! Basta vedere che succede in Catalogna, o nei Paesi Baschi (ma non è in basco il nome del centro sociale torinese Askatasuna?), o in Bretagna, in Galles… A opporsi alle lingue locali, in questi casi, sono le forze politiche nazionaliste e di destra, come il centrodestra spagnolo, il Fronte Nazionale dei Le Pen, i fascisti inglesi di Nigel Farrage. Ovunque le forze progressiste si battono per i diritti linguistici delle minoranze. Ovunque tranne in Italia, dove il cambiamento di qualche cartello nella toponomastica dell’Alto Adige suscita reazioni da guerra del ‘15-18.
Diciamolo chiaramente: l’idea una lingua = uno stato è uno dei frutti più avvelenati che ci hanno lasciato in eredità il nazionalismo e il fascismo, insensibili a qualsiasi forma di diversità; forse non se lo ricordano in tanti, ma fu proprio il fascismo a dare una svolta autoritaria alla repressione dei cosiddetti “dialetti”, e a italianizzare forzatamente le popolazioni germaniche e slave presenti sul territorio italiano. In una maniera assolutamente inspiegabile, questo furore sacro dell’italianizzazione totale è stato trasmesso anche alla sinistra. Perché? Per quale motivo? Perché facciamo mille manifestazioni con arcobaleni e bambini bianchi e neri che sorridono, mille e mill’altri inni alla diversità, se poi ci chiudiamo così ottusamente nel più rigido monolinguismo? Perché balliamo come tarantolati in manifestazione sentendo Le radici ca tieni e poi facciamo la faccia schifata se qualcuno parla di lingua lombarda o piemontese?
Ma in effetti c’è, in alternativa, un’altra forza che spinge a reprimere la diversità: un subdolo e viscido dono della globalizzazione senza criterio, a quel processo che tutto omologa e tutto rende indistinto e indifferenziato, che porta a una visione del mondo dove conta solo quello che è utile nell’immediato (quindi i soldi, e basta) e relega in umide stanzette tutto quello che non le serve. La varietà culturale e linguistica non è contemplata, è un intralcio al progresso: credo che molti riterrebbero più conveniente se tutto il mondo parlasse solo inglese. Quanti soldi si risparmierebbero! Che gran bella vittoria del progresso sarebbe!
È questo un morbo che ci ha colpito un po’ tutti, anche quelli di noi che si ritengono – chi più, chi meno – di sinistra. E visto che alla fine della fiera i dialetti puzzano di vecchio e di inefficiente, allora tanto vale metterli nello sgabuzzino, quello nel sottoscala. Poi, prima o poi, toccherà anche all’italiano (e già se ne scorgono le avvisaglie).

È un processo irreversibile? Davvero la diversità culturale non può resistere al progresso? Guardiamoci intorno: la città di Barcellona, uno dei posti più fighi, internazionali e giovani d’Europa, mantiene orgogliosamente la sua identità catalana, e non ne viene sminuita; e così avviene anche nelle Baleari, e a Valencia. Non stiamo parlando di piccoli e sfigatissimi villaggi dei Pirenei, ma di città e isole visitate ogni anno da orde di turisti. La ricchissima città-stato di Singapore ha quattro lingue ufficiali (come la Svizzera), il Sudafrica ne ha undici, gli Stati Uniti si stanno convertendo (lentamente e un po’ obtorto collo) a un bilinguismo inglese-spagnolo; vediamo progressi incoraggianti in Frisia, in Galles, in Sardegna, in Irlanda, in Scozia, in Galizia, nei paesi abitati dai Lapponi (Finlandia, Svezia e Norvegia); la Nuova Zelanda ha appena riconosciuto i nomi maori delle proprie isole come ufficiali, con pari dignità dell’inglese. La Chiesa ha autorizzato la celebrazione della Messa in alcune antiche lingue locali messicane.
Qui in Italia invece (salvo lodevoli eccezioni, dall’Alto Adige al Friuli e alla Sardegna), stiamo ancora a dibattere sui cartelli e il loro supposto “provincialismo”. Invece la diversità linguistica è un valore, una ricchezza, una gemma da portare al collo; non è una vergogna e un’umiliazione, o un relitto di un’epoca oscura. E a dirlo sono nientemeno che l’UNESCO, l’ONU, il Consiglio d’Europa, la UE, evidentemente non senza ragioni. Parliamo tanto di cultura, facciamo manifestazioni guidate da professori arrabbiati, occupiamo teatri e ci indigniamo se qualche supponente ministro ci dice che con la cultura non si mangia: e poi sputiamo per terra di fronte all’immenso patrimonio delle nostre culture popolari, o lo trattiamo come se fosse una robetta da nulla.
Quella che ci si pone davanti è una sfida culturale senza precedenti, che riguarda la nostra identità e la società che vogliamo creare e lasciare ai nostri figli e nipoti. Una sfida che può partire anche da un cartello di un piccolo comune della Bassa bresciana.