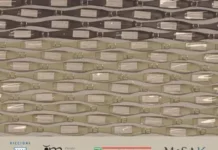Sono innumerevoli gli studi, le ricerche e le considerazioni che l’Antropologia Culturale, a volte con l’Etnologia, hanno portato all’attenzione dei lettori il tema dell’identità dei popoli nei confronti del fenomeno della globalizzazione. Per questo motivo, non abbiamo alcuna intenzione di ripetere concetti che si possono leggere facilmente altrove, scritti e documentati con efficacia da illustri colleghi, mentre vogliamo discutere su una prospettiva diversa, rispetto a questi stessi dati.
Innanzitutto, è bene soffermarsi sul concetto di globocentricità che ho affrontato nel mio primo e unico manuale di Antropologia Culturale, utilizzato all’inizio della mia carriera di ricercatore, come testo fondamentale per affrontare i contenuti di questa interessante e recente disciplina scientifica. Il termine si riferisce a un processo centrifugo e non centripeto, come spesso mi capita di affermare quando spiego il mio punto di vista rispetto al termine globalizzazione. In effetti, con questo ultimo termine, globalizzazione, si intende, anche figurativamente parlando, l’avvicinamento della parte esterna del mondo, ossia le parti più lontane dai propri territori nei quali si vive, alla dimensione quotidiana della propria esistenza. È come avvicinare a se stessi il perimetro del mondo, lontano e appunto globale, perché racchiude in sé tutta l’intera umanità, fagocitando questo perimetro per annientare, in qualche modo e misura, la propria identità personale, sia di essere umano che di cittadino di una nazione. Con il termine globocentricità si vuole invece affermare la presenza di una forza centrifuga che si genera dall’interno della propria identità territoriale e geografica, dunque culturale, per espandersi all’esterno, verso il perimetro del mondo. In questo senso, qualsiasi cultura, indipendentemente dalla propria posizione sul mappamondo, può essere ed è, in effetti, al centro di questo movimento verso l’esterno di se stessa, senza andare incontro alla negazione della propria identità storicamente determinata.
Infatti, qualsiasi individuo, come qualsiasi cultura al mondo, interpreta il mondo stesso partendo dal presupposto cognitivo di essere lei stessa l’attore di questa visione. In altre parole, ogni essere umano vede il mondo con i propri occhi, prima ancora di cercare di vederlo con occhi altrui, perché quest’ultima abilità cognitiva la si raggiunge, a volte, solo dopo molti anni di esperienza in questo mondo. È qui, in questo atteggiamento antropocentrico, che nasce il problema di fare di tutta l’erba un fascio, secondo uno stile che porta la mente ad assolutizzare il proprio microcosmo persino come il migliore, solo perché ad esso siamo ben adattati.
Con il termine globocentricità, pur negando un antropocentrismo territoriale e bieco, si conferma però il ruolo che la propria visione del mondo, frutto delle esperienze storiche della comunità di appartenenza, possiede nella valutazione della propria periferia, sia essa vicina oppure lontana. E non si tratta di connotare, necessariamente, ciò che è oltre il centro di noi stessi come qualcosa di negativo, di “brutto”, o persino cattivo perché distante da noi. Si tratta invece, di non perdere il fulcro esistenziale della propria storia, che è all’origine di ogni sicurezza identitaria, perché senza un proprio centro, e ben identificabile, non è possibile accettare il globo, ciò che è altrove, pena la confusione nella quale un certo tipo esasperato e disumano relativismo culturale vorrebbe farci accettare. Sapere da quale posizione si parte nell’accettare le differenze fra noi e gli altri è indispensabile per un vero e continuo processo di acculturazione, ossia di scambio e di osmosi. Se non so chi sono e dove abito, entro quali confini esisto, non riuscirò mai a sapere cosa accetto o respingo dell’altro diverso da me, ma avrò la sensazione di non sentirmi mai a casa, in nessun luogo. È così che sia crea l’alienazione antropologico-mentale nella quale sembra che il mondo stia sprofondando, specialmente quando il termine globalizzazione incombe nella vita di tutti noi come fosse la ben nota spada di Damocle che non possiamo evitare e che, in una certa misura, colloca la nostra storia oltre la memoria, oltre il ricordo che abbiamo di noi stessi.
Detto questo, concludiamo questo primo intervento scritto, con un ragionamento ulteriore riguardo il concetto di appartenenza, sia ad un gruppo di persone che ad un territorio, ossia uno spazio nel quale più individui hanno la possibilità di esercitare il diritto ad esistere, secondo criteri di cooperazione e collaborazione.
Ogni essere umano appartiene sempre alla propria storia, a qualcuno da cui è dipeso per molti anni, ed in primis alla propria madre. Si tratta di un’appartenenza e non di un possesso, ossia di una vicinanza che spesso viene confusa come una proprietà dalla madre stessa, mentre è per natura solamente una pertinenza, nel senso che il figlio attiene alla madre, come ai figli attengono i genitori. Questo è, in questo sistema solare e non può essere diversamente, altrimenti non esisterebbe la categoria linguistica dell’orfano, che indica l’assenza di questa pertinenza biologica. Una assenza che viene immediatamente colmata con una serie di azioni istituzionalizzate, all’interno di qualsiasi società, grazie alle quali quell’orfano diventa figlio di genitori adottivi, oppure di un’intera comunità di persone. In sostanza, la nostra individualità dipende da quella altrui, e tutte le individualità dipendono fra loro vicendevolmente, specialmente con l’avvento della struttura famigliare, di qualsiasi tipo essa sia.
Così come ogni individuo attiene a colui che lo ha generato (in relazione verticale), lo stesso individuo attiene a coloro che con lui condividono lo stesso territorio (in relazione orizzontale). Queste due tipologie relazionali stabiliscono l’insieme di persone che viene generalmente definito etnia, localizzata e geograficamente riconoscibile entro confini territoriali precisi, anche qualora fossero nomadi, oppure seminomadi (perché non esistono transumanze umane mondiali, ossia che attraversano nel lodo nomadismo l’intero globo circumterrestre…).
Ecco perché la dimensione etnologica della nostra vita precede quella prettamente culturale e mentale, andandola in effetti a costituire nel processo storico del personale divenire, quello che dal feto, ci fa entrare nell’infanzia, passare per l’adolescenza, esistere nella maturità e concludersi nella vecchiaia.
In sostanza, l’eliminazione forzata di questa doppia attinenza, verticale con la propria generazione ed orizzontale con il proprio territorio, abitato da tutto ciò che arreda il nostri spazi vitali, può diventare pericolosa e nemmeno la globalizzazione, intesa nella sua accezione più depauperante, può permettersi un tale scempio, pena l’annullamento biologico della vita in sé, in tutte le sue forme.