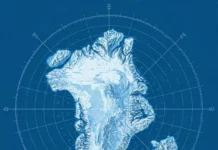>
I prigionieri curdi del PKK e le prigioniere del PAJK (Partito della Liberazione delle Donne del Kurdistan) hanno iniziato uno sciopero della fame nelle prigioni turche dove sono rinchiusi. Lo sciopero si preannuncia a tempo indeterminato e in alternanza, a turno.
Deniz Kaya, parlando a nome del PKK e del PAJK, ha dichiarato che questa protesta dei prigionieri va interpretata come un “avvertimento” al presidente turco Recep Tayyp Erdogan e al governo AKP. Con questo sciopero i prigionieri intendono rivendicare “il riconoscimento dell’autonomia per il popolo curdo e le liberazione di Abdullah Ocalan”.
I prigionieri hanno così voluto portare all’attenzione dell’opinione pubblica l’attuale politica di annientamento condotta, con una barbarie senza precedenti, dal governo turco contro la popolazione curda.
Deniz Kaya si è rivolto a quanti si considerano “intellettuali, scrittori o giornalisti, ma restano in silenzio sul brutale massacro”, chiedendo loro di “rispettare i valori umani”, mettendo poi in guardia sul fatto che “la guerra condotta da Erdogan contro i curdi sta portando la Turchia sull’orlo di un baratro”.
E proseguiva: “Noi dobbiamo dire chiaramente che non abbiamo mai ceduto davanti a questi politici corrotti durante 43 anni e che non abbiamo mai abbandonato la lotta. Bruciando la gente ancora viva dentro gli scantinati e appendendo i corpi nudi delle vittime, il governo AKP dimostra apertamente di non rispettare né le leggi di guerra né l’umanità”.
Appare evidente come Erdogan e i suoi complici abbiano ormai superato il limite della decenza e “un giorno saranno giudicati dal popolo curdo”, avverte il comunicato. Nel quale si informa che lo sciopero iniziato il 6 marzo 2016 proseguirà, condotto da gruppi di prigioniere e prigionieri che si alterneranno ogni dieci giorni. Rivolge poi un appello tutte le “orecchie sensibili” affinché denuncino pubblicamente le atrocità commesse dal governo turco e diano sostegno al popolo curdo.
La pistola fumante
“ISIS assassino, AKP collaborazionista”, gridavano i manifestanti turchi scesi in strada per protestare contro il loro stesso governo, ritenuto complice dello Stato Islamico, dopo gli attentati del 20 luglio 2015 in cui avevano perso la vita 32 militanti di sinistra. Ora altre prove si sono aggiunte a conferma di questa collaborazione in chiave anti curda e anti Assad.
Un articolo di Martin Chulov sul “Guardian” spiega come tra le macerie di un attacco contro il complesso residenziale di Abu Sayyaf (responsabile finanziario dello Stato Islamico, ucciso nel raid), vi fossero ulteriori prove che funzionari turchi di alto livello trattano direttamente con dirigenti dell’ISIS. Sayyaf era il responsabile della direzione delle operazioni gas e petrolio in Siria per conto di Daesh, che guadagna circa 10 milioni di dollari al mese dalla vendita di idrocarburi al mercato nero.
Il sequestro di vari documenti e memorie flash sembra confermare “in modo chiaro e inequivocabile” i collegamenti tra Turchia e ISIS. Le prove così ottenute potrebbero avere – l’articolo del “Guardian” riporta le dichiarazioni di un “alto funzionario occidentale” che ha potuto accedere ai documenti sequestrati – “profonde implicazioni politiche nel rapporto tra noi e Ankara”.
Niente di nuovo. Le buone relazioni tra Ankara e l’ISIS (in particolare il vasto contrabbando di armi e di combattenti verso la Siria, sia per provocare la caduta di Bashar Assad sia, soprattutto, per combattere i curdi) erano state denunciate persino da Joe Biden. Va ricordato quanto dichiarava nel novembre 2015 un ex membro del califfato a “Newsweek”: “I comandanti dell’ISIS ci avevano detto che non temevano nulla perché c’era piena cooperazione con i turchi”, aggiungendo che “l’ISIS vedeva l’esercito turco come un suo alleato specialmente quando si è trattato di attaccare i curdi in Siria”.
E più recentemente, in febbraio, un diplomatico occidentale ha dichiarato al “Wall Street Journal” che “la Turchia adesso è in trappola, ha creato un mostro e non sa come affrontarlo”.
Anche turkmeni e arabi nel mirino di Daesh e Ankara
Mi aveva sinceramente colpito la notizia – risalente ancora al 2014 – che i militanti curdi del PKK erano intervenuti per portare in salvo gli abitanti di un villaggio di turkmeni attaccato dall’ISIS. Ma come, mi dicevo, non sono stati forse i “turcomanni” (popolazione linguisticamente turcofona) a collaborare in passato con la Turchia contro i curdi (vedi l’assalto al campo profughi di Atrush nel 1997)?

Come mai ora vengono attaccati dall’ISIS, notoriamente “in batteria” con Ankara? Forse dipendeva dal fatto che quel villaggio aveva, agli occhi dei fascisti islamici, un grave difetto: gli abitanti sarebbero stati in maggioranza sciiti e quindi “eretici”. Bontà loro, i curdi – che evidentemente non portano rancore – si sono prodigati per proteggerli, così come hanno fatto con cristiani, alawiti e yazidi. Questi ultimi, una popolazione curda, vengono considerati ancora peggio che eretici (“pagani” addirittura) dall’ISIS che si conferma come l’odierna versione islamica della “Santa” Inquisizione.
Un altro villaggio a maggioranza turmena, Tel Abyad, è stato attaccato in questi giorni dall’ISIS con il sostegno turco. In un comunicato, Xali Redur denuncia che “i gangster di Daesh hanno massacrato 2 turkmeni, 3 curdi e 3 arabi, mentre durante la nostra liberazione di Tel Abyad nessun civile era stato ferito”. E, aggiunge il portavoce di YPG, “con il sostegno dello stato turco, Daesh si accinge a massacrare anche turkmeni e arabi della regione”.
Che fine hanno fatto le donne yazidi?
Un dramma senza fine quello delle donne yazidi sequestrate a centinaia nell’agosto del 2014, considerate “bottino di guerra” e violentate dai terroristi di Daesh. Secondo il sindaco di Sinjar, nell’Iraq settetrionale, sarebbero state deportate in altri Paesi come l’Afghanistan, il Pakistan, la Libia e la Cecenia. Una notizia confermata dalle dichiarazioni di numerose donne yazidi liberate, dopo il pagamento di un riscatto, grazie all’opera di mediatori.
“In questo momento”, ha spiegato il sindaco di Sinjar (liberata dalla coalizione curda il 13 novembre 2015), “non sappiamo quanti giovani donne siano state portate fuori dall’Iraq e dalla Siria, ma riteniamo che Daesh abbia potuto farle uscire clandestinamente via terra”.
In precedenza altre donne erano state portate nelle città di Mosul e di Tel Afar, ma al momento si troverebbero in località siriane ritenute “più sicure” per Daesh.
Ha poi aggiunto che “molte donne sequestrate possono ancora utilizzare i loro telefoni portatili, parlano con i familiari e chiedono di essere riscattate”. In base ai dati forniti da uffici governativi, degli oltre 6200 yazidi sequestrati, quasi 4000 sono ancora nelle mani dei rapitori e tra loro circa 2000 sono donne e bambine.
Hussein Koro, che si occupa delle persone sequestrate per conto del governo regionale del Kurdistan iracheno (KRG), spiega che “abbiamo pagato il riscatto di molte vittime di rapimento”; ma non sempre il pagamento garantisce la liberazione delle donne rapite. In altri casi sono state le famiglie a pagare anche se, purtroppo, in molti casi gli individui che si erano offerti come intermediari sono risultati dei truffatori.
Xudeda Misto, un anziano membro della comunità yazidi di Shingal (a cui l’ISIS nel 2014 ha rapito la moglie, tre figlie e un figlio), ha raccontato che gli erano stati chiesti 15.000 dollari per riavere la figlia maggiore, detenuta in Siria, “ma io ne possedevo soltanto 5000”.
Secondo le associazioni per i diritti umani, migliaia di donne e ragazze yazidi sono state costrette a sposarsi o sono state vendute come schiave sessuali dai terroristi di Daesh. Nel novembre dell’anno scorso, l’ONU ha definito l’attacco alla popolazione ezida come “un possibile genocidio”.
Da parte sua il parlamento europeo ha riconosciuto Daesh “colpevole di genocidio per aver rapito migliaia di donne curde yazidi e ucciso migliaia di uomini, donne e bambini a Shengal”.