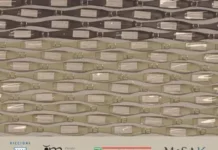In Bangladesh, ancora una vittima del capitalismo selvaggio, delle delocalizzazioni, delle zone franche. Se vogliamo anche del pret-à-porter. Ossia di quel sistema neocoloniale che consente a benestanti (più o meno benestanti, ovviamente) e aspiranti tali di vestirsi e gingillarsi elegantemente, ma a modico prezzo. Precisando che se in passato tutto questo riguardava soprattutto i Paesi occidentali, ormai anche la Cina non scherza.
La mattina del 14 giugno gli operai delle aziende tessili Lini Fashion e Lini Apparels avevano scelto di protestare – sostanzialmente per i salari arretrati non corrisposti – occupando l’autostrada Nabinagar-Chandra. A loro si univano, solidali, i lavoratori di altre fabbriche, soprattutto tessili, come quelli di Avant Guard, Shine Fashion, Goltex Garments, One BD Limited…
Rudimentali barricate venivano innalzate nei pressi della zona franca di esportazione (EPZ) di Ashulia. Quando il traffico è cominciato a rallentare seriamente, con alcuni imbottigliamenti di veicoli, la polizia è intervenuta sparando granate antilacrimogene e facendo ampio uso di cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti. L’operaia di 30 anni Jasmine Begum è deceduta per una ferita alla testa, presumibilmente prodotta dall’impatto con una granata sparata ad altezza d’uomo (e non a parabola).
Soltanto qualche mese fa, in aprile, almeno cinque operai erano rimasti uccisi in circostanze analoghe a Banshkhali. Protestavano, sia per i salari non corrisposti, sia contro il brutale orario di lavoro, davanti alla centrale a carbone in costruzione SS Power One. Costruita con finanziamenti cinesi, la centrale prevedrebbe – almeno in teoria – anche la realizzazione di un ospedale, come parziale compensazione per i danni ambientali (un po’ come le scatole di medicinali donate agli indigeni dai turisti danarosi d’alta quota).
Stando alle dichiarazioni ufficiali, la polizia avrebbe aperto il fuoco quando i lavoratori, circa duemila, avevano iniziato a tirar sassi e mattoni.
I quattro cadaveri trasportati all’ospedale di Banshkhali presentavano evidenti segni di colpi d’arma da fuoco, così come una dozzina di feriti. Un altro operaio ucciso era stato portato all’ospedale di Chittagong insieme ad altri venti feriti.
La centrale a carbone per la produzione di energia elettrica SS Power One (1200 megawatt previsti, investimenti per oltre 2,5 miliardi di dollari, lavori completati al 40%) appartiene per il 30% alla società cinese SEPCO3 (Shandong Electric Power Construction Corporation III, il maggior produttore cinese di acciaio), mentre il restante 70% spetta al gruppo industriale bengalese S. Alam.
Manifestazioni di protesta contro il progetto, realizzato senza consultare l’opinione pubblica, si erano già tenute in passato. Anche allora con vittime tra i civili.
Nel 2016, durante un raduno di contadini ostili alla centrale, la polizia aveva ucciso quattro manifestanti. Un altro era stato ucciso nel 2017. Per Shahnewaz Chowdhury, recentemente arrestato anche per questa sua dichiarazione, complessivamente i morti sarebbero almeno una dozzina.
Secondo alcune organizzazioni ambientaliste e per i diritti umani, la centrale non rispetterebbe i parametri minimi, le norme di impatto ambientale.
La firma del contratto risale al 2016 (visita di Xi Jimping) e prevedeva che la centrale venisse realizzata da imprese cinesi impiegando anche manodopera locale. Da sfruttare adeguatamente, a quanto pare.
Quanto al già citato Shahnewaz Chowdhury, si tratta di un ingegnere ambientalista bengalese che rischia ben 10 anni di prigione per aver espresso su facebook quella che sostanzialmente rimane una legittima opinione personale. Ossia la convinzione che la centrale in questione costituisca un elemento di “distruzione per l’ambiente”. Protestava inoltre per quella dozzina di vittime durante le proteste e invitava i giovani a “resistere all’ingiustizia”.
A favore della scarcerazione di questo prigioniero d’opinione è intervenuta all’inizio di giugno anche Amnesty International.