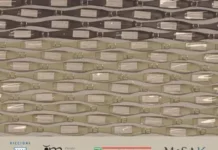Da “Chorus”, gennaio 1991
foto di Dino Fracchia
Carlo si sfila il maglione e mette a nudo un corpo che fa impressione: la pelle del torace, del ventre e delle braccia sembra solcata da una miriade di pennellate orizzontali, lunghe e biancastre sulla perenne abbronzatura da nomade. “Sono stato io, con il rasoio”, spiega indicando le cicatrici. “Per attirare l’attenzione su di me. Per far sapere agli altri che ero un ‘argato’, un bambino schiavo. Ho anche tentato il suicidio”. Con una smorfia di amarezza, Carlo si aggrappa alle stampelle e apre il frigorifero appoggiato alla parete esterna della roulotte per offrirmi una birra. Non oso chiedergli spiegazioni sul suo difetto fisico, probabilmente congenito; ma non mi stupisco che la famiglia dello zio l’abbia preso in affitto dai genitori a soli nove anni. Proprio così, preso in affitto. Noleggiato un tanto al chilo per trascinarsi, come un animale ammaestrato, lungo i marciapiedi delle ricche città italiane.
Un bambino zoppo fa vibrare più forte le corde della generosità, l’elemosina è più sostanziosa. Le brave massaie scuotono la testa impietosite, lasciando cadere una banconota. Ma se il bambino zoppo le segue, tenta di far capire loro che il suo dramma non si riduce a un paio di grucce e che la vera prigione non è un difetto fisico. allora le brave massaie si allontanano subito frettolose. La schiavitù non si riscatta con mille lire.

(foto Dino Fracchia)
“Tutte, tutte le ho tentate”, continua Carlo, ventiduenne rom gagikanè di origine iugoslava; in una parola: zingaro. “Parlavo con chiunque, cercavo di spiegare la mia situazione. Raccontavo del disprezzo per i miei genitori che mi avevano venduto, dei maltrattamenti che subivo quando tornavo al campo con pochi soldi, del freddo, della fame. E nessuno mi dava retta”.
“Non potevi cercare di scappare?”, gli chiedo, rendendomi istantaneamente conto delle difficoltà a livello fisico insite nell’impresa.
“Ci ho provato. Più di trenta volte! Raggiungevo Trieste e mi presentavo in questura. Loro capivano, mi lasciavano passare la frontiera e avvertivano la polizia iugoslava che mi accompagnava a casa. La magistratura locale avviava un procedimento contro i miei genitori. Ma io avevo paura e quando arrivava il momento del processo in tribunale non riuscivo a parlare, ad accusare nessuno. Cosi i miei genitori mi rispedivano in Italia, e tutto ricominciava daccapo”.
“Ora pero è finita…”.
L’ex argato sorride alla moglie, una graziosa sedicenne che malgrado il freddo zampetta a piedi nudi sotto la veranda della roulotte: sta preparando una pentolata di caffè alla turca, inesorabile
quanto gradevole testimonianza di ospitalità in un campo nomadi.
“È finita… in parte. Non sono più schiavo da quattro anni, cioè dal compimento della maggiore età. Però i miei zii sono ancora qui a Torino (nell’altro campo, quello di Strada Aeroporto) e la loro vicinanza non mi rende affatto tranquillo. E poi, pur avendo in vista un lavoro sia io sia mia moglie… lei fa l’apprendista parrucchiera… il comune di Torino non mi vuole dare la residenza.
E se non me la danno, dove vado a stare? Come vivo?”.
Il traffico degli argati, di cui s’è molto parlato nelle cronache recenti, e senz’altro l’aspetto più deprimente della disgregazione sociale alla quale stanno andando incontro i circa 80.000 sinti e
rom, le due principali etnie zingare presenti nel nostro Paese.
A grandi linee, la tratta funziona cosi: nelle regioni più povere del meridione iugoslavo, alcune famiglie con molti figli e pochi soldi accettano di affidare uno o più bambini alle carovane di zingari dirette in Italia. Dopo un certo periodo, gli zingari riporteranno i piccoli e verseranno ai genitori una percentuale sui proventi. Proventi di che? Dell’accattonaggio, come nel caso (neppure sfortunatissimo) di Carlo; ma più spesso dei furti d’auto, degli scippi, delle razzie negli appartamenti.
Gli argati varcano la frontiera attraverso i boschi per non incappare nei controlli: sono privi di documenti, non li lascerebbero passare. E anche una volta giunti nelle vie di Roma, Milano o Torino, i piccoli “strumenti” di delinquenza sono anonimi, inclassificabili, né si possono riconsegnare a famiglie cui è difficilissimo risalire… e a cui forse è meglio non risalire.
Secondo Livia Pomodoro, procuratore della repubblica presso il tribunale minorile di Milano, solo nella città lombarda si conterebbero oltre un migliaio di bambini e adolescenti impiegati in attività illecite. “La situazione è grave”, lamenta il magistrato. “La maggior parte dei minori attualmente inquisiti è rappresentata da ragazzi nomadi. E occorre tener presente che la popolazione zingara nella mia giurisdizione è appena di quattromila persone”.
Quindi una percentuale elevata. Quindi una popolazione, quella zingara, che presenta un alto tasso di pericolosità sociale. L’Opera Nomadi, un’organizzazione che provvede con l’ausilio di fondi pubblici alla difesa dei diritti di sinti e rom, non la pensa così. Almeno nella persona del responsabile milanese, Andrea Bertol: “Questa degli zingari sta diventando una psicosi collettiva, mi creda. Qui a Milano i bambini vanno in giro per le strade perché nessuno provvede a mandarli a scuola. È il risultato di una politica aberrante del comune e della questura, basata solo sulla repressione. Sgomberi su sgomberi. Una carovana sosta nel territorio, e loro la cacciano via in base a una famigerata ordinanza comunale di due anni fa che prevede 600.000 lire di multa per sosta abusiva e l’allontanamento immediato. Cosi non si elimina il problema alla radice, semplicemente lo si ‘sposta’”.
“Quale sarebbe quindi la soluzione?”
“Basterebbe seguire l’esempio di Torino. Qui il comune ha istituito dei campi fissi, censendone gli abitanti e inserendo i bambini nelle scuole. Come risultato, il numero di nomadi in prigione, maggiorenni o minorenni, si è dimezzato. Mentre Milano resta ancora una città di passaggio, c si sorbisce, perciò, soltanto gli aspetti negativi della civiltà nomade. Grazie anche alle petizioni dei ‘bravi cittadini’, i quali si scalmanano appena vedono una carovana che si ferma sono casa…”
“Va bene, ma a nessuno piace ritrovarsi, un giorno, l’appartamento svaligiato”, gli faccio osservare.
“Storie. Il nomade tende a rubare lontano dal campo, poiché vicino si ritorcerebbe contro di lui. Sono pregiudizi e basta. La verità è che il nomade dà fastidio visivamente. I ‘gagè’, i non zingari, non se lo vogliono vedere attorno a due passi da casa”.
Buon senso o retorica? È quanto probabilmente si chiedono da tempo milioni di cittadini, colpevolizzati dai giornali ogni qual volta si segnalano problemi di convivenza con i gruppi etnici “emarginati”. Sentiamo ancora il parere di Livia Pomodoro.
“Che a Torino ci siano meno minorenni in prigione, non stento a crederlo. Bella forza: vengono a rubare a Milano! Quanto alle reazioni dell’opinione pubblica, non le giudico immotivate. È imputabile agli zingari gran parte degli scippi e dei furti in appartamento. Per adesso siamo a questo livello, però già si profilano episodi di spaccio di droga e prostituzione minorile. Se un fenomeno del genere non impressiona la cittadinanza, mi dica lei quale potrebbe essere… È chiaro”, conclude il procuratore, “che il problema si risolverà superando l’approccio meramente giudiziario a favore di un intervento sociale. La soluzione e l’inserimento nella comunità dei cittadini, come chiedono gli stessi nomadi. Ma loro devono decidersi ad accettare le norme del vivere civile. Chi vive di furti non può aspettarsi comprensione in nessuna società umana”.
Che Carlo non viva di furti appare evidente. Intanto non gronda oro (denti falsi, orecchini, catene, anelli) come altri abitanti del campo. Inoltre, parcheggiato davanti alla veranda di legno e cartone, campeggia un Ape 50 tirato a lustro: la vettura con cui ogni giorno si reca in città per guadagnarsi il pane. Niente macchinone lussuose o costosi furgoni.
Lui e i suoi cugini (tutte facce slave, più chiari di carnagione, cristiani) sembrano pesci fuor d’acqua nel campo torinese dell’Arrivore, abitato in maggioranza da rom musulmani di origine turca e albanese. Mentre, sdraiato sotto il cassone dell’Ape, lo aiuto a individuare il carburatore (“Mi fa trecento metri, poi s’inchioda”), si avvicina una delegazione dei suddetti cugini. Birre alla mano, stanno festeggiando da due giorni la vincita alla “lotteria” di uno di loro: 250 milioni!
Ci accomodiamo nella veranda, dove vengo incaricato di esaminare l’incartamento. In composto silenzio, tutti attendono che mi esprima sull’armamentario di opuscoli, finti diplomi, buste per il “si” e per il “no”. Ahimè, l’occhio allenato dello stanziale non tarda a riconoscere la paccottiglia con cui una nota casa editrice inonda le cassette postali.
“Non hai vinto nulla”, sentenzio.
“Come non ho vinto nulla?”, si allarma il cugino. “C’è scritto lì. Documento ufficiale. Duecentocinquanta milioni al signor, eccetera”.
“Mi spiace. Parteciperai eventualmente all’estrazione di un premio, se acquisti Panorama di Musica Immortale in dodici volumi con dischi allegati. Se vuoi puoi pagare in ventiquattro comode rate mensili”.
“Ma che mi frega di musica immortale. Lì c’e scritto: hai vinto, io domani va dall’avvocato!”
Mentre passeggio per il campo, penso che sarebbe davvero bello se l’avvocato del candido gagikanè la spuntasse. Ma, temo, si tratterebbe di un legale da quattro soldi. Non certo del livello che si possono permettere altri nomadi, come mi ha raccontato un funzionario del tribunale di Milano: “Gli zingari pagano profumatamente per tirarsi fuori dai guai. Anche se difenderli non è esente da rischi (si può prendere un sacco di legnate in caso di esito negativo!), alcuni avvocati si sono specializzati nel settore. A Milano sono una decina, gente piuttosto losca. Uno di loro è stato inquisito perché sospettato di essere complice di una brutta storia di argati”.
Argati, traffici, connivenze: un mondo inquietante provocato dall’emarginazione e limitato alle periferie milanesi? O una realtà diffusa anche in questo campo torinese, controllato da coordinatori dell’Ufficio Stranieri e additato come modello dall’Opera Nomadi?
Difficile rispondere. È ormai un classico che quando si parla di extracomunitari ed etnie emarginate non esistono più esperti sereni e osservatori spassionati, ma solo intolleranti o antirazzisti di professione. I primi pretendono che la nostra razza sia migliore e abbia più diritti delle altre. I secondi, invece, affermano il contrario.
I comitati di cittadini vedono gli zingari come una minaccia. L’Opera Nomadi, spalleggiata dai giornali, li considera vittime innocenti di un’industrializzazione che ha cancellato le tradizioni del nomadismo produttivo, fondato sugli antichi mestieri del calderaio e del commerciante di cavalli. Chi ha ragione? A complicare ogni tentativo di analisi c’è poi un’atavica doppiezza degli stessi zingari: in sostanza è faticoso capire se ti dicono la verità o ti stanno menando per il naso. Fare amicizia con loro significa provare una doccia scozzese di sentimenti, oscillanti tra un commosso affetto e un’offesa indignazione.

(foto Dino Fracchia)
Prendiamo Borko, un capofamiglia rom kalderasha alloggiato in una specie di recinto fatto di travi in fondo al campo (l’industria del legname deve prosperare, da queste parti). Mi avvertono che, essendo le dieci del mattino, Borko dovrebbe già essere arrivato al quarto cartone di Tavernello. Lo trovo infatti che succhia dal tetrapak, sebbene non presenti alcun segno di cedimento mentale. Ignoro come si reggerà in piedi verso sera, ma per il momento suo eloquio appare colmo di buon senso (tranne, forse, quando si proclama musulmano mentre addenta una costina di maiale innaffiata da una sorsata di bianco).
«Vedi, noi siamo calderai. Il nostro mestiere è lavorare il metallo”, dice mostrandomi una piccola collezione di pentole di rame e alluminio battuto. «Facciamo piatti, sculture, alambicchi per la grappa. Poi li vendiamo al mercato. Però, i vigili ci cacciano via. Noi vorremmo la licenza per mettere su un negozio dove vendere la nostra roba”.
“Stando così le cose”, deduco, “non siete in grado di mantenervi solamente con l’artigianato”.
“Sì, sì”, insorge. “Siamo in grado. Se io rubo, mi mettono dentro e allora addio bambini. Niente rubare. E niente argati nel campo. I nostri bambini vanno tutti a scuola, amici di bambini italiani. Guai se non vanno a scuola”.
Aperto il quinto cartone di Tavernello, Borko prosegue: «Soltanto, ci piacerebbe che il comune pensasse di più a noi. Guarda qui, c’è la terra battuta. Come si fa a tenere pulito? Basterebbe mettere l’asfalto, come al campo Aeroporto. Non chiediamo molto”.
Le espressioni di Borko sono logiche, toccanti, ma al gagè impreparato certe cose sfuggono. Oggi c’è una disciplina antropologica, si chiama “prossemica”, che insegna a superare le incomprensioni dialettico-culturali tra razze diverse. Studiandola a fondo, forse riuscirò a capire perché Borko si lamenta della sporcizia e poi getta a terra le ossa rosicchiate delle costine; perché sostiene che i bambini devono andare tutti a scuola, mentre figlioletti e nipotini razzolano attorno a noi, e lo scuolabus del comune è già passato da due ore; perché tuona contro il furto, e poi il suo territorio è disseminato di televisori smontati, cavi metallici, macchinari.
Come mi spiega il dottor Secondo Massano, responsabile dell’Opera Nomadi di Torino ma con i piedi meglio piantati per terra del suo collega milanese, si tratta delle tipiche scorie di “rottamazione” furtiva. Vale a dire che i rom kalderasha sono sì lavoratori del metallo, però la materia prima se la procurano prelevandola da tir in sosta, razziando televisori e pezzi di cavo elettrico, e persino alleggerendo le fabbriche di costosi macchinari, di cui poi utilizzano (assai poco economicamente) le sole parti adatte alla fusione. Parecchi commercianti di metalli, mi si dice, restano aperti di notte per ricettare i prodotti gitani. E non si tratta di pentole.
Curiosando per il campo, tra personaggi picareschi come Borko e altri meno disposti ad aprire il proprio cuore, noto la strana architettura delle “abitazioni”. Alle roulotte originarie si vanno aggiungendo ampliamenti stabili, come verande di legno con vetri di recupero e porte su cui è pitturata una sottonumerazione civica (il campo è al numero 20 della via, quindi le varie abitazioni corrispondono a 20/1, 20/2, eccetera). In certi casi la roulotte manca del tutto, sostituita da baracche di travi con due o tre locali e tanto di apparecchio telefonico, meno adatte del rimorchio ai rigori dell’inverno ma sicuramente più comode per famiglie numerose.
Le auto di grossa cilindrata, onnipresenti nei campetti volanti e indispensabili al traino, hanno lasciato il posto a una flotta di Transit diesel, cioè furgoni per il trasporto merci. Il tutto a indicare una tendenza alla stanzialità piuttosto che al nomadismo. In verità, come mi confermano i diretti interessati, al giorno d’oggi il nomade è tale solo perché costretto dalle ordinanze di sgombero dei vari comuni. E qui a Torino, ufficialmente (e sottolineo ufficialmente) si viene sbattuti fuori soltanto se non si è in regola con i documenti, se non si mandano i bambini regolarmente a scuola e in caso di guai con la giustizia.
Verso mezzogiorno vengo raggiunto da un ragazzino in piena età scolare, latore di un invito a pranzo presso la baracca più imponente del campo. Lo seguo. Ad accogliermi, un personaggio notevole: si chiama Renka ed è, come dire, quanto di più prossimo all’astrazione di “tzigana” abbia incontrato in un campo di nomadi, luogo in cui la nostra iconografia di bellezza zingaresca nella realtà trova poca rispondenza.
Renka indossa un’ampia gonna zingara, porta orecchini zingari, ha un volto zingaro. Sembra lapalissiano, ma non ne avevo ancora viste abbigliate così. Per la prima volta ho la sensazione di trovarmi di fronte all’esponente di una “cultura”. Riesco ora, finalmente, a inquadrare il disagio provato fin qui: passeggiavo tra l’emarginazione, la sporcizia, le problematiche sociali, ma non scorgevo nulla al di là della facciata; la “cultura”, l’“etnia”, la “storia” erano rimaste nei libri o nelle appassionate descrizioni degli ziganologi.
Renka, scoprirò, ha quarant’anni, ma come ogni donna del suo popolo ne dimostra dieci di più; è perciò un’affascinante cinquantenne. Renka ama molto i giornalisti. Mi mostra la sua fotografia apparsa sui quotidiani locali, dove viene indicata come l’animatrice di una società culturale rom.
“Organizziamo corsi di battitura del rame, danze, cucina e arte curativa zingara”, mi racconta, invitandomi con un gesto regale a sedere nella veranda. “La gente deve imparare a conoscere le nostre antiche tradizioni, e quelli come te ci possono aiutare. Pubblica questo”.
Mi tende dei fogli scritti in maiuscolo, dettati da lei probabilmente a qualcuno dell’Opera Nomadi. Pur parlando in modo accattivante, è analfabeta.

Scrive Renka: “I gagè vogliono sapere come vivono i nomadi, viviamo bene, a nostro modo. Noi nomadi viviamo come possiamo. Qualcuno ruba, qualcuno vive onestamente, come voi gagè. Qualcuno è onesto e qualcuno no. Voi sapete, gagè, che una volta avevate tanta paura di noi. Finalmente è venuto il momento di chiederci come viviamo. Vi diciamo la pura verità. La nostra vita è bella, anche se per casa abbiamo solo una baracca e una tenda. I nostri figli sono la nostra gioia e la nostra ricchezza. Sono loro il nostro futuro. Noi siamo più o meno liberi e non ci interessa avere tanti soldi. Oggi mangiamo bene e domani non pensiamo se non ne abbiamo. Noi non pensiamo ad avere né fabbriche né ville. Però c’è una cosa che ci piace tanto! Un bel cavallo o una bella macchina per girare il mondo”.
Veniamo interrotti da un grido d’irrisione: “Avel o Rambo!” (Arriva Rambo!). E infatti appaiono due grossi gagè, uno dei quali porta una semiautomatica sotto l’ascella. Sembrano arrabbiati. Hanno l’accento piemontese. Discutono fittamente per qualche minuto con Renka, che di tanto in tanto li tranquillizza con fare condiscendente, materno. Alla fine i due se ne vanno.
“Erano vigili”, mi spiega la donna. “Stanno cercando un ragazzo quattordicenne fuggito dall’altro campo. Una specie di gigante che ha picchiato i genitori, ha persino gettato a terra uno dei due che hai appena visto. Adesso vogliono cacciare via tutta la famiglia. Vedi in quali condizioni viviamo? Dimmi che colpa ha la famiglia se il figlio è malato di mente?”.
Completamente d’accordo con lei, proseguo la lettura: “Qui a Torino quando sono arrivata mi sono trovata come nella mia tenda. I miei figli sono cresciuti, ho cercato di mandarli a scuola, quando ancora non c’era l’obbligo. Hanno insegnato agli altri zingari ad andare a scuola. Per adesso con mio marito vado molto d’accordo e siamo sempre insieme, lavoriamo anche insieme. Meno male che i miei figli e mio marito non mi danno preoccupazioni e non voglio nient’altro”.
Altre belle parole, con le quali mi piacerebbe terminare l’articolo. La voce un po’ ingenua di una famigliola modello venuta da lontano, disposta a onorare con dignità le norme e le tradizioni del nuovo mondo che la ospita.
Ma, come si diceva poc’anzi, le relazioni con gli zingari possono rivelarsi una doccia fredda. Parlando entusiasta di Renka e delle sue iniziative agli altri abitanti del campo, non ottengo che silenzi imbarazzati e occhiate gelide. Non riesco a comprenderne il motivo. Dopo qualche giorno, ormai in confidenza con alcune famiglie dei due campi torinesi, scopro una verità del tutto inattesa.
Renka fa paura. La odiano.
“Vedi”, mi spiega Stojan, un gagikanè, “nei campi c’è una mafia, un racket come nelle vostre città. Alcuni clan comandano sul resto della gente. Obbligano i giovani a rubare e guai a loro se si ribellano. Sono i capomafia a decidere chi resta nei campi e chi se ne deve andare”.
Dunque l’affascinante Renka sarebbe una capomafia? L’ipnotica apologeta della cultura rom? Da non crederci. Ulteriori informazioni provenienti da fonti più “ufficiali” confermano però la fama della sua famiglia. Il figlio maggiore, quello che insegna agli altri zingari ad andare a scuola, ha sul capo una sfilza di denunce, ha avuto a che fare con il clan dei catanesi e comanda una squadra juniores di ladri d’auto, che ogni notte portano al campo due o tre vetture rubate, smontano i motori e poi precipitano le carcasse nel torrente Stura. Quanto a Renka, coordinerebbe i traffici mantenendosi al sicuro grazie ad amicizie nella polizia e a qualche “soffiata” di tanto in tanto.
Queste ultime sono solo voci… per quanto venga spontaneo chiedersi come mai a certa gente sia consentito di spadroneggiare in un campo, laddove basterebbe il semplice sospetto di illegalità per esserne cacciati.
Meno ipotetici sono i dati fornitimi una sera tardi, in un’auto parcheggiata in una stradina buia come nei film polizieschi, da un personaggio che chiameremo Alberto. Alquanto nervoso. Alberto mi prega di non rivelare né la sua identità né il suo lavoro. Si tratta di un’attività svolta a contatto con gli zingari, di cui è profondissimo conoscitore. Sa vita, morte e miracoli di ogni abitante dei campi. Da tempo sta indagando sulle malefatte perpetrate da una cospicua percentuale di ospiti.
“Tu credi che siano tutti poveracci”, si sfoga, “che siano tutti costretti a rubare per sfamare i bambini. Sono tutte balle. Alcuni di loro tengono auto da ottanta milioni nei garage cittadini, e poi non comprano neppure le medicine per i figli. Si limitano a sfruttarli. Chiedono il posto gratis nel campo, senza pagare la bolletta della luce, rifiutandosi di versare un contributo al comune per l’acqua che sprecano in modo indecente (il campo di Strada dcll’Arrivore costa alla collettività duecentocinquanta milioni l’anno di solo rifornimento idrico), e poi hanno conti in banca da capogiro”.
“È un’illazione, la tua?”.
Scuotendo il capo, Alberto accende la lucetta interna e mi mostra alcune fotocopie di saldi di conto corrente. Nomi slavi seguiti da cifre sorprendenti: 150, 300 milioni… Tutti versati all’Istituto San Paolo e al Banco di Roma. Figura anche Renka: “soltanto” 30 milioni.
“Ma capisci che si tratta appena di una parte dei depositi. Ne esistono, e lo so per certo, in altre banche alle quali non sono ancora riuscito ad arrivare; su conti intestati a familiari o a falsi nominativi, considerato che gli zingari sanno fare dei veri giochi di prestigio con le proprie generalità. Senza contare, poi, le varie cassette di sicurezza piene di refurtiva proveniente dagli appartamenti…”
“Scusa”, obietto, “ma come le hai scoperte tu certe cose, a maggior ragione dovrebbe saperlo la polizia”.
“La polizia le sa”, replica lui. “Però sembra non interessarsene. È come se questa gente fosse intoccabile”.
Tralascio l’argomento che mi pare spinoso e sviluppabile soltanto a livello di congetture. C’è un’altra questione non meno rilevante. Perché Carlo (handicappato, sfruttato, con la fedina pulita e un lavoro all’orizzonte) dovrà andarsene dal campo, e Renka no? E neppure uno degli “-ovic” stampigliati sugli estratti conto?
“È un mistero”, ammette Alberto. “I poveracci vengono sbattuti fuori, anche se non hanno fatto nulla di male o comunquc nulla di molto grave. I deliquenti, con i loro racket, rimangono indisturbati ad accumulare capitali. Il bello, racket a parte, è che simili decisioni spettano unicamente all’Ufficio Stranieri del comune. E lì sanno sempre con chi hanno a che fare”.
Mi ci è voluto poco tempo per controllare di persona le asserzioni di Alberto. Le sue analisi si sono rivelate esatte. Molti zingari innocui come Carlo, alcuni anche con titoli di merito, raccomandazioni di vescovi e uffici sindacali, attività di collaborazione con enti pubblici, rischiano di (o stanno per) essere allontanati dalle aree torinesi.
Gli appartenenti ai clan mafiosi invece non rischiano niente. Compreso (ed è solo un esempio) un energumeno che oltre ai suoi compagni ha aggredito anche il coordinatore comunale di un campo, con conseguenti strascichi giudiziari rapidamente risolti grazie all’esborso, senza batter ciglio, di una cinquantina di milioni.
A parte la gravità dei fatti, si profila evidente il pericolo cui tutti andiamo incontro. Gettati in mezzo a una strada, anche i più volonterosi saranno costretti a vagare senza speranza e, stavolta sì, a rubare per sopravvivere.
E l’Ufficio Stranieri, responsabile dei campi, come spiega tutto ciò? Non lo spiega. Il suo direttore, Alfredo Olivero, un prete, mi risponde telefonicamente che non intende ricevermi. Non ritiene utile parlare con un giornalista. Arrivederci e grazie.
Peccato, perché così non sapremo se l’esperimento torinese, additato come la soluzione al problema, rappresenti una speranza per il futuro o un ricettacolo di delinquenza malamente gestito. Se ad altri comuni convenga seguirne l’esempio, o se ci toccherà convivere con gli zingari come abbiamo fatto finora. Cioè danneggiati. E beffati, per di più, da chi ha trasformato il sacrosanto antirazzismo in una petulante professione.