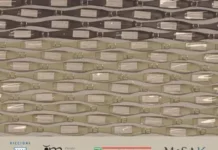Mentre gli ex no-global, o forse i loro discendenti, celebrano in rete (con facebook, instagram, twitter: colpa della pandemia, d’accordo, ma qualcosa non quadra) i primi vent’anni di resistenza alla globalizzazione neoliberista (vedi Porto Alegre, gennaio 2001), nel mondo reale le cose procedono. Di male in peggio.
Nel Bangladesh per esempio.
Il 18 gennaio, nel campo per rifugiati rohingya di Cox’s Bazar, un distretto nel sud-est del Paese, quattro scuole dell’UNICEF sono state ridotte in cenere. Ufficialmente, per le autorità locali, si tratterebbe di un incidente casuale (ma è plausibile che avvengano contemporaneamente ben quattro cortocircuiti?). Anche per il commissario bengalese responsabile per i rifugiati si sarebbe trattato di un “incendio scoppiato casualmente” (resta sempre il dubbio: vada per uno, ma quattro in contemporanea?)
Invece per le organizzazioni onusiane per l’infanzia siamo di fronte a un vero e proprio crimine, una serie di incendi appiccati ad arte. L’UNICEF ha parlato esplicitamente di un “incendio criminale, un attacco contro quattro centri di apprendistato nei campi per rifugiati”. Precisando che in questo modo viene colpita “l’educazione di oltre 300 bambini rifugiati, già sfavoriti”. Fortunatamente in quel momento le quattro scuole – strutture “non permanenti”, realizzate con materiale risultato infiammabile – erano vuote.
Qualche giorno prima un altro devastante incendio aveva colpito il campo di Nayapara, sempre nel sud-est del Paese, distruggendo almeno cinquecento baracche, per lo più in bambù, e lasciando all’addiaccio circa duemila rifugiati della minoranza musulmana. In questo caso tuttavia anche le agenzie onusiane non escludevano che l’incendio si fosse generato casualmente: non per un attentato, ma per lo scoppio di un bombola di gas.
Dal 2017 l’UNICEF gestisce in Bangladesh 2500 centri di apprendistato nei 34 campi per rifugiati che accolgono circa 750mila rohingya – provenienti dalla Birmania per sfuggire alla pulizia etnica operata dalla milizie buddiste – tra cui 240mila bambini. Al momento i centri sono ancora chiusi per la pandemia, ma con la speranza di poterli riaprire entro un mese o due.
Lavoratrici del sesso, un duplice sfruttamento
Dovrebbero essere alcune decine le “case chiuse” del Bangladesh, stimando ovviamente soltanto quelle “ufficiali”. Sottoposte inevitabilmente, dal marzo dell’anno scorso, alle restrizioni con cui il governo sta tentando di circoscrivere la diffusione del Covid-19. Il sindacato delle donne costrette alla prostituzione, Bangladesh Sex Workers Network, insieme a un’altra trentina di associazioni, sta cercando di lenire le accresciute sofferenze delle donne rimaste ora senza clienti. Per la stragrande maggioranza questo significa trovarsi nell’impossibilità di mantenere le proprie famiglie, nutrire i figli. In mancanza di interventi statali, il Bangladesh Sex Workers Network aveva rivolto un appello alle organizzazioni umanitarie della società civile, anche straniere. In molte hanno risposto venendo in aiuto. Con i fondi raccolti è stato possibile intervenire a sostegno di qualche migliaio di lavoratrici del sesso in difficoltà. Da segnalare l’opera dei volontari dell’associazione di Rina Akter che ha fornito centinaia di pasti.

Per Rahat Ara Nur, funzionario onusiano per la popolazione del Bangladesh, “solo un piccola minoranza di lavoratrici del sesso aveva un po’ di denaro messo da parte. La maggior parte di loro ora come ora non è in grado di sopravvivere”. Scelta quasi scontata per molte di queste donne: esercitare nelle strade. Esposte quindi alla violenza, ai rapporti non protetti e alle malattie, alla possibilità ricorrente di non venire nemmeno pagate.
Molte poi hanno denunciato di aver subìto ulteriori abusi sia dai conviventi (in quanto veniva meno una fonte di reddito), sia dai proprietari delle abitazioni a cui non potevano pagare l’affitto. E in molti casi si sono ritrovate senza un tetto, per strada. E trovare un altro lavoro risulta alquanto difficoltoso per la forte stigmatizzazione sociale a cui sono sottoposte.
Una situazione di inasprimento delle disuguaglianze che comunque non contamina solo il Bangladesh ma tutta l’area dell’Asia-Pacifico, con queste donne per lo più escluse dai programmi di protezione sociale. Sia perché tale lavoro rientra nella cosiddetta “economia informale”, sia perché gran parte di loro, in quanto immigrate – non possiedono i requisiti (una residenza ufficiale, una dichiarazione dei redditi, talvolta nemmeno documenti in regola) che consentirebbero l’accesso agli aiuti governativi.
Un discorso a parte quello sulla recrudescenza, nel corso della pandemia, delle discriminazioni e delle violazioni dei diritti umani, con arresti arbitrari e anche episodi di autentico racket nei confronti di queste donne da parte della polizia.
Bidonville rase al suolo
E la vita risulta piuttosto dura anche per altri diseredati bengalesi. Qualche giorno fa un tribunale di Dacca ha stabilito che diverse centinaia di baracche costruite ai bordi della strada che collega Mirpur-11 a Kalshi andavano demolite e gli abitanti – diverse migliaia – espulsi con la forza (leggi deportati). Ma l’ingiunzione ha provocato le proteste di queste donne e questi uomini che hanno accolto con lanci di pietre, tegole e mattoni le forze dell’ordine incaricate dello sgombero. Medesimo trattamento lo avevano riservato ai funzionari municipali e membri del partito al potere che erano accorsi a sostenere l’operazione.
Proprio da parte dei membri del partito governativo sono venuti gli attacchi più duri contro i manifestanti, mentre la polizia sparava proiettili di plastica. Alla fine, almeno ufficialmente, si sono contati una cinquantina di feriti.