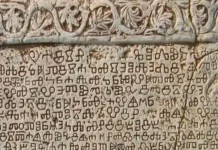In pieno periodo di crescita autonomistica, alcune regioni – come l’Emilia e la Liguria – sembrano non reagire all’italianizzazione sempre più aggressiva. Vediamo che succede nel capoluogo emiliano
Nel quadro dell’odierna situazione neo-autonomistica dell’Italia settentrionale l’Emilia-Romagna rappresenta un vuoto che certo stupisce, se non preoccupa.
Analizzare i problemi etnico linguistici del capoluogo è quindi una tappa obbligata per cercare di addentrarsi meglio nei sentimenti di questa ricca e cruciale regione. Si vuole qui tentarne un primo avvicinamento, rivolgendo l’attenzione a quel fattore che – anche se non unico – caratterizza almeno esteriormente un’etnia: l’uso dell’idioma locale; di quell’idioma che Dante, già “scolare in Bologna”, diceva di preferire sotto vari aspetti al suo fiorentino. Ora, da questo punto di vista, la situazione bolognese appare assai scoraggiante…
I reali utenti del bolognese al di sotto dei trent’anni di età sono una vera minoranza, numericamente irrilevante; nella fascia di mezz’età i “patoisanti” sono invece parecchi, forse i più, mentre, per gli anziani, ciò che è stato scritto per i giovani va invertito. Perché? Indubbiamente questa situazione riflette purtroppo una condizione più generale, italiana ed anche europea, di massificazione linguistico-culturale, ma a Bologna il fenomeno in questione appare particolarmente accentuato, specie rispetto alle finitime province di Modena e Ferrara ed alla Romagna.
La televisione e la radio che fanno da baby-sitter – invero perverse – ai bambini sono la prima, nota ragione di questo appiattimento. Non esiste una trasmissione locale interamente in lingua celto-padana, ma solo alcuni programmi “bolognesi” in cui il vernacolo è usato come intercalare, sia per TV che per radio; però a tarda ora capitano certe telefonate di vecchiette smaniose di partecipare al solito gioco a premi per vincere il calcolatore elettronico da regalare all’“anvaud”, il nipote, “parche l’à d’andèr a scola”. Ma, naturalmente, proprio perché il virgulto deve istruirsi a scuola, bisogna fare in modo che accantoni il “dialetto”: ecco spiegato il fenomeno, comunque incredibile, di signore che col marito e la madre si esprimono in dialetto, e coi figli invece in italiano, magari stentato, ma pur sempre italiano, lingua della scuola.
A proposito, la scuola in dialetto, anche in campagna, è un fatto attualmente utopico, vista la mentalità dei genitori, ma, anche se non a livello ufficiale, qualche iniziativa c’è; aiutati dalle nonne incredule, i bambini partecipano a qualche concorso di poesia bolognese, e mettono in scena pure delle recite.
In certe scuole, per lo più elementari, vengono insegnate ai bambini alcune frasi bolognesi, e forte è la richiesta di testi per l’infanzia in dialetto da parte di maestre “aperte”; ma purtroppo questi tipi di libri non vengono stampati.
Scarse iniziative
Non va tuttavia trascurato che alcuni editori locali pubblicano, con una certa frequenza, saggi di pochi benemeriti appassionati su aspetti della parlata e delle usanze popolari; ma i testi in lingua sono rarissimi, quasi sempre di qualità mediocre. Si deve invece segnalare l’interesse – tenuto vivo dagli stessi che produssero le prime edizioni (come Zanichelli) o da specialisti in ristampe anastatiche (come Forni) – per le opere ormai classiche di autori scomparsi, quali Alfredo Testoni e Olindo Guerrini, e per i vocabolari e le raccolte di proverbi e di testi che nell’Ottocento contrassegnarono, non solo a Bologna e nella sua regione ma in tutta la penisola, il fervido studio degli idiomi locali (e di fatto del bolognese uscirono nel secolo scorso almeno quattro vocabolari, di cui due recentemente ristampati). Ma queste ultime sono iniziative che si esauriscono nella cerchia di pochi iniziati, mentre nel complesso si può ben dire che ora la lingua scritta non fuoriesce da una realtà “folclorica”, fatta di manifestazioni rare ed episodiche e ben diverse da quelle di altri centri (sappiamo quali) del Nord.
In realtà anche le associazioni quali la Faméja bulgnaisa, la “Bologna storico-artistica”, la “Francesco Francia”, nate per difendere e propagandare il patrimonio culturale e artistico della città, non hanno i connotati per promuovere su Bologna un discorso più impegnativo per il recupero e la riaffermazione di una sua identità.
Il fenomeno dell’emigrazione dal sud, pur se non indifferente a Bologna, non ha inciso come altrove; invece si è verificato un movimento massiccio dalla stessa provincia, il che sul piano etnico non ha molto influito. Piuttosto il trovarsi ad essere in una posizione nodale per le comunicazioni e il commercio, con una presenza notevole di moderne industrie, ha reso questa città vulnerabile, trasformandola in metropoli quando la sua mentalità è ancora decisamente provinciale. E l’abbandono della campagna, come delle attività artigianali (a cui erano legate precise locuzioni dialettali degli strumenti e del concreto operare) ha contribuito a disperdere un patrimonio linguistico estremamente ricco.
Il bolognese, quando si sente legato alle proprie origini, è fiero di essere tale, gli piace la passeggiatina in centro, ama il pettegolezzo sottile, dice spesso che la sua lingua è la più bella del mondo, ma non la trasmette ai figli. È affetto da complessi d’inferiorità verso certe città e popoli che crede più “progrediti” (di qui una sorta di diffusa esterofilia), ma nello stesso tempo soffre di una sorda diffidenza, quando non di aperta avversione, per altre realtà sentite come estranee: e così affiora quell’antimeridionalismo che qui fa chiamare senza troppa benevolenza “marucchèin” chiunque sia nato a sud di Ancona. Al riguardo vien fatto di osservare che una migliore informazione sugli altri contribuirebbe a far riconoscere in modo più adeguato la propria individualità.
Molti giovani – e lo dichiarano con insistenza – proverebbero interesse a conoscere qualcosa della loro città, ma più che frequentare i teatri dove si esibisce ogni tanto Arrigo Lucchini con la sua compagnia, assistere a qualche spettacolo estivo dei burattini di Demetrio Presini e comprare i dischi di Dino Sarti non possono fare. Occorrono invece iniziative culturali non limitate o astratte, ma vaste e popolari, di cui però oggi non è dato vedere le linee e gli animatori.