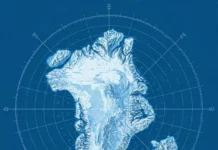Cos’è realmente la “memoria storica”? Proviamo a fare un esempio. Passeggiando per una grande città, capita di passare davanti a qualche edificio scolastico, tipo liceo o istituto tecnico. Le pareti esterne sono tappezzate di manifesti solitamente in bianco e nero, come se lo spirito del ciclostile non fosse mai svanito nella modernità, con slogan inneggianti a categorie sociali da secolo precedente come il proletariato, titoli di rappresentazioni teatrali in cantine o sottoscala, profusione di termini come okkupazione, lotta, collettivo anarchico, assemblea, manifestazione, presidio, vigilanza, centro sociale, spazio autogestito, cooperativa; oltre a mura coperte di scritte con vernici rosse, slogan antifascisti, stelle a 5 punte, falci e martelli e persino stencil di Lenin. L’arredo urbano che ne consegue, permeato di livore, squallore, senso del brutto, è esattamente identico a quello della mia adolescenza. Ora, poiché siamo nel 2015 e quell’adolescenza cominciava intorno al celebre ’68, vuol dire che questa faccenda dura da almeno 47 anni: mezzo secolo!
La velocità dei cambiamenti tecnologici e socio-demografici nella storia dell’uomo è direttamente proporzionale alla modernità del contesto. Due-tremila anni significavano uno sviluppo minimo all’epoca dei cacciatori raccoglitori maddaleniani, grosso modo come 100-200 anni in epoca protostorica. Ma già con il Rinascimento, e ancor più a partire dal Settecento, 20-30 anni hanno potuto rappresentare il passaggio dalla magia alla scienza, o dal barocco al classicismo. Un lustro a cavallo di una guerra, nei primi del Novecento, ha praticamente cancellato l’epoca vittoriana infilando a forza l’Inghilterra nella modernità sociale. Cinquant’anni, nell’èra contemporanea, non ci hanno portati dal calesse all’automobile, ma dal calesse all’aereo a reazione!
Memoria storica, allora, significa poter prendere uno di questi giovanotti che ogni lustro pensano di inventare un nuovo movimento di pensiero, metterlo in una capsula del tempo e spedirlo mezzo secolo addietro al cospetto del suo stesso istituto tecnico o liceo scientifico. Probabilmente, rendendosi conto di persona dell’incredibile cristallizzazione ambientale, ne rimarrebbe sconvolto, e forse anche a lui verrebbe fatto di chiedersi (come ci chiediamo noi) Chi o Cosa sia capace di trasmettere un’intera tradizione, virgole comprese, attraverso tre generazioni, allevando fantocci seriali… Ma in quale periodo storico si è mai espresso, il naturale ribellismo adolescenziale e postadolescenziale, con gli stessi simboli e gli stessi slogan per mezzo secolo?  Impossibile. Quindi, probabilmente, il soggetto in questione si sentirebbe una vittima manipolata da Qualcosa di più grande di lui, per un Disegno che non è in grado di comprendere (e nemmeno noi).
Impossibile. Quindi, probabilmente, il soggetto in questione si sentirebbe una vittima manipolata da Qualcosa di più grande di lui, per un Disegno che non è in grado di comprendere (e nemmeno noi).
Naturalmente la memoria storica non può esistere soltanto in presenza di una capsula del tempo, altrimenti ne mancherebbe persino il concetto. Senza scomodare i rapporti primigeni con il mito e la tradizione orale, tralasciando anche gli aspetti d’élite come la storiografia, per l’uomo moderno la memoria storica nella vita di tutti i giorni è stato il racconto della propria esperienza da parte di nonni e genitori, l’ascolto di testimonianze e ricostruzioni alla radio – e per qualche anno anche alla televisione – la lettura di libri e qualche analisi giornalistica su quotidiani e periodici. (La scuola, in teoria il luogo deputato a questa trasmissione culturale, non ha mai fatto molto per figurare nell’elenco.)
Ora, da qualche decennio – da quando cioè, secondo gli psicologi dello sviluppo, la struttura della famiglia è passata dal modello patriarcale a quello nucleare; da quando i nonni non sono più la voce autorevole a capotavola, e al loro posto troneggia spesso il televisore – l’educazione familiare dei bambini e dei ragazzi si è ridotta a poca cosa. Nove radio su dieci diffondono solo musica. Le trasmissioni televisive sono divise tra i programmi di intrattenimento e quelli di approfondimento; tranne che i secondi “approfondiscono” quasi soltanto le beghe politiche che sono esse stesse frutto ed espressione di un’assenza di senso del passato.
Un brutto esempio di oblio
L’incapacità dell’establishment politico culturale di onorare qualsiasi forma di memoria storica, che non siano slogan, raggiunge il culmine nella – appunto – Giornata della Memoria, in cui c’è tutto fuorché il ricordo. Intanto, se tre giovani concorrenti di un telequiz in prima serata su Rai 1, cioè tre diversi individui selezionati per poter rispondere a domande di carattere culturale, hanno affermato che Hitler è diventato cancelliere, rispettivamente, nel 1948, nel 1964 e nel 1979, c’è da chiedersi a chi sia rivolta la rimembranza della Shoah.
In un certo senso finisce per avere ragione il matematico Odifreddi quando sostiene che, per quanto ne sa lui, sterminio e camere a gas sono un’opinione e il processo di Norimberga “un’opera di propaganda”. Perché di fatto la Giornata è diventata parte della liturgia resistenziale (che a 70 anni dalla caduta di quei regimi non ha più alcuna relazione storica con essi, se non nei paramenti sacri) e non sembra avere il popolo ebraico come protagonista. È vero che l’Olocausto è stato scelto come paradigma di tutte le stragi della storia, essendo (forse) la più cruenta… In quest’accezione “esemplare”, suonano gravemente fuori luogo i distinguo di Odifreddi o di qualsiasi studioso che decidesse di revisionare (non negare) l’entità degli avvenimenti. In certi casi, forse, la Verità può anche fare due rispettosi passi indietro appetto all’Opportunità; e probabilmente, se fossi uno storico e scoprissi, documenti alla mano, che invece di 6 milioni ne sono stati assassinati 5, lascerei perdere. Come se al funerale di un grand’uomo, mentre tutti i presenti lo piangono sinceramente, uno si mettesse a gridare: “Sì, però non mi ha mai restituito i 100 euro che mi doveva”…
C’è però un limite al simbolismo, perché questo distacco completo dalla realtà sta provocando l’estinzione della Giornata della Memoria. Se nessun cittadino men che decrepito sa più chi sia Hitler, se i giovani sono convinti che nazismo e fascismo siano epiteti da urlare nei cortei, soprattutto se mezza (facciamo pure tre quarti di) stampa italiana, chiusa la celebrazione, il 28 gennaio ricomincia a spalare letame sopra Israele, c’è il caso che la Giornata entri a far parte del noioso calendario istituzionale della Repubblica Italiana. E di lì a dire “mavalà, una cosa del genere non può essere successa davvero”, il passo è breve.
Il collo di bottiglia
Il caso fantascientifico del “movimento studentesco” che muore e risorge come la fenice, producendo generazioni di direttori di quotidiani, non può che essere la punta di un iceberg. Difficile che un simile fenomeno proliferi in una società in progressione. E in effetti si tratta di una peculiarità tutta italiana, figlia di un mondo immobilizzato, imbalsamato. Se la funzione della Giornata è ammonirci a non ripetere gli errori del passato, la memoria storica, quantomeno a partire dalla fondazione della Repubblica, dovrebbe aiutarci a prendere atto che stiamo rifacendo le stesse cose da settant’anni, che dalla metà del secolo scorso stiamo recitando la medesima commedia. Stessi slogan, stessi partiti con nomi diversi, stessi gazzettieri, stesse polemiche quotidiane.
Forse a qualcuno è capitato, nel dipingere una parete, di stendere vecchi giornali ingialliti sul pavimento e, tra una pennellata e l’altra, chinarsi incuriosito a leggere quel mondo che balza fuori dal passato prossimo… Se nelle vetuste pagine degli esteri va in scena la storia, con Franco a capo della Spagna, lo Scià di Persia, gli Usa e l’Urss sull’orlo di un conflitto nucleare, in quelle nazionali sembra di essere finiti sul Corriere o la Stampa del giorno precedente: battibecco tra destra e sinistra, scontro sindacale, manifestazione con incidenti, il nuovo che avanza nella persona di un giovane politico, episodio di razzismo, forte richiamo all’unità nazionale, indipendenza dei giudici, colpo mortale alla camorra.
Commentare questa litania di ricorsi evenemenziali richiederebbe la professionalità del politologo, del sociologo, dell’economista, mentre a noi interesserebbe capire piuttosto per quale meccanismo “antropologico” l’essenza di quel passato sia svanita nel nulla; nel senso che nove 20-40enni su dieci che leggessero quelle pagine penserebbero di avere le traveggole: “davvero tutto ciò è gia successo pari pari?”.
Un collo di bottiglia analogo – ovviamente di proporzioni assai più vaste – si è verificato nell’Alto Medioevo, tra il V e l’VIII secolo, con il crollo europeo della conoscenza, soprattutto scientifica, astronomica e geografica. Ancor oggi, con l’ovvia esclusione degli studiosi, siamo in media culturalmente eredi di questa strozzatura, convinti che Colombo abbia scoperto l’America, Marco Polo l’estremo oriente e Copernico l’eliocentrismo. E ci stupiamo ancora parecchio nell’apprendere che i romani avevano navi enormi con cui circumnavigavano l’Africa (toccando possibilmente anche l’America, visto che oggigiorno c’è chi l’ha raggiunta con una barchetta a remi) e rotte di commercio con la Cina. Quanto all’astronomia, Eratostene nel III secolo a.C. riusciva a calcolare la circonferenza terrestre con un errore del 5%.
Il collo di bottiglia nell’evoluzione umana è sempre un problema perché fa perdere per strada un bel po’ del bagaglio accumulato e costringe a ricostruire da zero parte delle nozioni. Noi, con l’informatica, stiamo rischiando parecchio in questo senso. Chi ha una certa età e dimestichezza con i calcolatori ha probabilmente vissuto qualche esperienza poco simpatica con i supporti di archiviazione. Questi si conservano, certo, ma i dispositivi per leggerli e scriverli diventano rapidamente obsoleti. Così, se non ci ricordiamo di trasferire i nostri archivi a ogni passo evolutivo della tecnologia, rischiamo di ritrovarci con pacchi di floppy da 5¼ pollici che nessun computer sarà mai in grado di decifrare (e sta già diventando pericoloso affidare i nostri dati ai cd).
Anche sul lato software c’è da preoccuparsi. Possiamo avere testi fondamentali scritti a cavallo degli anni Ottanta e Novanta con Word55 che – a meno di non aver conservato il file eseguibile e farlo girare su una macchina virtuale – non riusciremo ad aprire con un word processor moderno. E c’è qualcosa di inquietante in questi libri che non sono più su carta, ma su file con mezza dozzina di protocolli diversi mirati a dispositivi di lettura che oggi ci sono e domani non si sa.
Ma probabilmente il vero collo di bottiglia informatico è internet. Qui il nodo non è per nulla tecnologico, non sono in discussione i supporti fisici né i protocolli di trasmissione dei dati, bensì l’aspetto culturale e cronologico della rete. Cioè, in primis, la tendenza a trasferire tutte le conoscenze all’interno di essa, eleggendola ormai ufficialmente a depositaria del sapere; e, in secundis, la giovinezza di questo strumento.
Il salto della rete
La rete di comunicazioni che chiamiamo internet è nata quattro decenni fa, ma ha cominciato a funzionare come strumento comunicativo di massa soltanto nella seconda metà degli anni Novanta.
Molti studiosi del fenomeno sono concordi nell’affermare che l’alluvione di dati fornita dalla rete ha profondamente modificato le nostre abitudini, facendo virtualmente estinguere il concetto stesso di ricerca. L’attività di “procacciarsi le informazioni” è da sempre parte del processo di apprendimento. La “fatica” per ottenere qualcosa non va intesa tanto come un valore morale, quanto in termini di arricchimento, acquisizione di competenze e, in ultima analisi, maggiore consapevolezza dell’oggetto ottenuto. Procacciarsi il cibo è ben diverso dall’essere nutriti attraverso un sondino, anche se la sua ricerca al giorno d’oggi può essere circoscritta alla sapienza di trovare cibi genuini o di tradizione, all’abilità di ottenere un buon rapporto qualità-prezzo, eccetera. Il risultato senza sforzo rende il cittadino moderno un semplice consumatore, cioè un soggetto eterodiretto e privo di reale decisionalità.
Fino agli anni Novanta inoltrati, la tradizione necessaria all’acquisizione dei dati, alla ricerca scolastica, all’approfondimento professionale, ha richiesto l’accesso “fisico” a una serie di luoghi e di strumenti, biblioteche pubbliche in testa. Quindi: libri da compulsare, magari in gran numero, per setacciare e ricostruire frammenti di informazioni; emeroteche con pubblicazioni materiali o riportate su microfilm da scorrere pazientemente; enciclopedie e dizionari da sfogliare alla ricerca di voci poco chiare; cartine ben disegnate. E se ciò non bastava, si poteva cercare qualche esperto per chiedergli aiuto, o rivolgersi a enti e associazioni specializzate.
Per ottenere tutto ciò era necessario uscire di casa, ottemperando a quel binomio movimento-apprendimento che per le neuroscienze è alla base dello sviluppo individuale. Come ha sostenuto lo studioso di tecnologie Nicholas Carr, “è inverosimile che il web ci aiuti ad accelerare il nostro lavoro, per esempio facendoci risparmiare tempo prezioso da dedicare ad altro come la lettura. Il nocciolo del problema è che il web crea una voglia e un bisogno incontrollati, proprio come quelli indotti dalla tossicodipendenza, di restare costantemente immersi in un flusso di nuova informazione e nuove notizie, senza approfondire nulla. Anzi, l’unica cosa che fa è renderci sempre più distratti”.
Un altro aspetto importante è che la stragrande maggioranza di queste fonti tradizionali erano (e sono) di produzione commerciale, quindi accurate e controllate, se non altro per considerazioni meramente utilitaristiche: chi investe denaro in una testata o in un libro non si affida al primo venuto. Dopodiché possiamo benissimo non condividere una virgola dei contenuti.
Ulteriore caratteristica del materiale tradizionale è di essere filogeneticamente progressivo: non ci sono salti cronologici o strutturali, né vuoti temporali o intervalli in cui i libri abbiano cessato di esistere o siano stati stampati tutti in alfabeto fenicio. La tranquilla, rassicurante, scomoda distribuzione di edicole, librerie e biblioteche assicura il rifornimento (per chi lo voglia) e la sopravvivenza (per tutti noi) dell’intero scibile umano.
L’avvento della rete ha stravolto tutto ciò, forse più di quanto siamo disposti ad ammettere. Si tende a minimizzarne l’impatto, per esempio sostenendo che, sì, i dati sono immensamente più numerosi e pertanto bisogna accertarsi che le fonti siano attendibili; oppure che, in fondo, si tratta soltanto di uno strumento in più a disposizione. Il guaio è che questo strumento non si è aggiunto agli altri, ma li ha sostituiti. Siamo franchi: chi di noi, di fronte a una definizione dubbia su wikipedia, si veste e corre alla biblioteca rionale per consultare la Treccani? Dice: ma vuoi non avere in casa 40 chili di Enciclopedia Taldeitali? Certo, quella il cui ultimo aggiornamento risale alla caduta del Muro di Berlino. In alternativa possiamo spendere decine di euro in enciclopedie digitali, ma la realtà è che ormai siamo abituati ad avere tutto gratis e a portata di clic.
“La rete ha rimpiazzato qualsiasi altro mezzo di comunicazione e di informazione”, osserva ancora Carr, “è ormai divenuta il medium per eccellenza, vale a dire il nostro unico canale dal quale trarre ogni genere di informazione o di servizio. Penso che ciò stia producendo un effetto particolarmente dirompente e profondo sulle abitudini della nostra mente. Penso che stia cambiando il nostro stesso modo di articolare il pensiero”. 1)
Questo ha in effetti modificato il modello della conoscenza. Perché non è affatto vero che sulla rete c’è tutto. Una porzione cospicua delle testimonianze umane di cui parlavamo prima è assente. Non ci sono i libri, per esempio. La sacrosanta esistenza dei diritti d’autore impedisce il loro sbarco sui monitor. Chi non “esce di casa” per procacciarsi le informazioni deve rinunciare alla lettura di un saggio. E non sono molti i quotidiani ad aver digitalizzato i loro archivi storici (il più illustre, il “Corriere della Sera” si ferma al 1992). Ovviamente non sosteniamo che un esperto non sia in grado di cavare parecchio buon materiale: pagando (o “craccando”) l’accesso a una pubblicazione accademica può leggere paper di alto livello, e dall’archivio della “Stampa” di Torino – caso forse unico – può anche recuperare la foto di un numero di fine ‘800. Quello che s’intende è che abbiamo digerito e metabolizzato il concetto di fruizione rapida; e se vogliamo sapere qualcosa delle Brigate Rosse, non andiamo a comprare o prendere in prestito il libro del giornalista specializzato, né perdiamo tre o quattro ore a frugare tra centinaia di vecchi articoli in formato jpeg, ma: 1) digitiamo i due termini su Google, 2) clicchiamo sul primo risultato che compare, cioè Wikipedia.
Gli stessi scienziati mostrano costernazione di fronte alla difficile accessibilità del sapere in forma cartacea. Joseph Stromberg, dello Smithsonian, osserva che il reperimento di dati d’archivio (in questo caso si riferisce a studi di biologia) più vecchi di una ventina d’anni è irrealizzabile al 90%, vanificando così la possibilità di confrontare i nuovi dati con quelli precedenti, di riprodurre gli esperimenti, di effettuare statistiche a lungo termine, eccetera.
Tra l’altro, sull’argomento Wikipedia è già stato detto molto da alcuni (non tantissimi) commentatori. Dal punto di vista scientifico, per esempio, uno studio americano ha calcolato che le voci legate a salute e medicina – le più delicate perché la gente ci si affida – sono imprecise o erronee al 90%. Gli esperti di web e ingegneria sociale, poi, hanno più volte descritto il controllo “politico” delle definizioni da parte di gruppi di potere.
Maledetti ricorsi
La cosa che colpisce, però, è che la popolazione italiana ha un’età media molto elevata: quasi 44 anni. Nel 2013, secondo l’Istat, gli ultrasessantacinquenni erano 12.639.829, con un indice di vecchiaia pari a 151,4 anziani ogni 100 giovani. Ciò significa che un esercito di studiosi, scrittori e soprattutto giornalisti dovrebbe abbracciare memoriter un subisso di decenni. E invece no. Per molti argomenti, il Secondo Dopoguerra è un immenso buco nero. Per esempio – ciò che ovviamente ci interessa più da vicino – tutte le questioni diciamo così “etniche” sono scomparse nel nulla.
Quando sono nati i primi grandi movimenti autonomisti del nord, negli anni ’80, tutti i commentatori sono caduti dalle nuvole, completamente dimentichi che le proteste padane per l’invasione italica, conseguenti perdite umane e danni vari, erano cominciate nei primi anni ’60. Si trattava di rimostranze, talvolta furibonde, a livello popolare, quindi senza convalida della diffusione mediatica, che si espandeva a macchia di leopardo dalla Linea LaSpezia-Senigallia in su tra amici, familiari, passeggeri del tram, conoscenti occasionali, circoli. Milioni di persone che vedevano il loro ambiente sociale sulla via della distruzione, oggi quasi completata. Tutti sembrano essersi scordati che negli anni ’80 in città come Torino e Milano non era quasi più possibile uscire di sera, e non c’era ancora in giro uno straniero nel senso del passaporto. Prima per il boom economico e oggi per la crisi, il flusso prosegue e – come paventava già trent’anni fa lo storico meridionale e contromeridionalista Virgilio Titone 2) – la Padania come tale è ormai soltanto un rottame in mano alla ‘ndràngheta.
Completamente dimenticati, anzi mai notati, i primi capitoli dell’immigrazione extraeuropea dalla metà degli ’80. Se si vanno a ripescare… meglio, se si riuscisse a ripescare gli articoli dei quotidiani, soprattutto nelle cronache locali, si scoprirebbe un giacimento di fatterelli, mezze dichiarazioni, abbozzi di slogan, indizi, che aiuterebbero a chiarire il mistero che sta dietro quest’orgia migratoria, oicofobica e xenomane in cui stiamo vivendo a livello politico e giornalistico. È un capitolo assolutamente fondamentale che approfondiremo in seguito. Limitiamoci a dire che, pur vedendosi in giro nelle città un africano ogni chilometro quadrato e zero nelle campagne, i politici del tempo sostenevano che dovevamo prepararci a una cittadinanza di 20 milioni di autoctoni e 30 di immigrati. 3) Strano, come facevano a saperlo in anticipo? Palla di vetro? Accordi con qualche emiro? Gran copia, inoltre, di fatterelli in cui la gente reagiva male ai primi episodi di violenza, furti e danneggiamenti, ed erano già pronti gli articoli sul Corriere che strillavano all’intolleranza, o i servizi della RAI che aggiungevano invariabilmente l’epiteto “feudo della Lega” al nome del Comune (ovviamente nordico) in cui si era verificato l’episodio. Alle prime proteste dei pensionati in un quartiere cittadino in cui la gente aveva paura di metter piede fuori casa, eccoti il corteo antirazzista con Dario Fo in colbacco e Franca Rame, seguiti da giocolieri e pistola sui trampoli. Già da subito messe in chiaro le politiche e le forze in campo da parte dell’establishment: noi importiamo masse umane per motivi che solo noialtri sappiamo, e se voi vi mettete di traverso vi insultiamo sui giornali, vi rinchiudiamo in casa a colpi di cortei e manifestazioni e, a partire dal terzo millennio, vi scateniamo contro anche la magistratura. Ah, a proposito di quest’ultima la memoria storica è oggi ai minimi termini:
Per i nativi internautici e la sterminata categoria dei brevimemori sarà fonte di stupore scoprire che situazioni reali, rapporti di potere, retroscena e slogan politici sopravvivono immutati da decenni. Leggendo le cronache di Titone, si prenderà atto che già all’inizio degli ’80 qualcuno descriveva la magistratura italiana come una setta asservita a interessi politici. In un convegno, il presidente della Commissione Giustizia della Camera definisce alcuni magistrati “protagonisti, faziosi, strumentalizzati, esibizionisti, che stravolgono il ruolo tradizionale del giudice, che dispongono di enormi poteri discrezionali”; e che sembrano avere una speciale predilezione per i peggiori delinquenti, tanto da perdonarli e renderli liberi appena possibile. Come dire che sono almeno trent’anni – ma in realtà molti di più – che la popolazione trangugia ingiustizie e attentati alla propria incolumità. Da un punto di vista della conoscenza, può davvero essere utile per i più giovani apprendere come le polemiche contro la magistratura siano di molto antecedenti al 1992, e quindi non un fenomeno berlusconiano. E suscita un misto di irritazione e pena leggere: “La recrudescenza dei delitti mafiosi, la più estesa infiltrazione della mafia negli organi del potere politico, burocratico, giudiziario, la diffusione della droga hanno determinato dalla seconda metà del 1982 una spettacolosa campagna antimafia, fatta di prediche, cortei, particolarmente di ragazzetti delle scuole medie, compiti in classe e naturalmente insopportabili tavole rotonde di intellettuali”. Trentadue (32) anni fa… 4)
Potremmo andare avanti all’infinito a citare situazioni in cui gli “intellettuali” dimostrano di non avere un minimo di memoria storica, e quindi di non capire un cavolo della realtà di oggi. Ma facciamo solo un esempio. Clamoroso. I nostri antenati chiamavano quei tizi che arrivavano via mare dal Nordafrica “saraceni”. Vi dice niente?
N O T E
1) “La Stampa”, Tuttoscienze, 6-10-2010.
2) Torna La festa del pianto, il “capolavoro scomparso” del contro meridionalismo, “Etnie”.
3) Mi sembra che queste cifre in particolare le abbia dette Francesco De Lorenzo.
4) ibidem