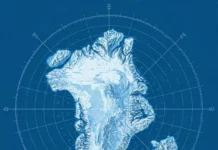Con questo orrore per le differenze razziali e gli eventuali lazzi e giochi di parole – spesso bonari – che ne derivano, stiamo veramente esagerando. E che adesso ci si metta anche un’organizzazione serissima e meritoria come Cultural Survival sembra un po’ eccessivo. L’ente americano, che difende le popolazioni aborigene del pianeta dallo sfruttamento e dalla distruzione culturale (quando non fisica), ha avviato una campagna per abolire le “racist native mascots”, intendendo con il termine mascot le forme di rappresentazione caricaturali ma anche, e soprattutto, l’abitudine tutta americana di utilizzare emblemi etnici negli stemmi di squadre e scuole.
Secondo CS, si tratta di un’iconografia fondamentalmente razzista, basata su stereotipi. Per esempio, la cultura sportiva è piena di riferimenti iconografici al guerriero pellerossa, con grande sfoggio di pitture di guerra, copricapi piumati, tomahawk, e danze tribali eseguite da tifosi e figuranti (la squadra più famosa ad adottare queste coreografie è il Washington Redskins, della National Footbal League).
Per combattere l’abitudine (definita “appropriazione culturale”, cioè sfruttamento di espressioni etniche al di fuori del loro contesto), Cultural Survival fornisce persino una lettera tipo da inviare ad autorità politiche e istituzionali per richiedere la cancellazione di una mascot.
Bisogna ammettere che le campagne per l’abolizione dei simboli etnici esistono dagli anni ’70 e hanno portato alla rimozione di circa due terzi di essi, e anche che le suddette campagne sono state avviate spesso dalle organizzazioni dei nativi. Probabilmente con ottime ragioni in alcuni casi, un po’ meno in altri. In sostanza, spulciando tra le decine di petizioni, interrogazioni e delibere, si arriva alla conclusione che il problema è limitato all’iconografia riguardante le nazioni indiane.
Lo stesso manifesto dell’iniziativa riporta quattro caricature – un pellerossa, un cinese, un africano e un ispanico – ma poi, nella trattazione e nella casistica, si riferisce unicamente alle comunità amerinde. Il motivo, si può ipotizzare, è che negli USA l’unica forma di autoctonia sia rappresentata da loro, e gli altri tre disegni compaiano per correttezza politica. Ma c’è anche una seconda ipotesi: che negli Stati Uniti (e non solo negli Stati Uniti) l’unica etnia non caucasica a
 essere sfruttata come marchio sia proprio quella indiana. I bianchi, diciamolo chiaro, non hanno mai guardato ad altre razze come modelli. Nel caso di certe popolazioni “primitive” (ce ne sono in tutti i continenti), dotate di un rispetto per l’ambiente e la persona che noi neanche ci sogniamo, faremmo bene a prendere parecchie ripetizioni, ma non c’è verso di considerarli dei simboli. Con l’eccezione dei pellerosse. Tutti i bambini europei e americani da un secolo giocano agli indiani, mentre nessuno gioca all’africano, al cinese o al messicano. E, siamo disposti a scommettere, nessuna squadra o college o università si fregia di una di queste tre espressioni dell’Uomo.
essere sfruttata come marchio sia proprio quella indiana. I bianchi, diciamolo chiaro, non hanno mai guardato ad altre razze come modelli. Nel caso di certe popolazioni “primitive” (ce ne sono in tutti i continenti), dotate di un rispetto per l’ambiente e la persona che noi neanche ci sogniamo, faremmo bene a prendere parecchie ripetizioni, ma non c’è verso di considerarli dei simboli. Con l’eccezione dei pellerosse. Tutti i bambini europei e americani da un secolo giocano agli indiani, mentre nessuno gioca all’africano, al cinese o al messicano. E, siamo disposti a scommettere, nessuna squadra o college o università si fregia di una di queste tre espressioni dell’Uomo.
Il punto non è il possibile disprezzo nei confronti di questi ultimi (l’abbiamo già detto, i bianchi non venerano nessun’altra razza, né a grande maggioranza la disprezzano), ma l’insolito e probabilmente unico misto di affetto e ammirazione che nutriamo per gli indiani del Nordamerica. Alcuni antropologi hanno osservato che la popolazione americana bianca ha molte più gocce di sangue indiano nelle vene di quanto si tenda a credere. E il filosofo Robert Pirsig ha rilevato come questa eredità genetica affiori in certi comportamenti “di frontiera” diffusi oltre Atlantico.

Eppure i redskins hanno dovuto affrontare una dose di stereotipi ben superiore ad altri popoli, se non altro perché coprotagonisti di un intero filone cinematografico, il western, che li ha visti oggetti di due trattamenti opposti: “l’indiano buono è quello morto” alla John Wayne, prima, e “l’indiano massacrato dal bianco cattivo” da Soldato Blu in poi. Sta di fatto, però, che quel rispetto “genetico” dell’americano non è mancato in entrambe le versioni. Il selvaggio alla Ombre Rosse è crudele, spietato, ma anche coraggioso, forte, agile, gran cavaliere e tiratore infallibile, un nemico formidabile; tanto che al di qua dell’oceano molti bambini sceglievano di recitarne il ruolo.
La cosa sconcertante è che scorrendo a decine le mascots tanto vituperate, si nota la preminenza dell’indiano fiero, del guerriero, soprattutto con il copricapo multiplume da cerimonia, così come si potrebbe utilizzare (e di fatto si utilizza) un soldato romano, un guerriero vichingo o un cavaliere medievale, a indicare forza, coraggio e spirito indomito. È questa la simbologia da condannare? A ben vedere, è ancora migliore qualitativamente di quella che ha fatto innamorare i nostri ragazzi di qualche decennio fa, mancando dell’aspetto crudele. A ben vedere, è molto migliore della realtà di certi insediamenti indiani negli Stati Uniti, dove (a differenza del Canada) una politica infame ha portato soltanto povertà e alcolismo.
Dopodiché Cultural Survival può pubblicare il suo quartetto di caricature, basato certamente su stereotipi, ma non pretendere che siano razziste o insultanti. I problemi dei popoli nativi sono altri.