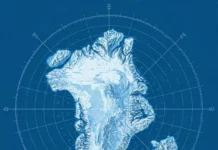La figura dell’uomo selvatico ha gran posto nel folklore biellese, ma ha fatto capolino non solo sotto le spoglie del santo vestito di foglie d’una statua della cappelletta della Bursch che sale da Campiglia al santuario di San Giovanni, ma spunta anche in un luogo imprevisto. Un’attenta e cortese lettrice mi ha infatti segnalato che, sul soffitto del sacello al santuario dl’Urupa, uno dei personaggi raffigurati che dovrebbe rappresentare San Giovanni è vestito con il vascapon, il mantello impermeabile d’erba carex 1) dei pastori biellesi: questo veniva considerato il costume tradizionale dell’uomo selvatico della montagna, nonché di quel singolare affollamento di figure fantastiche appartenenti al “piccolo popolo” di elfi e di esseri fatati coi piedi d’oca.
Al loro mondo mitico e fuori del tempo appartiene a pieno titolo anche il pastore errante delle montagne, noto col nomignolo di crusch, lo stesso termine con cui nel leggendario dei Grigioni svizzeri vengono chiamati i piccoli esseri fatati che vivrebbero tra le malghe e gli alpeggi come gli gnomi valsesiani.
Rimasti ai margini del processo di omologazione culturale e spirituale imposto per secoli dai ceti dominanti, i pastori parlavano differente perché pensavano diversamente, e come forma di autoconservazione e di difesa avevano elaborato un particolare “gergo furbesco” criptico e misterioso. Anni addietro è stato stampato nel Biellese un minuscolo e ormai introvabile opuscolo sulla lingua dei pastori, intitolato Slacadùra di Tacolér, con il testo d’un manuale curato una sessantina d’anni prima da Giuseppe Facchinetti, “allora ultimo e più fortunato rappresentante di una famiglia di pastori lombardi” che aveva raccolto i termini in uso fra la gente della montagna, offrendolo come “guida per tutti i pastori bergamaschi, veronesi, della Val Camonica, tirolesi, ecc., che vanno per il mondo”.
Era una sorta di esperanto montanaro in parte transitato dritto dritto nelle parlate alpine; insomma “un linguaggio convenzionale che accumuna i pastori nei disagi e nelle fatiche della professione, dando loro modo di comunicare e di scambiare le proprie idee in modo pratico e chiaro”.
La slacadura, il parlare del crusch, conteneva definizioni suggestive come verdosa per erba, povrosa per farina, gacc per brutto, scaj per soldi, scarviné per bastonare o empeltré per mostrare d’aver compreso.
Erano parole incomprensibili oltre il mondo chiuso dei nomadi della montagna.
Quando l’opuscoletto di Facchinetti venne ristampato, si ebbe l’accortezza di precisare che i “pastori erano di certo un popolo, ma ora non lo sono più per tante ragioni facilmente intuibili. La loro lingua che scompare è una di queste cause, non meno importante di altre”.
Il pastore nella maggior parte dei casi era un estraneo poiché proveniva da un paese lontano, in molti casi dalla Bergamasca; e oltretutto usava proprio quel gergo del tutto particolare che era una delle tante parlate artificiali usate da un ristretto gruppo di appartenenti a una particolare categoria di lavoratori (come quello dei muratori o la rëlla dij Ciòlin, gli sternitori di Graja/Graglia) o di gruppi sociali emarginati (come il “giudeo-piemontese” usato nei ghetti).
Proprio la cripticità della parlata garantiva ai marginali delle Alpi un vantaggio non trascurabile di fronte agli estranei, gli scuciat, i sedentari: tutti, dai margari ai turisti, guardati con sospetto e timore.
L’estraneità del pastore era evidente anche dal modo trascurato e “selvaggio” del vestire, poiché indossava quasi sempre lunghe mantelline nere di lana che venivano tessute da una ditta bergamasca.
A vederlo da lontano, fermo a controllare il gregge, con in capo un cappellaccio nero e l’immancabile bastone poteva ricordare l’“òm ëd pera” e la scultura spontanea caratteristica delle montagne; ed era tenuto in forte sospetto dagli stessi margari, i quali lo consideravano un làder d’erba che raramente rispettava i confini dei pascoli segnati con le croci incise sulle pietre. Il fèjat, l’uomo delle pecore, non conosceva le proprietà e si distingueva dal margaro che saliva all’alpeggio all’inizio della stagione, vi si stabiliva per l’estate e scendeva all’arrivo del brutto tempo.
Il crusch senza terra, invece, restava lassù tutto l’anno nelle poche grange aperte a tutti anche quando l’erba era scarsa. Scendeva malvolentieri solo quando vedeva arrivare la neve alta, adattandosi a cercare gli avari pascoli lungo il Sesia e riparandosi alla bell’e meglio con il patum, un giaciglio di pelli di pecora avvolto nella tela cerata, con gli scarponi per cuscino e il paraluscia, l’ombrello, come riparo.
La sua era una vita dura per uomini speciali.
Doveva arrangiarsi a fare un po’ di tutto, conosceva a perfezione la tecnica casearia, ed è ben probabile che la figura leggendaria dello straniero maestro nei segreti per la lavorazione del latte e del burro memorizzi un lontano passaggio di saperi lasciati in dono ai primi alpigiani del posto da un “crusch ramingher”, un pastore errante.
Ma la sua caratteristica principale consisteva nel vivere solitario e nel trascorrere la maggior parte del tempo a pensare, fantasticare, sognare, tanto da potersi ritenere che gran parte del leggendario alpino biellese sia frutto delle sue meditazioni, mentre un concerto di sonaje (campanacci) lo ispirava e lo estasiava assaporando l’aria fine e pura delle terre libere, senza i vincoli, spesso assurdi e sempre oppressivi, della società urbana.
Era soprattutto un anarchico della montagna.

N O T E
1) La Carex brunnea, o carice, è una pianta erbacea perenne che forma estesi tappeti erbosi.