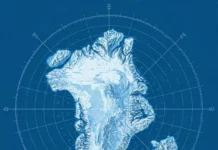Molti analisti notano che da qualche anno la stampa europea, soprattutto, ma anche quella americana e canadese, ha un proprio linguaggio in codice per minimizzare le azioni violente dei musulmani nei Paesi occidentali. Si usano volentieri termini sostitutivi a quelli di base – cioè terrorismo islamico, terrorista islamico – chiamando in causa di volta in volta la delinquenza comune, l’estremismo e, ultimamente, il disturbo mentale.
In un recente articolo, Guy Millière spiega bene questa situazione dal punto di vista di un francese, cioè di chi vive in un Paese sull’orlo di una catastrofe antropologica propiziata da un governo che applica una feroce censura fascista a chiunque, non già aggredisca i seguaci di Maometto, ma solo manifesti qualche dubbio sulla loro capacità di convivere con chi li ospita: “Molti francesi che hanno criticato pubblicamente l’islam e le sue conseguenze sono stati severamente condannati dal sistema giudiziario”, denuncia il politologo. E aggiunge una carrellata di atti terroristici in cui numerosi suoi concittadini sono stati uccisi o feriti da nordafricani e arabi che gridavano “Allahu Akbar” durante le aggressioni. In ciascun caso, la polizia e i giornali del regime hanno affermato che si tratta di uno “squilibrato”, che l’uomo “soffre di disturbi mentali” e che la sua destinazione è invariabilmente il manicomio. “Nessuno sa quanti ‘squilibrati’ siano pronti ad agire in Francia urlando che Allah è grande”, conclude sconsolato Millière. “Secondo i sindacati di polizia, se troppi ‘malati di mente’ decidessero di agire, le forze dell’ordine non sarebbero in grado di proteggere la popolazione”.
Altri articoli di varia provenienza sottolineano questa falsificazione, comune a tutti i Paesi occidentali, che sembra fatta apposta per nascondere ai relativi cittadini che l’islam sta portando il terrorismo nelle loro strade.
Pur concordando con gli autori sull’infame operazione di questi governanti senza gli attributi – quando non collusi con i tagliagole – vedo però un barlume di verità nel continuo richiamo alle patologie mentali. Non in quanto i singoli attentatori siano dei deficienti slegati dai movimenti jihadisti – come pretendono i cronisti – ma, al contrario, proprio nel senso che i movimenti jihadisti sono formati da psicopatici. Quando vediamo i filmati di costoro che gettano l’omosessuale dal tetto e poi lo finiscono a sassate, o allorché il sito del califfo apre le consultazioni via internet su come trucidare il pilota giordano, siamo davvero convinti di avere a che fare con gente che prende troppo sul serio una religione? Crediamo onestamente che “francesi”, “italiani, “britannici” e “olandesi” di seconda o terza generazione (spero che l’inferno abbia un girone riservato agli ius-solisti) vadano a combattere per un ideale, e non perché in “patria” non gli riesce così facile torturare qualcuno o stuprare una bambina?
Infime fesserie sociali producono dibattiti tra esperti, analisi sociologiche, libri e articoli; ma, guarda caso, trattandosi di “etnicamente corretto”, ecco che neanche una parola si spende per analizzare questo immane fenomeno di sadismo collettivo che sta mettendo in ombra, nella classifica nera della storia, la barbarie del nazionalsocialismo.
Religione e criminalità
Qualcosa si è provato a fare, tuttavia. Lo psicologo danese Nicolai Sennels, che ha lavorato anche nelle locali carceri giovanili – e quindi a contatto diretto con i musulmani, che costituiscono il 70% dei detenuti in Danimarca – si è chiesto perché i comportamenti psicopatologici, pur presenti all’interno di tutte le culture e religioni, siano appannaggio quasi esclusivo delle comunità islamiche: “Le stragi di massa quotidiane, i massacri delle famiglie, il terrore, le persecuzioni da parte dei seguaci dell’islam lasciano nauseati”, commenta Sennels. “Soprattutto l’ingegnosità con cui vengono perpetrati: dirottare un jumbo e lanciarlo contro un grattacielo, uccidere innocenti disarmati in un centro commerciale con granate a armi automatiche, impiantare bombe nel corpo di qualcuno, attaccare lame rotanti ai pickup e usarle come falciauomini, massacrare i propri familiari con acidi e coltelli, impiccare persone a una gru davanti alla folla festante, e via andare. Al punto che uno si chiede: cosa può aver provocato una tale mancanza di empatia, anzi, una simile gioia nel far del male a chiunque si percepisca come nemico?”
Giustamente Sennels osserva che rispondere tocca a un esperto di psicologia. E di fatto, osservando il comportamento dei giovani delinquenti rinchiusi nei correzionali danesi, si è reso conto che quelli di background musulmano hanno caratteristiche proprie, che parlano chiaramente di un’impronta comune e ben riconoscibile ricevuta in famiglia. Le sue considerazioni, se espresse in Francia, lo porterebbero dritto in galera: “Sono giunto alla conclusione che l’islam e la cultura musulmana hanno determinati meccanismi psicologici che danneggiano lo sviluppo delle persone e favoriscono il comportamento criminale”.
Sennels si dice consapevole del fatto che i musulmani non sono identici, e non tutti “seguono il messaggio violento e perverso del Corano” ma, come d’altronde qualsiasi altra religione, l’islam influenza più o meno tutti i suoi seguaci e la cultura in cui vivono. Forse involontariamente, egli apre la porta a quel concetto, espresso da molti analisti, secondo cui l’islam moderato non esiste se non in presenza di “cattivi” musulmani che, appunto, non seguono il Corano. È vero che alcuni aspetti infami nei confronti delle donne o degli infedeli non sono presenti nelle sure, puri sadismi di alcune scuole coraniche, ma per tantissimi altri risvolti della convivenza umana il sacro libro parla spietatamente chiaro.
Sennels individua due gruppi di meccanismi psicologici. Il primo è intimamente connesso con la dottrina, che mira a inculcare i valori islamici nei bambini il più presto possibile e con ogni mezzo necessario, compresa la violenza e l’intimidazione. È abbastanza comprensibile la preoccupazione di un genitore per le eventuali scelte dei figli, visto che la sharia contempla la pena di morte per chi abbracci un’altra religione. Il secondo gruppo comprende meccanismi più culturali e psicologici, “conseguenza naturale di essere influenzati da una religione siffatta e derivanti da una società tribale vecchia di 1400 anni con poca o nessuna libertà di oltrepassare i limiti imposti dalla dottrina”.
Metodi di lavaggio del cervello nell’educazione infantile
Per riuscire a indurre masse di individui a pensare e agire contro la propria natura umana, per convincerli a odiare e uccidere altri individui che neppure conoscono, servono metodi assai efficaci. Uno assai sperimentato dai regimi totalitari e dalle sètte religiose più spietate è l’effetto combinato di dolore e ripetizione, che consiste nello spezzare la resistenza del soggetto infliggendogli una sofferenza psicologica o fisica, accompagnata dalla costante reiterazione di un messaggio.
“Grazie alle sedute con oltre un centinaio di pazienti musulmani, ho scoperto che violenza e ripetizione di messaggi religiosi sono all’ordine del giorno nelle loro famiglie”, rivela Sennels. In breve, secondo lo studioso, questo tipo di cultura non ha un grado di comprensione dello sviluppo infantile paragonabile a quello delle società “civilizzate”, e dolore fisico e minacce sono spesso lo strumento privilegiato per crescere i figli. Ciò spiega perché così tante ragazze musulmane accettano come normale la brutalità nel loro matrimonio, perché i ragazzi crescono convinti che la violenza sia uno stile di vita accettabile. Ed è il motivo principale per cui nove bambini su dieci sottratti ai loro genitori dalle autorità di Copenaghen appartengono a famiglie di immigrati.
La tradizione musulmana di usare il dolore e l’intimidazione come strumento disciplinare è ampiamente utilizzato anche nelle scuole musulmane, comprese quelle presenti nei Paesi occidentali. E qui tornano in mente le aggressioni, una decina d’anni fa, a Magdi Allam da parte di un gruppo di psicopedagogiste che difendevano l’istituzione di scuole “arabe” a Milano (come quella di via Quaranta, rivelatasi poi una vera e propria madrassa). Esperte – e lo affermo per esperienza personale – capaci di censurare un asilo nido perché l’inserimento di un bimbo è un po’ troppo rapido, ma disposte a tollerare in nome di un multiculturalismo d’accatto che esistano scuole teleguidate da un imam.
L’indottrinamento ripetitivo si svolge recitando senza fine i versetti del Corano (al-qur’ān vuol dire proprio “la recitazione”) a scuola e in famiglia, e ciò comporta una totale ignoranza dell’universo circostante unita a un disorientamento psicologico, all’atrofizzazione di quella dote evolutiva che chiamiamo “teoria della mente”, ovvero la capacità di immedesimazione negli altri esseri umani.
Quattro fattori psicologici determinanti
Se l’educazione islamica ricorda per certi versi i metodi professionali di lavaggio del cervello, la cultura stessa che ne proviene coltiva – secondo Nicolai Sennels – quattro sviluppi psicologici che alimentano vieppiù i comportamenti violenti. Parliamo di ira, prosopopea, irresponsabilità, intolleranza.
Nelle società occidentali, la rabbia è quasi sempre considerata un segno di debolezza. Chi si lascia andare a esplosioni incontrollate, da noi, tende a essere socialmente emarginato. Nelle società islamiche, al contrario, le esplosioni d’ira appaiono come manifestazioni di forza e di status sociale. “Vediamo intere comunità etniche o Paesi proclamare giornate di ‘rabbia santa’, un termine che sembrerebbe contraddittorio nelle culture pacifiche”.
Dalle nostre parti, per “fiducia in se stessi” si intende la capacità di accettare e far proprie le critiche quando sono costruttive, o di lasciarle cadere con una scrollata di spalle se non lo sono. Non è un mistero per nessuno che nel mondo islamico questo non succede. “Qui la critica, non importa quanto fondata, è considerata un attacco al proprio onore, e ci si aspetta che esso venga smacchiato con qualsiasi mezzo necessario a zittire l’interlocutore”. Questo atteggiamento, da noi, viene definito arroganza, presunzione, prosopopea… tutto tranne che fiducia in se stessi.
Il terzo fattore psicologico ha a che fare con la responsabilità individuale, la libera scelta. Gli individui allevati secondo gli standard occidentali hanno un cosiddetto luogo di controllo interno grazie al quale la vita viene interpretata come una serie di eventi in gran parte gestiti dall’individuo, con azioni disciplinate dalla propria personalità, visione del mondo, gestione delle emozioni, eccetera. Al contrario, i musulmani crescono convinti che la loro intera vita sia pilotata dall’esterno: “tutto quanto avviene inshallah, se Allah lo vuole, e la congerie infinita di leggi religiose, tradizioni e potenti autorità maschili lascia pochissimo spazio alla responsabilità individuale. Questa è la causa della loro tipica mentalità vittimistica, per cui sono sempre gli altri da biasimare e punire per le condizioni che essi stessi si sono autocreate”.
Il quarto fattore psicologico che li rende vulnerabili ai messaggi violenti riguarda la tolleranza. Se per i nostri canoni una brava persona è tendenzialmente aperta e tollerante, a loro viene insegnato precocemente che i musulmani sono superiori ai non musulmani, che sono destinati a dominarli e che devono prendere le distanze, socialmente ed emotivamente, dai “diversi”. “I numerosi passi disumanizzanti del Corano e degli Hadith contro i non musulmani sono molto simili alla propaganda psicologica che i leader usano contro il loro stesso popolo, al fine di prepararlo mentalmente a combattere e sterminare il nemico. Uccidere un’altra persona è più facile se la odi e non la percepisci come pienamente umano”.
Un interrogativo etnistico
D’altronde la disumanizzazione è il metodo elettivo del razzismo (quello vero!), iniziato nel XVIII secolo proprio grazie all’emersione della scienza moderna, e quindi alla possibilità di manipolarla per attribuire caratteristiche non umane ad alcuni popoli a seconda delle convenienze: gli africani per usarli come schiavi, gli indiani d’America per prendere le loro terre, gli ebrei per giustificarne il massacro, eccetera.
L’approccio puramente psicologico lascia comunque qualche perplessità. Da una parte lo si vorrebbe più presente nelle osservazioni etniche, che a causa del politicamente corretto rifuggono spesso dall’analisi comportamentale delle comunità umane (a proposito di “paura della diversità”!). Dall’altra perché i canoni della psicologia, della psicanalisi e della psichiatria sono stati inventati appositamente per gli individui o al massimo per categorie di individui all’interno di una collettività omogenea. Fa invece parte delle nozioni elementari dell’antropologia il concetto che quello che è asociale o parafiliaco in una società umana non lo è in un’altra. L’antropologia, inoltre, può tener conto di substrati evolutivi, genetici, biologici, storici e persino climatici che, presi nel loro insieme statistico, riescono ad analizzare l’indole attuale delle popolazioni.
Ma con l’islam l’operazione è ardua anche per l’etnismo di formazione antropologica. Secondo uno dei suoi fondamenti, l’etnia è (indipendentemente dalla metodologia usata per tracciarne i “confini”) per definizione il risultato di una serie di caratteri; e, in quanto somma, virtualmente tutte le manifestazioni di una comunità ne sono un attributo. È un tratto etnico la capacità imprenditoriale di un popolo, oppure la sua tendenza a rispettare norme interne o nei rapporti con i vicini, come dire che – a meno di subire invasioni armate, come è avvenuto per alcuni satelliti dell’URSS – ciascuna regione o nazione è responsabile delle proprie fortune.
Ora l’islam, pur autoreferenziandosi come “popolo”, è tutt’altro. È una religione, un’ideologia se si preferisce, estesa alle nazioni autoctone di due continenti, Asia e Africa, con un paio di microisole in Europa. Vi aderiscono popolazioni diversissime per radici e cultura originaria.
Ma la religione, in definitiva, è un tratto etnico o sfugge alle leggi dell’etnia? Per alcuni versi è vera la prima. Certe cosiddette guerre di religione di fatto non lo sono state, come nel caso irlandese in cui a scontrarsi non furono cattolici e protestanti (le confessioni qui erano più che altro bandiere), bensì autoctoni irlandesi e colonizzatori britannici, in gran parte inglesi e scozzesi. D’altronde, se esistono Paesi come la Germania, e non solo, in cui metà della popolazione è protestante e l’altra cattolica senza il volare di un insulto, significa che vere frizioni confessionali all’interno della cristianità non esistono (più).
Per altri versi la trans-etnicità delle varie fedi, buddismo compreso, induce a dubitarne. Forse possiamo appellarci al fatto innegabile che l’ethnicity è in perenne formazione nel corso dei millenni, e può creare un tratto etnico – economia, arte, religione, ideologia – a propria immagine, oppure essere influenzata da quelli di altre popolazioni, al punto da attraversare uno stadio di modificazione.
È comunque evidente l’interpretazione “personale” del gruppo alla luce della propria indole preesistente. Come il latino si parastratifica su lingue autoctone dando vita ai volgari, così ideologie, filosofie e religioni risentono innegabilmente delle culture locali. E siccome non esistono soltanto etnie isolate, ma gruppi, “blocchi” che hanno caratteri affini e a mano a mano, scendendo la piramide, si stemperano nel collettivo dell’umanità, accade che popolazioni diverse ma non troppo possano avere in comune un terreno di coltura adatto al proliferare di determinate idee.
La creazione del culto maomettano è probabilmente il portato etnico delle genti arabe del VII secolo, così come il cristianesimo lo è di quelle ebraiche di sette secoli prima. La differenza tra le due fedi sta nella modificazione attraverso i secoli, quasi inesistente nella prima, adattata alle culture europee la seconda. La prima è stata estesa con le armi alle popolazioni circostanti, la seconda è stata recepita dai “bianchi” e imposta con violenza preferibilmente in regioni lontane, come l’Africa e le Americhe. Resta il fatto che l’islam ha potuto attecchire in aree dove già era presente una mentalità tribale, cruenta e iperpatriarcale, mentre neppure con le armi è riuscito a imporsi nei suoi domini europei, penisola iberica in testa. 1)
Anzi, a ben vedere è proprio l’isoletta europea in cui questa religione è ancora presente (s’intende a livello di autoctoni, non di immigrati), ossia la Bosnia, a dimostrare che la struttura antropologica delle nostre genti non è il terreno adatto per seminare l’ortodossia islamica.
Se l’Europa è Europa…
La Bosnia, regione di etnia slava, probabilmente illirica, è stata cristiana fino alla conquista turca del 1463. Perché proprio queste genti, tra tante realtà balcaniche assoggettate all’impero ottomano, si siano lasciate convertire non è facile da comprendere. Per una serie di facilitazioni amministrative da parte del sultano, comunque, i bosniaci potevano essere assai “meno rigorosi di altre comunità musulmane nell’osservare alcune pratiche islamiche: era molto diffusa la rakia (bevanda alcolica), l’uso del velo era spesso ignorato, così come i matrimoni combinati”. 2)
Nei secoli successivi la Bosnia rinforzò un suo assetto sociale che consisteva, e consiste tuttora, in una comunità plurireligiosa dove cristiani (cattolici e ortodossi), ebrei e musulmani convivevano tranquillamente. La cosa era possibile perché tutti o quasi erano europei, slavi e parlavano serbo-croato. Con il crollo della Iugoslavia, il potenziale etnico dei suoi componenti si sprigiona e per i bosniaci, stretti tra serbi e croati, l’appartenenza musulmana diventa una delle possibili bandiere da opporre.
A tentare di convincere il mondo che dal 1992 al 1995 in Bosnia sia esplosa una guerra tra religioni è stata fondamentalmente la propaganda di Ankara. Ma di fatto, malgrado tutti i tentativi di penetrazione arabi, soprattutto sauditi, nella regione, spesso a suon di finanziamenti, questa popolazione resta indistruttibilmente europea. Il famoso scrittore croato Predrag Matvejesevic afferma che “il fondamentalismo in Bosnia resta verbale e limitato, perciò debole. Io ho visto più ragazze con il viso coperto dal velo in alcuni quartieri di Torino e di Marsiglia che non nello storico quartiere sarajevese di Baščaršija”.
“Viaggiando nelle città bosniache si ha la piena percezione di essere in Europa, non certo in Arabia; la gente, i giovani in particolare, sono perfettamente uguali a quelli europei, con gli stessi desideri e ambizioni. La coscienza di appartenere al mondo europeo, favorito dal graduale ritorno del turismo occidentale, trova conferma anche nelle parole delle persone con cui capita di parlare. Sicuramente il rischio di una deriva islamista della società bosniaca è una possibilità, ma non così concreta, e sicuramente non già realizzata. La sensazione è che fra la popolazione il desiderio di entrare in Europa sia superiore all’interesse per la materia religiosa”. 3)
Quanto all’altra isoletta di islam autoctono, l’Albania, la situazione è ancora più netta. I musulmani, che compongono il 70% della popolazione, condividono con l’altro 30% cristiano un fortissimo senso di appartenenza alla nazione. Solo dopo arriva il sentimento religioso, fievole al punto da non onorare quasi il ramadan, lasciare le moschee vuote e considerare eroe nazionale quel Giorgio Castriota Scanderbeg che nel ‘400 difese strenuamente l’Albania e l’Europa cristiana dall’invasione turca.
Il cristianesimo c’entra poco
Una cosa è abbastanza evidente: quella tra occidente e islam non è una guerra di religione, ma proprio quel conflitto che tanti non vogliono neppure sentir nominare: una guerra di civiltà. O tra civiltà e inciviltà, a seconda dei gusti. Una battaglia tra mondi, tra pianeti, tra tipi di umanità, sbizzarriamoci pure con le antitesi. Non abbiamo ancora chiarito – né forse ci riusciremo – quanto la religione sia una manifestazione etnica per l’islam, ma di certo lo è per l’occidente, in primis per l’Europa. È un tratto culturale comune a un gruppo di etnie affini come lo è la musica barocca, l’espressionismo, la lavorazione del vino o della birra, l’ateismo, la lussuria, l’amore per gli animali, la pedagogia, il fascino dei boschi, il Natale anche se non si crede, le lingue minoritarie, il teatro. E, disgraziatamente, anche quella massa di mentecatti internautici che ogni qual volta c’è di mezzo l’islam commentano che le religioni sono la rovina del mondo. Come se, dopo un rastrellamento delle SS, i familiari delle vittime se la fossero presa con la politica, o una donna violentata auspicasse l’abolizione del sesso perché troppo pericoloso.
Noi non combattiamo (o combatteremo, inevitabilmente) l’islam perché siamo laici ma perché siamo europei; e l’islam non combatte noi perché siamo cristiani ma perché siamo europei.
NOTE
1) “La tanto osannata ‘integrazione’ è impossibile da realizzare. Impossibile per un motivo molto semplice che i politici però si rifiutano di capire: le religioni sono creazione dei singoli popoli, così come la lingua, il diritto, l’arte, la musica, la scienza; ne rispecchiano la forma mentis, la visione del mondo, il carattere, la personalità di base”. Ida Magli, Il conto degli sbarchi lo pagheranno le donne, “Italiani Liberi”, 11-08-2014.
2) Valerio Perino, L’islam in Bosnia, Torino, 2006.
3) ibidem