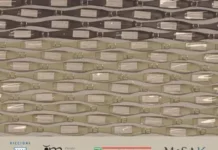La Sicilia fu veramente l’elemento propulsore della letteratura italiana? Potevano, i poeti di Federico II, comporre una lingua tanto lontana dalla tradizione etnica dell’isola? Un’analisi controcorrente del concetto di “Italia” e della sua collocazione in campo sociale, artistico e culturale.
L’anno scorso, la Sicilia fu teatro di un interessante scontro sulle tematiche garibaldiane il cui esito, per gli autonomisti e i democratici, non può che essere fonte di sollievo: l’Assemblea regionale respinse la proposta di erigere un monumento al condottiero e ai suoi Mille. Non si trattò, forse, di intelligenza politica o di buon senso bensi, semplicemente, dello scandalo prodotto nelle coscienze isolane dall’assurdità di una iniziativa costosissima (1 miliardo di lire!) e beffardamente offensiva per un popolo sconfitto. Per l’occasione, Giuseppe Scaccianoce scrisse su “Sicilia Oggi” che “avrebbe dovuto essere, caso mai, il governo centrale a festeggiare simile avvenimento con noi, date le perplessità che la storia comincia a sollevare sulla utilità politica per i siciliani di questa invasione savoiarda”.
A distanza di un anno e in piena celebrazione del Centenario, piace ricordare che l’Assemblea, prima di prendere la sua saggia decisione, fu denunciata per avere stanziato la favolosa cifra – con l’accusa di peculato, distrazione e malversazione di fondi pubblici – dall’ingegnere catanese Giuseppe Mignemi; il coraggioso cittadino, oltre a rilevare la follia di un impegno finanziario privo di pubblica utilità in una terra che ha ancora bisogno di tutto, nella sua corrispondenza al giornale “La Sicilia” accusò la Regione di avere programmato la costruzione di un “monumento a Mille avventurieri, che vennero in Sicilia per sostituire la tirannide borbonica con l’altra non meno efficiente dei Savoia, mentre non si è sentita in dovere di erigere un monumento al prof. Antonio Canepa, Carmelo Rosano e agli altri Caduti dell’esercito volontario per l’indipendenza siciliana”.(1)
Neanche a dirlo, la sconfitta assembleare fu impugnata dai socialisti – e soprattutto da Bettino Craxi – i quali promossero un’affannosa sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari.
A tale proposito, un esponente della combattiva organizzazione etnica “Sicilia Nostra” ebbe a coniare una frase forte ed emblematica, ma anche sapida di atavico fatalismo isolano: “È un triste destino che la Sicilia debba avere sempre tra le palle un Garibaldi bramoso di liberarla e di governarla!”
Gli Eroi
Siamo dunque a un profondo ripensamento riguardo a questa figura di uomo (il Garibaldi) che pare di estrema utilità per la retorica dei vari regimi italiani: accanto all’immagine un po’ patetica che molti cittadini hanno imparato a beffeggiare, si fa strada la consapevolezza della reale statura storica, assai più sinistra, di un folle avventuriero che serviva gli interessi dell’espansionismo savoiardo; lucido, peraltro, nel pianificare le feroci repressioni con le quali intendeva piegare il popolo siciliano all’aspirazione italianista. Aspirazione che deve essere ancora oggi prioritaria rispetto a ogni ideologia politica se partiti come PCI e PSI – legati alla simbologia garibaldina – fingono per esempio di ignorare che il luogotenente Bixio, a Bronte, “reprimeva con arresti e fucilazioni in massa una delle tante agitazioni contadine che si erano accese in tutta la Sicilia”.(2) L’analogia di questi episodi con le azioni naziste di ritorsione è suggerita dal fatto che Bixio, in tale occasione, “intervenne quando la calma era già tornata e con l’intento di dare un esempio e un monito per il futuro”.(3)
L’Eroe e la sua banda si distinsero per altre esecuzioni in massa, ordinate da tribunali improvvisati e dirette contro una popolazione inerme che, quando si organizzò nella guerriglia anti-straniera, fu (ed è) tacciata di brigantaggio. È ovvio che in caso di miglior sorte i “briganti” sarebbero oggi onorati come “partigiani” e “patrioti”, al pari dei loro coraggiosi compagni di quarant’anni fa.
In un momento come l’attuale, dunque, in cui le Brigate Rosse per molti rappresentano la più temibile minaccia per l’umanità, fa un certo effetto l’esaltata apologia di questo padre del terrorismo, nonché la passione nutrita da certe sinistre per un “imperialista-reazionario” di tanta portata: non bisogna infatti dimenticare che il principale alleato dell’invasore era proprio la borghesia capitalista – in Sicilia come nel Friuli e altrove – e nell’isola, come rileva Mack Smith, Garibaldi “riuscì […] ad associare molti membri dell’aristocrazia conservatrice, i ‘galantuomini’ e le élites sociali, alla causa dell’unità d’Italia” (4); né è un mistero che il Prode sia stato nominato, nel 1864, primo massone d’Italia e successivamente gran maestro di quella massoneria che diventerà “la struttura portante della burocrazia statale e della borghesia italiana” (5) Un complesso di fattori indica cosi che la partitocrazia romana ha a cuore soprattutto, se non unicamente, l’unità del falso stato italiano – nato dal fallimento della resistenza di vari popoli – e il potere che ne consegue, anche a costo di travisare alcuni avvenimenti storici.
I Poeti
L’isola ha dunque opposto una recisa negazione alle celebrazioni di una sconfitta pagata a caro prezzo (i suoi abitanti “da quell’infausto avvenimento in poi non hanno subito che angherie e soprusi”, scriveva un lettore a “La Sicilia”). La presa di coscienza autonomista si va allargando a strati sempre più vasti di popolazione, legata a una mentalità più moderna e più “etnica”, già lontana dall’ancipite indipendentismo siciliano classico.
Come spesso succede, il cammino verso l’autodeterminazione si snoda attraverso l’accidentato terreno della rivalutazione linguistica; a tale proposito, la Sicilia lamenta non pochi handycap che ne minacciano gravemente la, diciamo cosi, credibilità agli occhi dell’Italia e dell’Europa, nonostante il particolare status giuridico della Regione: a quanto si dice essa sarebbe la culla (o meglio, la pre-culla) della dinastia letteraria italiana e della dolce favella statale; a ciò va aggiunto che il siciliano è uno di quei popoli che le fumoserie linguistiche dell’etnismo accreditato a Roma assegnano al limbo delle regionalità, senza remissione. Non entriamo per ora nel merito della questione se la Sicilia sia una nazione o vada comunque inserita in un blocco etnico meridionale (decisione che, se permettete, lasceremo agli interessati). Ma di una cosa possiamo essere certi: il siculo non è un dialetto italiano. Chi sostiene il contrario, evidentemente, ha subito con prona accettazione la campagna di menzogne storico-letterarie che ci viene somministrata sin dalla più tenera età scolare, e di cui i libri di testo sono ingenui o consapevoli strumenti di complicità.
Spieghiamoci. L’assioma della nostra educazione scolastica è che tutta la storia, dal solco di Romolo in poi, è storia d’Italia, scambiando la causa con l’effetto e affidandosi a una teleologia degli avvenimenti passati che è tuttora ricavata dall’inventiva fascista; per la suddetta teleologia i Siciliani, essendo oggi “italiani”, dovevano esserlo per forza già da prima e tendere all’Unità sin dai tempi degli Elimi. E la loro lingua, naturalmente, era italiana: ci si evolse – vien detto – dal latino al volgare, un volgare provvidenzialmente plasmato sull’ideale linea di confine che il futuro bellico del XX secolo avrebbe tracciato…
Un popolo di indovini, l’italiano, a sentire le singolari argomentazioni degli studiosi, in particolare del De Sanctis (6) quando sostiene che “ci erano dunque due lingue nostre nazionali [sic], il latino e il volgare. Con lo svegliarsi della cultura, se parecchi dialetti rimasero rozzi e barbari, come le genti, che li parlavano, altri si pulirono con tendenza visibile a svilupparsi dagli elementi locali e plebei, e prendere un colore e una fisionomia civile, accostandosi a quel tipo o ideale comune fra tante variazioni municipali, che non si era perduto mai, che era come criterio a distinguere fra loro i dialetti più o meno conformi a quello stampo, e che si diceva il volgare, cosi prossimo al romano rustico”. A queste facezie il valente letterato aveva aggiunto (e poi cancellato) nel manoscritto: “Il dialetto che si alzò sopra tutti fu il siciliano”.
Ora, la sua conoscenza di quel “dialetto” doveva essere verosimilmente limitata ai componimenti della Scuola di Federico II, di cui – come non tutti gli studiosi sanno, ma come tutti dimenticano – noi degustiamo la traduzione toscana, e tramite i quali innumeri storici letterari commentano i primi vagiti della lirica italiana. Noi dunque “siamo costretti a leggere i testi siciliani in una veste linguistica che non è la loro, in redazione toscana” (7); non solo, ma – come sostiene Giovanni A. Cesareo – a quella corte anche “Napoletani, Pugliesi, Toscani, Genovesi avrebbero composto le loro rime, non già nel proprio volgare, ma (sia pure con qualche venatura del proprio volgare) in siciliano…” (8).
Come si vede, tutte le divagazioni linguistiche sull’italianità della Scuola, e quindi della parlata stessa di Sicilia, non hanno altro significato se non quello di piegare l’antica realtà letteraria alla moderna ragion di stato. E, d’altronde, che la lingua impiegata nei componimenti che ci sono tramandati non sia siciliana è dimostrabile più in termini di elementare buon senso che mediante lunghe analisi filologiche; gioverà riportare un frammento di Ciullo d’Alcamo:
Molte sono le femine
Che hanno dura la testa,
E l’uomo con parabole
Le dimina e ammonesta:
Tanto intorno percacciale
Sinché l’ha in sua podestà.
Femina d’uomo non si può tenere.
Guàrdati, bella, pur di ripentere.
e confrontarlo con una poesia di Antonio Saitta, «A suggiuta ’u suli»:
Brisciu!
e ’a campana d’a chesa
sunau ’u signu d’ a cruci
’U sceccu ràgghia ntà stadda
e u boi fa buci
vidennu ch’è vacanti ’a manciatura.
Di cuntrata a cuntrata chiamaru i jaddi
e i jaddineddi su’ fora û giuccaturi.
Supa d’a tenira ibbuzza
’u chiantu d’a notti
lucichia.
Cùrrunu ppi l’aria
friscati ’i picurari
a scrusci ’i zzappuni.
I rinnineddi fannu firriola
ppi scupari ’a strata
ô suli chi scinni dû puntali. (9)
Abbiamo, qui, una lingua moderna che pure è praticamente incomprensibile al non siciliano, mentre l’antica cantilena di Ciullo è intelligibile a tutti noi che, ufficialmente, parliamo un derivato linguistico di matrice toscana.
Il De Sanctis, dunque, condiziona come tanti il livello culturale di un popolo all’adeguamento linguistico e stilistico nei confronti del modello toscano, che egli tuttavia insiste a definire italiano; la lettura degli originali siciliani lo avrebbe verosimilmente innorridito, se è vero che, parallelamente ai dialetti “rozzi e barbari”, altri si mondarono “dagli elementi locali e plebei” e presero “una fisionomia civile”. Il siciliano, per il fatto di essere distante – come abbiamo ben visto – dalla gentile favella fiorentina dovrebbe essere indubbiamente registrabile tra i barbarumi che infestano in parte anche l’Italia moderna dove, secondo Robert Rüegg, nella prima metà degli anni ’50 solo il 18% della popolazione impiegava l’italiano.
L’attenzione viene indubbiamente carpita anche dalla terminologia dell’autore (“rozzi”, “plebei”, “civile”) che comporta una visione aristocratica della cultura e dell’arte, e un dispregio più cortigiano che etnico o patriottico nei confronti della gente comune; atteggiamento che è comunque isomorfo alla sostanza stessa della cultura classica “italiana”, la quale altro non era che una moda internazionale di stretta competenza curtense, distolta da un vero rapporto con i popoli extra-toscani e, pertanto, priva di ogni qualifica nazionale, al pari del primitivo provenzalismo.
Che si tratti di prestigio culturale o – come sostiene Calvet – di prestigio economico, è un fatto che l’impiego di lingue straniere a un certo livello sociale era cosa comune a molte plaghe d’Europa, senza per questo scomodare le peculiarità etniche delle varie genti. Cosi, nel ’400 il Portogallo produsse un poema, il Cancionero de Resende, in castigliano; e, al pari, il valenzano Vinoles si vantava di usare la “limpia, elegante y graciosa” parlata castigliana, a danno delle altre lingue iberiche definite, alla De Sanctis, “bàrbaras y salvajes”. (10)
Gli Italiani
Le procedure usate dalla cultura ufficiale per rivendicare l’italianità spaziano dalle raffinate manipolazioni letterarie alle meno misurate manifestazioni di patriottismo, ma tutte hanno quale comune fondamento assiomatico la retroattività dello status geografico-giuridico attuale, sotto forma di coincidenza tra i concetti di stato e nazione. Ovvero: se oggi lo stato corrisponde ufficialmente alla nazione, è indispensabile proiettare nel passato l’esistenza stessa della realtà nazionale, (11) interpretando tutti gli avvenimenti storici in funzione consapevole del conseguimento di uno stato futuro che ci sembra, nella sua circoscrizione geografica, più frutto di guerre e di trattati internazionali che di coscienza nazionale.
Non bisogna, d’altra parte, pretendere che il concetto di Italia non sia mai esistito prima delle manovre risorgimentali; molti etnisti – anche se per motivi comprensibili – sono portati a considerarla una moderna invenzione, mentre basterebbe porre l’accento sulle diverse interpretazioni che il termine ha registrato attraverso i secoli. I Romani, ad esempio: in questo caso ci sembra verosimile collocare la loro “Italia” in analogia geografica con “Iberia”, immaginando che “Iberia” e “Spagna” potrebbero ora essere sinonimi se quest’ultima avesse in qualche modo conquistato il Portogallo. Una penisola geografica, dunque, abitata da una nutrita schiera di popoli che, a differenza dell’Iberia, sono stati riuniti in un unico sistema politico amministrativo.
Tra parentesi, un altro dato che si è soliti ignorare riguarda l’uso improprio del vocabolo “penisola”, il quale interessa all’incirca una metà del territorio statale, essendo il Settentrione parte integrante del corpo continentale europeo. E se Roma comprendeva nella circoscrizione delle XI regioni augustee (con almeno 10 milioni di abitanti) pure la Padania celtica e venetica – escludendo ogni connotazione etnica unitaria – lo faceva superando anche una logica classificazione geografica, probabilmente in ossequio a una pianificazione bellica che riconosceva nell’arco alpino l’ultimo e più formidabile baluardo difensivo prima della capitale.
Gli stessi appetiti del regno italiano nei confronti del versante tirolese furono chiaramente risvegliati da tale impellenza strategica. Molto più tardi, prese forma una particolare interpretazione culturale dell’Italia, avvolta nelle foschie dei rapporti politico artistici dei vari centri di potere, ma sempre con un punto di riferimento – la Toscana medievale e rinascimentale – che gravitava nel cuore spirituale dell’Europa. Il meridione della penisola, un po’ moresco e legato al continente più che altro dall’impegno orografico, era per cosi dire più lontano dalla Divina Commedia di quanto non lo fosse qualsiasi plaga dell’Emilia o del Veneto di pianura, anche se i fissati della linguistica affidano al contrafforte La Spezia-Senigallia un ruolo praticamente invalicabile.
Alla faccia della linguistica, dicevamo, l’Italia era un’idea grosso modo multietnica, una deliziosa damigella che amava intrattenersi in vaghe occupazioni con le compagne di Fiandra e di Francia, ammaestrando di sé l’ammirato uditorio europeo; un cenacolo nordico, insomma, che nascondeva dietro l’apparente uniformità una ricca varietà delle sue componenti popolari.
Quell’Italia, semplicemente, non era questa Italia.
Lo testimonia chiaramente Machiavelli il quale, avendo a descrivere una mostruosità che non ricordo, spiega: “Sarebbe come dire che un siciliano è un italiano!”
La vocazione settentrionale dell’italianità (parliamo ovviamente in linea di massima) rimase inalterata sino all’Unità e, tramutatasi da blando imperialismo culturale in forsennati aneliti monoetnici, si dispose alla colonizzazione del Sud, ma sempre – si badi – con la pretesa di “portare” quel certo tipo di Weltanschaaung ai popoli mediterranei. O anche alla parte di Settentrione che, come il Friuli, si era mantenuta più distante dalla fiorentinità (caratteristica ancora più marcata in un Piemonte che, però, si eresse curiosamente a brando dell’italianità).
L’inversione di tendenza, paragonabile a una vera e propria “migrazione dei poli”, è storia recente. La colonizzazione del colonizzatore operata da Roma è in piena attività e ha già completamente spostato il baricentro dell’italianità. Ne è una riprova l’immagine sconcertante- sconcertata che ne ha il mondo, travolto da una serie di dati ancipiti che ora si riferiscono all’esperienza storica del Nord, ora a quella attuale del Sud, e che sembrano impossibili da far collimare. Ma lasciamo perdere il triste capitolo, e non dimentichiamo che è compito dell’etnismo combattere la deculturazione reciproca, la distruzione biunivoca che è in atto tra le due componenti, indipendentemente da chi ha più o meno crediti in questa corsa all’appiattimento.
Un’ipotesi
Immersi come siamo in un presente tanto caotico, è evidente che ogni qualifica storica o culturale dell’“Italia” è andata ormai a farsi benedire. Il termine è oggi completamente rivisitato e non può esprimere in alcun modo la realtà delle etnie padano alpine, e forse neppure di quella toscana. Per la suddetta ragione è tendenza di molti etnisti definire “italiani” i mediterranei (non i Sardi, però), anche e soprattutto perché essi sembrano assai fieri di appartenere alla comunità tricolore. Non vorremmo, però, che tale apparente rispetto dell’altrui identità – ancorché di recente acquisizione – celasse un certo dispregio, un’ulteriore imposizione “regionalitaria” che almeno i siciliani respingono in misura crescente.
Che fare? Dissezionare i popoli e attribuire qua e là qualificazioni etnicistiche è cosa che, personalmente, mi irrita. Anche perché si tratta sovente di vere e proprie autopsie su cadaveri linguistici, su dati filologici che hanno valore solo se esprimono l’anima complessiva di una comunità, non la sua collocazione in un accademico casellario glottologico. Ma non c’è dubbio che le risoluzioni politiche che consentiranno di ricomporre un’Europa dei popoli dovranno necessariamente decollare da una precisa distribuzione di certe qualifiche etniche, nonché economiche e geografiche. Riteniamo che l’esempio elvetico sia estremamente valido, ma non possa essere applicato a realtà eccessivamente complesse e diversificate, né d’altra parte si ha la pretesa di tramutare ogni regione in uno stato sovrano senza ridestare ulteriori interdipendenze.
Il primo passo, di certo, consiste nel combattere affinché i due grandi gruppi – i blocchi etnici più palesemente differenziati: i Padano-alpini e i Mediterranei – riacquistino la totale indipendenza l’uno dall’altro; le ulteriori distinzioni, fino alle sottigliezze storico-linguistiche, potranno venire in seguito magari con un ordinamento federale da far impallidire la stessa Svizzera.
Si facciano le repubbliche alla iugoslava, i cantoni, i campanili, i rioni se si vuole, ma ciò avvenga quantomeno in un contesto omogeneo, centroeuropeo da una parte e mediterraneo dall’altra.
Visto cosi il panorama strategico, si potrà pensare a una Sicilia fortemente autonoma all’interno di un Meridione federalizzato, libera di esprimere pienamente la propria ricchezza linguistica e spirituale, ma non alla deriva in un Mediterraneo dove i piccoli navigli solitari sono sempre più alla mercé della pirateria internazionale. Ma, lo ripetiamo, è decisione che spetta agli interessati.
NOTE
(1) “La Sicilia”, 10-5-1981.
(2) Giuliano Procacci, Storia degli Italiani, Laterza 1971.
(3) Paolo Alatri, Lotte politiche in Sicilia sotto il governo della destra. Einaudi 1954.
(4) Denis Mack Smith, Storia della Sicilia medievale e moderna. Laterza 1970.
(5) Valerio Ochetto, Luci ed ombre nei “fratelli” italiani, da Il Messaggero. 7-10-1981,
(6) Francesco De Sanctìs, Storia della letteratura italiana, vol. 1. Einaudi 1958.
(7) E. Pasquini, A.E. Quaglio, Le origini e la scuola siciliana. Laterza 1971.
(8) Giovanni A. Cesareo, Le origini della poesia lirica, Sandron 1924. Si veda anche Ireno Sanesi, Il toscaneggiamento della poesia siciliana, in “Giornale storico della Letteratura Italiana”, vol. 34.
(9) Antonio Saitta, ‘U cottu. 20 poesie in dialetto messinese, Scheiwiller 1975.
(10) Philippe Wolff, Les langues occidentales.
(11) La propaganda in tal senso è tanto forte da coinvolgere anche gli etnisti stranieri – solitamente ignorantissimi di cose “italiane” – come hanno purtroppo dimostrato anche l’ottimo Calvet e il meno ottimo Héraud. Krejci (Ethnic and political nations in Europe), poi, che fa una grande confusione persino tra le minoranze “ufficiali”, arriva a sostenere che “l’unità etnica dell’Italia è rimasta intatta dal tempo dei romani”!
Desidero ringraziare Giovanbattista Nicastro jr., segretario di Sicilia Nostra, per avermi fornito parte del materiale bibliografico e giornalistico utilizzato nel presente articolo. Le valutazioni storiche e le proposte politiche espresse nell’articolo stesso sono assolutamente personali e non rispecchiano necessariamente le posizioni di Sicilia Nostra.