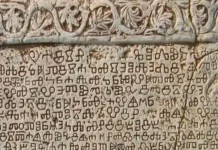A volte ritornano… È quasi divertente per un etnista, dopo tre o quattro decenni dedicati allo studio e soprattutto alla difesa delle parlate minoritarie, ritrovare intatte le stesse identiche diatribe su lingue e dialetti. Cambiano le persone, ovviamente, ma certe figure – come quella sempre affascinante e misteriosa del “dialettologo” – sono eternamente presenti a ricordarci che nulla può essere veramente parlato al di fuori dell’italiano.
Le recenti iniziative della Regione Veneto a trazione leghista non potevano non scatenare gli accademici (“che tutto il mondo ci invidia”, si usa aggiungere quando c’è di mezzo il tricolore), sempre pronti a rintuzzare qualsiasi pulsione localista. “La nuova Venezia”, in un articolo-intervista del novembre scorso intitolato Ma quale lengoa veneta? C’è un mosaico di dialetti, dà voce a una dialettologa dell’Università di Padova, Gianna Marcato, scandalizzata dalla legge regionale sul bilinguismo. Dopo aver sostenuto che un’iniziativa simile mette “una pietra tombale sui dialetti”, la docente sembra rinunciare alla preistorica dicotomia lingua/dialetto (“da un punto di vista linguistico, le lingue sono tutte pari”), grazie a Dio, ma per aggiungere subito dopo che “una lingua è qualcosa che ha una propria unitarietà codificabile, i dialetti invece sono mille”. Insomma, scientificamente le parlate sono tutte “lingue”, ma se osservate dal punto di vista socio-politico diventano dialetti quando non sono codificati; ovvero se – come ha detto qualcuno – non hanno “una flotta” alle spalle; ovvero se non c’è un centro di governo che li ufficializzi. La logica a questo punto rende inevitabile la domanda: e se un centro di governo come può essere una Regione tenta di porvi rimedio, perché diavolo ti opponi?
Un maligno sarebbe portato a rispondere che a politici e accademici italici e italianizzati non importa un cavolo di come parli la gente: hanno solo paura che all’ufficializzazione di una lingua locale corrisponda una caratterizzazione etnica, con ulteriore detrimento del monolitismo razziale di mussoliniana memoria. Ma la Marcato assicura di essere preoccupata per la sopravvivenza stessa del veneto:
“Esiste un mosaico di dialetti veneti. Come diceva il nostro grande poeta Andrea Zanzotto, ogni parlante quando parla il suo dialetto è rannicchiato su un tessera di un mosaico che sa essere più ampio, però il suo è solo quella tessera”.
Che cosa vuol dire “codificare” un dialetto? “L’italiano è diventato tale nel Cinquecento perché alcuni grammatici, supportati da chi gestiva la cultura, hanno decretato che alcuni usi andavano bene e altri no. Codificare una lingua, significa fissare con una norma esterna chi parla bene e chi parla male. Come possiamo fare questo con i nostri mille dialetti che sono lingue orali? Se voglio codificare un dialetto, devo per forza imporre una varietà sacrificando le altre, ma – mi chiedo – che senso ha oggi? La ricchezza dei dialetti è proprio quella di essere stati trasmessi assieme all’identità comunitaria, di famiglia in famiglia, all’interno di un paese, proprio nella loro diversità”.

Interessante e ironico il commento a queste parole inviato a “La Nuova Venezia” da Alessandro Mocellin, direttore dell’Academia de ła Łengua Veneta:
“Codificare una lingua, significa fissare con una norma esterna chi parla bene e chi parla male”… Ebbene, la professoressa Marcato parla male. È sufficiente ascoltare un qualunque suo intervento pubblico per accorgersi che non sa parlare italiano corretto: non usa regolarmente il passato remoto, non usa il raddoppiamento fonosintattico, scempia le consonanti, non utilizza le vocali toniche secondo la dizione standard della lingua italiana; in due parole, la professoressa Gianna Marcato parla quello che scientificamente è definibile il “dialetto veneto”. Una vera e propria corruzione dell’italiano standard, un non-italiano e non-veneto contemporaneamente.
A cosa serve definire uno standard imperativo, come pretende la Marcato, se poi nessuno lo usa?
Tra l’altro, oltre all’atteggiamento bislacco di lamentare la mancanza di una koiné e contemporaneamente di stigmatizzare ogni tentativo di crearla, viene da chiedersi come si collochino questi dialettologi di fronte alle realtà linguistiche minoritarie che sinistri calcoli politici (da noi ampiamente trattati) hanno messo sotto (pseudo) tutela da quasi vent’anni. Tra le parlate descritte all’articolo 2 della legge 482 del 1999 – come friulano, ladino, occitano e sardo – quali sarebbero codificate più del veneto, secondo la Marcato? E dovremmo supporre che il piemontese sia il miglior candidato allo status di lingua riconosciuta, avendo una koiné fin dal ‘700 e una vasta letteratura basata su tale codifica?
Ma, ripetiamo, qui siamo di fronte all’altruistico timore che il veneto possa soffrire di regolamentazioni e codifiche: meglio strangolarlo politicamente mentre è ancora colorato e multiforme. Osserva Mocellin:
In realtà, la professoressa Marcato è molto chiara ad esprimere le sue personali motivazioni di contrarietà: “Se voglio codificare un dialetto, devo per forza imporre una varietà sacrificando le altre”, e poi aggiunge, “perché è impossibile insegnare un dialetto”. In sostanza, la sua è più che altro un’ammissione di incapacità a risolvere la questione dal punto di vista scientifico e glottodidattico, scaricando la responsabilità alla politica.
Spero sinceramente che ella sappia che in area scandinava, per esempio in Norvegia, si è proceduto a una codifica multistandard della lingua e a scuola la si insegna, cioè si insegna la variante locale e si spiegano gli elementi di diversità delle altre varietà. È così difficile da capire? La professoressa Marcato ovviamente non sa, perché probabilmente non le interessa, che quest’anno l’Università di Francoforte ha patrocinato lo studio e la pubblicazione scientifica del primo manuale universitario interamente scritto in lingua veneta, quella “lengua veneta” che la Marcato definisce addirittura “orribile” mostrando la psicologia di un inquietante “odio di sé”, così grave e penetrante da inficiare l’imparzialità del suo giudizio scientifico.

In effetti (e lo diciamo per i lettori più giovani) tirare fuori questa faccenda delle varietà interne alle lingue in pieno XXI secolo è ridicolo e squalificante per qualsiasi studioso. Sarebbe come discutere di zoologia mettendo ancora in forse la validità dell’evoluzione. Queste diatribe sono già state ampiamente superate negli anni ’70, e oggigiorno nessuno può seriamente recriminare sul numero di varietà interne a una parlata sapendo quante ne contano lingue ormai al centro delle cronache come il basco o il provenzale. Un fenomeno non ignoto anche a lingue statuali, come fa notare – sempre contestando la Marcato – il linguista veneto Michele Brunelli, membro della Commissione regionale per la grafia:
Io noto che anche altre lingue hanno varietà interne. Qui l’argomento si fa necessariamente tecnico, ma cercherò di spiegarmi con tre esempi.
1) In veneto è un problema l’esistenza della doppia forma fornaro/fornèr o della coppia parlemo/parlòn? Bene, la lingua spagnola ha doppie forme per il congiuntivo di tutti i verbi: durmiera/durmiese (dormissi io), durmieran/durmiesen (dormissero) e cosi via per tutte le persone. La lingua ufficiale le accetta: ci sono varianti che possono convivere.
2) In veneto c’è chi dice tuto e c’è chi dice tut. Anche nel piccolo Portogallo esistono variazioni simili: tudu/tud. I portoghesi hanno brillantemente risolto il problema: scrivono tudo, poi la o finale puoi pronunciarla (tudu) oppure non pronunciarla (tud).
3) In veneto il numero 100 ha tre pronunce: sento, thento, tsento. Bene, in spagnolo il 100 suona sjen e anche thjen. Gli spagnoli hanno conciliato le due pronunce in un solo segno: scrivono cien, poi la c puoi pronunciarla th oppure s.
In conclusione, la situazione del veneto è analoga a quella di altre lingue ufficiali. Ci sono variazioni che possono coesistere e variazioni che possono essere conciliate nella grafia senza che una forma “schiacci” le altre. La presenza di varietà non è di per sé un ostacolo alla scrittura, né all’insegnamento.