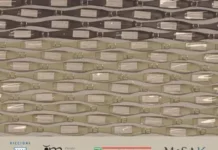Cosa sono le piramidi e gli obelischi in pietra costruiti nei secoli sulle montagne biellesi? Per gli alpigiani sono semplicemente òm ëd pera, la cui origine sarebbe meramente utilitaristica per togliere dai rari pascoli troppi sassi ingombranti. Tuttavia il mistero di queste costruzioni resta ancor oggi molto fitto.
Si tratta infatti di numerosi impilamenti litici di forma piramidale con sopra un masso più grande a mo’ di copertura, eretti fin dalla notte dei tempi nella valle dell’Elf (Elvo) a poca distanza o addirittura sopra il Dèir Saltzèr, il grande complesso roccioso di forma umana frequentato dagli antichi salassi per i loro rituali.

Questi grandi colonnati di sassi innalzati in forma prismatica o cilindrica con un’abilità impensabile e che hanno sfidato tutte le intemperie, sono stati definiti “Mongioje” dagli archeologi Filippo Maria Gambari e Alberto Vaudagna, i primi a valorizzarli e a dichiarare che il loro nome “evoca significati positivi legati al ‘sacro’”.
Il termine, presente soprattutto in area gallica, trarrebbe origine da un’alterazione del medioevale mongerius usato per indicare un “accumulo a forma di monte”, ma soprattutto un luogo con attinenza al sacro.
A questo proposito viene ricordato che anche la collina di Montmartre di Parigi era detta “Montjoie S. Denis”. Montmartre deriva da Mons Martis, il rilievo delle “Martes”, le quali vivevano accanto a dolmen pietrosi (come il ròch d’Urupa) e originarono il culto celtico delle Matronae, vivo anche nella nostra Gallia Cisalpina.
Poiché in lingua piemontese con il termine giòje si indicano i monili, non é troppo fantasioso pensare che i cumuli siano stati chiamati così perché considerati veri e propri “gioielli della montagna”, opere di anonimi e oscuri artisti della civiltà perduta delle Alpi. Peraltro, il territorio dove sono eretti è compreso principalmente tra i torrenti Viona e Janka, dove la tradizione popolare collocava il santuario litico degli antichi salassi.

Anche Corrado Martiner Testa, nella sua accurata e preziosa guida alle Passeggiate sulle montagne del Biellese, li chiama “ometti di pietra” e segnala quello molto singolare lungo la costa della Muanda, “pitturato di bianco, con una piccola nicchia ed una statuetta della Madonna Nera”, togliendogli l’anima pagana ma riconfermandone il carattere sacro, analogamente a quello sul Poggio Frassati sovrastato da una croce.
La zona dove si concentrano è compresa tra una località che prende il nome di Morter, sovrastante il Viona, e il Pian dla mòrt, sovrastante il Dèir Salrzèr: questa circostanza potrebbe far pensare che si tratti di stele funerarie. Altri manufatti simili si concentrano verso l’Alpe Muanda attorno a una località chiamata Pian dla cesa, pianoro della chiesa. Nessuno sa perché si chiami così.
Proprio la straordinaria abilità creativa dei costruttori prova che non si tratta di occasionali e casuali cippi pietrosi, ma di veri e propri monumenti d’una perduta tradizione. Sentinelle dei percorsi di antiche migrazioni, sarebbero in qualche modo gli antenati dei “piloni” votivi cristiani, quelli con le immagini dei Santi e della Madonna collocati lungo le strade e ormai deteriorati dall’abbandono e dal disinteresse del mondo moderno, sempre più lontano dalla spiritualità e della fede.
Il nome con cui le strutture litiche vengono indicate da Gambari e Vaudagna trova riscontro nella toponomastica alpina, per esempio nella Val Montjoie in Alta Savoia alle falde del Monte Bianco, dove – vicino all’antico santuario di Nôtre Dame de la Gorge – é situata la nota stazione sciistica di Les Contamines-Montjoie, da cui si sale verso il Col du Bonhomme. Dal medioevo, il termine bonhomme é il soprannome tipico dei contadini, il bonòm, bonaccione; e da buon uomo a òm ëd pera il passo é breve, richiamando il carattere di sentinella della montagna o di essere pietrificato.
Nelle Alpi di Sarentino (Sarntal) gli omini in pietra sono chiamati Stoanernen Mandln, e se ne contano parecchi allineati sulla cima Hohe Reisch a duemila metri d’altitudine, dove secondo un antico ma robusto pregiudizio si sarebbero recate delle malefiche streghe.
La credenza pare basata su un procedimento giudiziario del 1540 contro una donna del luogo, Barbara Pächlerin, accusata d’essere una fattucchiera malefica e condannata al rogo poiché, con altre donne perdute, si sarebbe recata in quel luogo magico per ballare e avere rapporti contro natura col demonio.

Come le sfortunate streghe biellesi, era stata vittima della maldicenza delle donne del paese di suo marito, Windlahn (toponimo brutalmente e stoltamente italianizzato in Lana al Vento). dove si era trasferita, le quali avevano accusato la “forestiera” di ogni misfatto costringendola a una vita errabonda sulle montagne, guadagnandosi il soprannome di Pachler Zottl – la stracciona del maso Pachler – nonché la denuncia come essere infernale.
In realtà gli Stoanernen Mandl hanno un’origine ben più antica, come attestano le numerose incisioni rupestri e gli attrezzi di pietra focaia ritrovati nella zona.
L’òm ëd pera biellese meglio conservato é quello posto accanto al sentiero che sale verso il Pian Bres poco sopra il rifugio dell’alpe Cavanna, mentre quello più elevato sovrasta l’Alpe Muanda e la strada sterrata verso l’alpeggio delle Sette Fontane.
Un monumento litico a forma di piramide alto quasi un metro e mezzo si trova sotto le cascine Settefontane, altri due troneggiano alla Costa della Muanda sopra l’Alpe Chiavari, e se ne incontra un altro a valle della cascina Alpetto e della cascina dël Truch, proprio al limite del bosco che digrada verso l’Urupa. Come a indicare il cammino verso un luogo eccelso di fede e religiosità: cristiana oggi, ma di origine pagana.