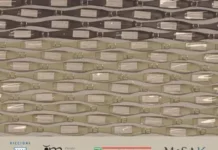Chi erano, chi sono i Celti: una razza? Un’etnia? Una cultura? Forse, al di là dell’indagine storica, essi rappresentano un modo di essere, qualcosa che appartiene alla nostra natura più intima e gelosa, più inspiegabile e ribelle…
Una prima notizia sui Celti ci torna dai banchi di scuola: ricordate il latino di Giulio Cesare, bello e chiaro, il suo avventuroso racconto della conquista romana delle Gallie? Ecco, era proprio l’inizio del De Bello Gallico: “Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra autem Galli appellantur”, ossia “La Gallia è divisa in tre parti, la prima la abitano i Belgi, la seconda gli Aquitani, la terza quelli che nella loro lingua si chiamano Celti e nella nostra, appunto, i Galli”. Proprio come si conviene alle grandi vedettes, eccoli qui comparire, i nostri Celti, da ultimi, preparati da una bella frase rotonda, da veri protagonisti.
Dunque, sembra facile, no? E invece non lo è. Tanto per cominciare, Cesare, tutto occupato a raccontarci le sue gesta guerresche (ricordate il famoso “telegramma”: veni, vidi, vici…), non aveva certo il tempo di fare dell’antropologia o del folclore comparato. E quindi sulla natura dei Celti non ci dice molto. Con sottile umorismo, è il grande Chesterton che così se ne lamenta, nel primo capitolo della sua Piccola storia d’Inghilterra: “Il breve rapporto di Giulio Cesare sui Britanni ci lascia qualcosa di quel mistero, ch’è qualcosa di più della semplice ignoranza dei fatti… Su quasi tutti gli argomenti controversi nei tempi moderni Cesare tace. Nulla ci dice sulla lingua e se fosse ’celtica’… Cesare si proponeva di dare un’occhiata da viaggiatore, ma anche quando, dopo un considerevole periodo di anni, i Romani ritornarono e fecero della Britannia una provincia romana, continuarono a far mostra di una singolare indifferenza nei riguardi di questioni che erano poi destinate a eccitare sì grandemente un numero grandissimo di professori. Ciò di cui si curavano era di dare e ricavare nella Britannia ciò che avevano dato e ricavato nella Gallia. Noi non sappiamo se i Britanni allora, e per conseguenza i Britannici di adesso, fossero iberici, cimbri o teutonici: quel che sappiamo di sicuro è che in breve tempo diventarono romani”.
Ma come mai abbiamo parlato di Gallia, e poi ci siamo ritrovati — sempre con Giulio Cesare — in Britannia, ossia in Inghilterra? Anzitutto, l’Inghilterra non è che la “Gran Bretagna”, che riprende il suo nome dalla Bretagna primitiva, quella “piccola”, una regione della Francia del Nord. E che cos’hanno in comune, le due Bretagne? Qualcosa di più forte del sangue, e cioè il nome, e quindi una cultura. Ascoltiamo cosa dicono le leggende, ancora dalla penna, sempre caustica e sorvegliata, di G. H. Chesterton; si parte dalla morte e dal sepolcro di Cristo, nonché da colui che s’era dato da fare perché il corpo del Signore potesse ricevere sepoltura: Giuseppe d’Arimatea. “San Giuseppe d’Arimatea, uno dei pochi seguaci della nuova religione che sembra sia stato danaroso, fece vela come missionario, e dopo lunghi viaggi arrivò a un gruppo di piccole isole che agli uomini del Mediterraneo apparve come le ultime nubi del tramonto. Egli mise piede sulla sponda occidentale e più selvaggia di quel paese selvaggio e occidentale e si fece strada sino a una vallata che in tutte le più antiche testimonianze viene chiamata Avalon”.
Prosegue la leggenda: “Fosse a causa delle ricche piogge e del tepore delle praterie occidentali, fosse qualche perduta tradizione pagana, certo si è che Avalon venne considerato come una specie di Paradiso Terrestre. Qui, infatti, fu trasportato Re Artù, quando gli fu tolta la vita a Lyonesse; qui il pellegrino piantò nel suolo quel suo bastone, che poi doveva mettere radici e diventare un albero che fiorisce il giorno di Natale… San Giuseppe portò la coppa dov’era stato versato il vino nell’Ultima Cena e il sangue della Crucifissione a quel santuario di Avalon che oggi si chiama Glastonbury, e che divenne il cuore di un intero universo di leggende e poemi non solo per la Britannia ma per l’Europa tutta.
Dal fondo di questa tremenda e ramosa tradizione emerge la Santa Coppa (Holy Grail). La visione di essa era la speciale ricompensa di quel circolo di forti paladini che Re Arturo intratteneva alla Tavola Rotonda, simbolo di eroico cameratismo che più tardi fu imitato dalla cavalleria medioevale… A torto o a ragione, questo ciclo di tradizioni fece apparire la Britannia per secoli come un paese con un passato cavalleresco; la Britannia divenne uno specchio di cavalleria universale”. Si tratta di quello che viene appunto chiamato il “ciclo bretone” dei poemi, o meglio, dei romanzi di cavalleria.
Se la cultura celtica fosse all’origine del ciclo bretone, avremmo dunque un forte punto di riferimento. Ma anche qui, appena giunti a questo incerto approdo, subito le cose si complicano. Ecco infatti come si esprime sul ciclo bretone l’Enciclopedia Treccani: “Nome complessivo della letteratura medievale narrativa, di colorito magico e favoloso, in versi e in prosa, fiorita intorno alle imprese dei cavalieri di re Artù, ai casi di Tristano e Isotta e di altri personaggi. Il nome è dovuto alla supposizione che tutta la materia dei racconti sia derivata dal fondo novellistico tradizionale dei popoli celtici della Piccola e della Grande Bretagna, da cui avrebbero attinto Chrétien de Troyes, Béroul, Thomas, Marie de France. Ma la fallacia di questa supposizione è messa in rilievo sia dalle analogie che la materia stessa ha con la novellistica e con le leggende del mondo orientale e del mondo classico, sia dal fatto che le gesta di re Artù non sono largamente diffuse prima della Historia regum Britanniae (1118- 1135) di Goffredo di Monmouth, il quale lavorò su fonti per lo più di derivazione greco-latina. In linea generale, di questa materia cavalleresca e amorosa l’elemento bretone è limitato a qualche motivo di provenienza celtica, alla finzione della quale i poeti si servono accennando a non specificate fonti bretoni ch’essi avrebbero utilizzate, alla collocazione degli avvenimenti in terre della Piccola e della Grande Bretagna”.
Una specie di doccia fredda, come si vede. Già: ma perché i creatori del ciclo avrebbero collocato la scena delle loro fantasie nelle due Bretagne senza nessun fondamento? La Treccani, opera di concezione idealistica, si rifà ai documenti classici della storiografia e diffida della tradizione e della cultura popolare. Non così noi, confortati anche dal già citato Chesterton.
La storia
Il nome dei Celti compare sull’orizzonte della storiografia con Erodoto, storico greco di Alicarnasso del V secolo avanti Cristo; ma in geografia era già stato fatto un secolo prima da Ecateo di Mileto, logografo greco della Ionia e instancabile viaggiatore, il quale compose quattro libri di Genealogie contenenti una esposizione degli avvenimenti mitici e storici noti al suo tempo disposti cronologicamente per generazioni. Una curiosità: Ecateo di Mileto è il primo autore che adopera il vocabolo greco historia, “indagine”, dal quale deriverà “storia”, che usiamo ancor oggi. Ora, riguardo ai Celti, la mitologia greca aveva elaborato questa “leggenda delle origini”: erano i discendenti , di Celto, figlio di Ercole (un Celto maschio), e di Celto o Celta, figlia di Britanno, o anche di Sterope, figlia di Atlante. È difficile capire se tali indicazioni ci dicono qualcosa, e soprattutto che cosa: un po’ come quando, nella Bibbia, ci ritroviamo di fronte ai tre famosi fratelli Sem, Cam e Jafet, i figli di Noè scampati al diluvio nell’Arca e dunque nuovi progenitori comuni di tutto il genere umano.
Sul genere di credito da attribuire a queste antiche leggende esistono teorie diverse. Noi preferiamo pensare che esse abbiano comunque un certo fondamento nella memoria comune del genere umano, appunto, e in questo ci conforta ancora una volta il vecchio G. K. Chesterton, il quale scriveva: “A proposito di questi grotteschi della fantasia popolare c’è ancora un’ultima cosa da ricordare; e dev’essere ricordata specialmente da coloro che si soffermano solo sui documenti, e non vogliono sentir parlare di tradizioni. Per quanto fallaci possano essere i risultati di chi faccia la storia prestando credito a tutte le storie delle vecchie comari, essi non saranno mai così gravi come gli errori che derivano dal volersi fidare solo delle testimonianze scritte, specialmente quando queste difettano… Un fatto che se ne sta tutto solo, senza la chiave del pensiero (ad esso) contemporaneo, può indurre in errore assai più di qualsiasi leggenda. Conoscere quale parola che uno scriba arcaico vergò senza essere sicuri di ciò che essa significasse, può condurre ai risultati più assurdi”.
Per avvicinarsi alla comprensione totale, dunque, occorre saper interpretare e mescolare con accorta intuizione storia e leggenda. E che ci dice la storia, dei Celti? Secondo Ferdinand Lot, “l’immensa maggioranza degli abitanti della Gallia apparteneva a una sola razza, la razza celtica”. Furono i Celti a introdurre in Francia la civiltà del ferro, originaria dell’Asia Minore. La conquista celtica del territorio durò almeno per otto generazioni, e si concluse all’incirca nell’anno 400 avanti Cristo. Da allora fino alla conquista romana, avvenuta nel primo secolo avanti Cristo, la Gallia, ossia la terra dei Celti, fu un grande paese agricolo e militare, straordinariamente prolifico e teso alla conquista di nuovi territori verso sud. Ecco allora queste popolazioni dilagare appena possibile dalla Pianura Padana e andare a occupare i territori ubertosi prima tenuti dagli Umbri e dagli Etruschi. Nel 390 avanti Cristo gruppi di Celti si spinsero fin sotto le mura di Roma, ponendo l’assedio alla “città eterna”. Ma il territorio effettivamente controllato dai Celti nell’odierna Italia settentrionale era delimitato dagli Appennini, lungo una linea corrispondente a quella che venne definita più tardi “linea gotica”. Furono appunto i Celti a creare colonie stabili destinate a diventare alcuni dei maggiori e più duraturi insediamenti urbani della Padania, come Milano, Bergamo, Brescia, Como, Modena, Bologna; il nome latino di Bologna, Bononia, deriva appunto da quello della tribù dei celti fondatori della città: i Galli Boi.
Ma la marcia dei popoli celti verso il sud non si arrestò qui. Attraverso la valle del Danubio, altri Celti si spinsero fino in Grecia dove, nel 278 avanti Cristo, si abbandonarono al saccheggio e alla depredazione dei celebri santuari di Delfi. Bande di Celti s’inoltrarono poi fino all’Ellesponto, alle rive asiatiche del Bosforo e addirittura all’Egitto. In Asia Minore essi giunsero alla fondazione di un vero Stato che durò fino in piena epoca classica, denominato Galazia, donde il nome greco di Gàlati dato a tali avanguardie. Questo a sud. A nord, gl’intraprendenti Celti avevano attraversato la Manica guadagnando così le isole britanniche; a ovest erano arrivati fino all’Oceano Atlantico; a est — come abbiamo già visto — attraverso Macedonia e Ungheria fino all’Asia Minore. Il massimo apogeo dell’espansione fu raggiunto nel IV secolo avanti Cristo: in quell’epoca, conclude il giovane antropologo Furio Jesi (purtroppo precocemente scomparso), le lingue celtiche furono parlate in un territorio estesissimo. Ma con altrettanta rapidità — si direbbe — esse scomparvero quasi del tutto sotto i colpi della conquista romana e germanica, tanto che attualmente ne rimangono soltanto alcuni residui in gruppi isolati e compatti nell’estremo lembo occidentale d’Europa, ossia nell’occidente della Scozia e dell’Irlanda, nell’isola di Man, nella regione del Galles e nella penisola bretone di Francia, dove però il loro residuo insediamento è dovuto, secondo Jesi, a un reflusso dalle isole britanniche seguito all’invasione germanica. Così, delle antiche lingue celtiche, oggi non ne rimangono che due varianti fondamentali: il gaelico, parlato in Irlanda e Scozia, e il cimrico, parlato nella Bretagna e nel Galles.
Ma perché, dopo un’espansione così veloce e vastissima, i Celti scomparvero quasi senza lasciare traccia, almeno in confronto alle tracce ben più vistose lasciate da altre culture come la greca, la latina, la teutonica? Il fenomeno può forse trovare la sua spiegazione appunto nei caratteri peculiari della cultura gaelica, che non era come le altre: per molti versi si trattava evidentemente di una cultura speciale, separata, “diversa”, disomogenea con le altre con le quali venne a contatto ed entrò in conflitto. Mentre infatti, per le culture greca e latina, e persino per certe culture italiche come quella etrusca, si può parlare di una certa continuità, per i Celti si deve parlare di rottura; per loro non si ripeterà l’antico aforisma “Graecia capta ferum victorem coepit”, la Grecia conquistata (con le armi) conquistò a sua volta il duro conquistatore (con la forza del pensiero e delle arti). No, i Celti erano e rimasero, per il mondo grecoromano, dei “barbari”, degli stranieri, dei diversi, appunto. E i romani, secondo Gerhard Herrn, li temevano molto più di Cartagine, per la quale avevano pure un odio mortale. Già fin da allora questi popoli guerrieri e scorridori costituivano per la “nostra” cultura una specie di oggetto misterioso.
Questi esseri misteriosi, questi “diversi” ch’erano dunque i Celti, come vivevano? “Erano apparentemente governati”, ci sovviene ancora Chesterton, “da una cosa terribile, da un clero pagano. Pietre ora informi, ma disposte in forme simboliche, testimoniano dell’ordine e della fatica di coloro che le maneggiarono.
Il loro culto era probabilmente naturalistico, e se da una parte questo fondamento religioso può tenersi in conto per le qualità elementari che hanno impregnato le arti dell’isola, dall’altro la collisione tra esso fondamento e l’accomodante Impero Romano suggerisce la presenza di qualche cosa che generalmente germoglia dal culto della Natura, voglio dire l’innaturale”. A questa separatezza celtica il buon Chesterton fa risalire, non senza qualche fondamento, anche certi aspetti del carattere britannico moderno: “Gli isolani ben si confanno alle loro isole. Differenti come le nazioni entro le quali sono ora divisi, Scozzesi, Inglesi, Irlandesi e Gallesi hanno nel contempo qualcosa di differente dalla monotona docilità dei Germanici continentali e dal bon sens français, che può essere secondo i casi tagliente o trito.
V’è qualcosa di comune a tutti i Britanni… Qualche cosa molto prossima alla precarietà, qualche cosa che s’addice a uomini che camminano lungo rupi scoscese, sul ciglio delle cose. Il senso dell’avventura, un solitario gusto della libertà, un humour senza spirito, rendono perplessi i loro critici ed essi stessi. Le loro anime sono corrose come le loro scogliere… C’è qualcosa di doppio nei loro pensieri, come di un’anima che si rifletta in molte acque. Di tutti i popoli sono i meno attaccati a ciò ch’è puramente classico… Essi sono costantemente coloni ed emigranti; e si son fatti il nome di trovarsi a casa loro in tutti i paesi. Pure sono come in esilio nel loro stesso, lacerati dall’amore del focolare e da quello di qualche cos’altro. Di ciò il mare può essere la spiegazione ovvero può esserne solo il simbolo. Se ne trova traccia anche in una rima d’anonimo che tutte le bambinaie conoscono, e che è il più bel verso di tutta la letteratura inglese, e nel contempo il tacito ritornello di tutti i poemi inglesi: ‘Sulle colline e molto lontano…’”. Così Chesterton, sui suoi amati “diversi” Britanni. Ma coloni furono anche i Greci, emigranti anche gl’italiani… Dunque, forse cominciamo a carpire il segreto dei Celti: più che una razza, più che un popolo ed una cultura, essi rappresentano qualcosa come un aspetto dello spirito umano, un modo di essere, quello che appunto gl’inglesi chiamano un “mood”…
“Giganti biondi”
Ma insomma, che aspetto avevano, questi famosi Celti o Galli che dir si voglia? Come ce li descrivono gli antichi? Ecco le parole di Diodoro Siculo, storico greco-siceliota del primo secolo avanti Cristo, la cui opera narra gli avvenimenti dalle origini fino all’inizio della guerra di Cesare nelle Gallie: “Il loro aspetto era terribile… Sono alti di statura, con una muscolatura guizzante sotto la pelle chiara. Di capelli sono biondi: e non solo di natura perché se li schiariscono anche artificialmente lavandoli in acqua di gesso, pettinandoli poi all’indietro sulla fronte e verso l’alto. Sembrano quindi già per questo dèmoni silvani, poiché questo tipo di lavaggio rende la chioma spessa e irta come una criniera. Taluni si radono la barba, altri (in ispecie i maggiorenti) ostentano con guance rase baffi che coprono l’intera bocca… Vestono in maniera stupefacente, con camicie ricamate di tinte sgargianti, e portano inoltre dei calzoni, che chiamano brache, e mantelli fissati alla spalla da un fermaglio… Questo mantelli sono a strisce o a quadri, e i singoli quadri stanno fitti gli uni accanto agli altri e presentano colori diversi”. Diodoro Siculo, storico del primo secolo avanti Cristo, ci sta descrivendo dei mantelli di tartan scozzese dove, come è noto, i disegni riproducono i colori del clan.
“I Celti, dunque”, scrive Bruno Romani, “avevano grande cura della loro persona, e vestivano con una certa ricercatezza. Portavano i capelli lunghi a metà, rialzati sulla fronte, talvolta tinti o scoloriti con acqua di calce. I Francesi d’oggi usano rappresentare i Galli, nel teatro, nel cinema o nei disegni, con enormi baffi spioventi. Ma le monete recanti l’effigie di Vercingetorige ce lo mostrano senza barba e senza baffi. Invece, la statua del Gallo morente, custodita in Campidoglio, ha dei baffetti corti e sottili”: baffetti alla Menjou, potremmo dire, per chi se ne ricorda. E come vivevano? Erano suddivisi in tribù, ciascuna col proprio nome, che spesso è rimasto alla terra da essi occupata: “La ripartizione del suolo tra le diverse tribù di Galli”, scrive ancora il Romani, “ha rappresentato un dato importante nello sviluppo dell’ordinamento amministrativo della Francia. I Romani ne seguirono il tracciato per fissare le loro circoscrizioni, la Chiesa per la creazione delle diocesi, ed infine lo Stato francese per il catasto. I nomi di molte di quelle tribù galliche sopravvivono nella geografia della Francia odierna: Arras era la sede della tribù degli Atrebates, Amiens degli Ambiani, Reims dei Rems, Parigi dei Parisii, Chartres dei Carantes, Bourges dei Biturigi… I Celti avevano edificato le loro città e le loro piazzeforti nelle località più diverse. Lutezia o Parigi, capitale dei Parisii, era stata costruita su un’isola; Avaricum, capitale dei Biturigi, nel centro di una pianura protetta da paludi; Bibracte, capitale degli Edui, su un promontorio situato all’estremità meridionale del Morvan… Le vie di comunicazione erano numerose e varie. Le strade erano ben tenute ed esistevano molti ponti… Le case erano di legno ed avevano la forma rotonda che in tutti i paesi distingue e indica le costruzioni primitive. Al centro della casa esisteva un foro per l’uscita del fumo… Dormivano su tappeti o su pellicce. Ai muri erano appese le teste dei vinti illustri. Altre teste di vinti, imbalsamate con olio di cedro, venivano custodite in apposite cassa- panche”.
Insomma, si trattava di un popolo bellicoso, che non guardava tanto per il sottile. “Una prova ulteriore che i Celti erano un parto mostruoso del caos (agli occhi grecoromani, naturalmente) — scrive ancora Gerhard Herrn — è data dal più terribile dei loro usi bellici: quello di decapitare i nemici vinti e di inchiodarne i teschi sopra la porta delle loro capanne”. Ma, a proposito di usi bellici, ecco qualcosa che ci interessa più da vicino: “brandiscono le armi”, racconta Diodoro Siculo, “in modo da intimorire l’avversario. Se però questi raccoglie la sfida, i compagni del provocatore erompono in canti selvaggi che celebrano le gesta dei loro padri e le loro proprie capacità, mentre l’avversario viene dileggiato e offeso con l’intento di fargli perdere le staffe prima della battaglia”. Non pare la descrizione del comportamento di Cassius Clay, alias Mohammed Alì, sul ring e durante gli allenamenti prima di un combattimento importante? Scherzi a parte, dove saranno finiti quei canti, quegli “strani e dissonanti suoni di corno”, quelle urla di “voci profonde e roche”, quel battito ritmico delle spade contro gli scudi di cui ci parlano gli storici dell’età classica? Purtroppo essi non possedevano strumenti di registrazione del suono, e noi dobbiamo oggi accontentarci di sommarie descrizioni, e lavorare un po’ d’immaginazione…
Anche Tito Livio, lo storico latino del primo secolo nativo di Padova, ci descrive i Celti come giganti biondi che “riempivano tutto intorno di canti selvaggi e di grida spaventevoli”; e tuttavia, essi ci appaiono anche abili diplomatici, capaci di un comportamento ligio all’onore e pieno di dignità, pur non esitando a reclamare apertamente il diritto del più forte. “L’educazione dei figli dei nobili”, riepiloga ancora il Romani, “oltre a quella dei giovani destinati al sacerdozio, veniva affidata ai druidi. Ai giovani nobili era però proibito l’uso della scrittura: essi dovevano ascoltare e imparare a memoria. L’insegnamento comprendeva le seguenti materie: il diritto, le tradizioni epiche, la liturgia, la storia degli dei, l’arte di interpretare i presagi”. Ecco che forse ci siamo incontrati con un elemento fondamentale, strutturale, della cultura celtica, che potremmo ritenere responsabile della rapida scomparsa della lingua e delle altre tracce di cui siamo in cerca: essi non avevano compreso il valore fondamentale della scrittura, e preferivano affidarsi alla tradizione orale. E stato forse questo, dopotutto, l’errore fatale dei Celti? E chi erano i druidi che abbiamo appena sentito nominare?
Una religione terrena
Ce lo dice Furio Jesi, dopo aver puntualizzato anche che “le popolazioni celtiche avevano un’organizzazione per gruppi di famiglie (clans) collegati in tribù; in imprese di particolare importanza si eleggeva un capo supremo ch’era assistito da un Consiglio formato dagli altri capi. La famiglia presso i Celti storici era patriarcale; però Cesare attesta che in Gran Bretagna e Caledonia (Scozia) vigeva la poliandria e il potere passava talora a donne…” Quanto ai druidi, essi erano il corpo sacerdotale “che partecipava ai sacrifici, garantiva l’educazione religiosa dei giovani, esercitava la divinazione e manteneva vivi i rapporti tra le varie tribù”. Nel quadro della società celtica tracciato da Cesare, i druides (sacerdoti) e gli equites, aristocrazia guerriera, erano le due classi privilegiate cui si trovava sottoposta la plebs. Questo tipico schema di società indo-europea è confermato anche dalle fonti antiche (Posidonio, Strabone Pomponio Mela, ecc.), così che i Druidi appaiono occupare nel mondo celtico il posto dei Brahmani nell’india arcaica. Secondo l’antica etimologia tradizionale, il nome dei druidi deriverebbe da drus, quercia, nel senso di ‘conoscitori della quercia’ (albero sacro) o di ‘coloro che hanno il sapere della quercia’”. Secondo altre ipotesi invece la radice etimologica del nome sarebbe druvid, “il molto veggente”, “colui che sa molto”. La loro funzione principale sembra comunque essere stata la divinazione…
A questo punto è necessario accennare alla loro religione, argomento affascinante anche se, come al solito, tuttora assai oscuro e misterioso. Per i Celti “la sfera degli dei non poteva dirsi propriamente ultraterrena, ma piuttosto superumana (è sempre Jesi che parla). L’Aldilà non era negato (e molti miti celtici narrano viaggi in un altro mondo), ma non era la sede d’elezione degli dei, i quali piuttosto risiedevano nei luoghi oscuri, misteriosi o inaccessibili della terra; nel sottosuolo, nelle colline, nei boschi, nella caverne, nelle profondità delle acque”…
La religione dei Celti è un mistero nel mistero, attorno al quale si sono appassionate le ricerche degli studiosi, anche perché sembrava uno dei bandoli della matassa da sviluppare per penetrarne il segreto.
E poi le credenze, i riti, i miti religiosi costituiscono sempre un argomento affascinante e strettamente legato con l’anima di un popolo. Se quindi vogliamo accostarci in qualche modo all’anima popolare, non possiamo trascurare questo fondamentale argomento. Se vogliamo conoscere qualche risposta sui Celti, dobbiamo interrogare gli dei proprio come, per penetrare con sicurezza in un territorio inesplorato ed ignoto, i Latini consigliavano di provvedere prima a propiziarsi le divinità del luogo.
La religione ci presenta un quadro complesso e affollato di presenze, non sempre coerenti fra loro, e diverse da tribù a tribù. Ma — scrive Furio Jesi — “al di là di tali divergenze affiorano i tratti di una fondamentale unità, fra cui spiccano tre elementi particolarmente arcaici, comuni a tutto il mondo celtico: la caccia ai crani, l’alleanza del sangue e il potlach (sistema di scambi di oggetti e prestazioni ritualmente organizzato). La decapitazione del nemico e la conservazione rituale del suo cranio appartenevano alle pratiche dell’iniziazione, almeno in senso lato, poiché erano prescritte agli adolescenti come condizione al matrimonio e in generale alle attività degli adulti; impadronendosi di un cranio, l’adolescente si assicurava il soccorso delle forze di un defunto. L’alleanza del sangue (documentata soprattutto nell’antica Irlanda) trasferiva le relazioni giuridiche nell’ambito di sacri rapporti di parentela; e il potlach, compiuto con grande frequenza e con l’apparato cerimoniale di una festa religiosa, determinando lo scambio di manufatti e di prestazioni d’opera consentiva affermazioni di prestigio da parte dei maggiori donatori, consacrava i vincoli sociali e favoriva al tempo stesso operazioni para-commerciali di indubbia utilità economica”.
Ma che cos’era esattamente questo potlach? La parola viene qui applicata da Jesi ai Celti, ma nel repertorio antropologico essa appartiene piuttosto alle antiche culture americane. Più precisamente, si tratta di una parola della lingua chinook, potlach o potlac, che significa “dono”; la lingua chinook fu parlata fino al XVIII secolo sulle coste americane del Pacifico, nel territorio degli attuali Stati dell’Oregon e di Washington, e apparteneva alla popolazione dei Penuti, nomadi suddivisi in varie tribù. Dunque, con tale termine vengono designate dagli studiosi di antropologia le grandi feste collettive delle tribù indigene del Nord-Ovest dell’America settentrionale. Questi raduni, occasionati da avvenimenti di particolare importanza nella vita della tribù, duravano diversi giorni ed erano arricchiti da danze, banchetti, recite cantate e riti particolari tra i quali la tipica usanza (da cui il nome) di scambiarsi dei doni che poi venivano deliberamente distrutti per manifestare la ricchezza del clan che aveva indetto la festa. Infatti costituiva un punto d’onore, per ciascun clan, superare in generosità e ricchezza i potlach organizzati via via dai vari clan concorrenti, affermando in tal modo la propria supremazia economico-sociale. Si trattava, insomma, di una festa dello spreco e dell’ostentazione, una sorta di consumismo avanti lettera, dove amore e odio — sia per le cose che per le persone — si presentavano, come sempre accade, uniti inestricabilmente.
Seguiamo ancora l’itinerario proposto da Furio Jesi per la nostra avventurosa esplorazione di quello che si potrebbe chiamare il pantheon celtico: “In base alle testimonianze più sicure e a ciò che si può ricavare sia dai testi degli storici antichi, sia dai poemi epici e lirici attingenti al substrato celtico, è lecito affermare che i numerosi dei venerati dai Celti erano per lo più figure sovrane, ciascuna riconosciuta come tale dalle singole tribù. La società divina veniva concepita sul modello di quella dell’aristocrazia celtica e conduceva la sua esistenza immortale autonoma dalla vita degli uomini. Le grandi feste agrarie segnavano il punto di contatto fra il mondo degli dei e quello degli uomini, confermando periodicamente la sovranità divina sulle cose terrene e la devozione umana verso la presenza del sacro.
P. Lambrechts ha tracciato una carta geografica dei culti tributati dalle singole tribù ai vari tipi di figure divine, e da essa appare chiaro il carattere locale di forme e attributi: divinità a tre teste nel territorio dei Remi, dee madri presso i Treviri, dio cavaliere tra le valli del Rodano e della Saône, dio seduto con le gambe piegate e il capo coronato di corna di cervo nella Gallia centrale, dio col serpente nella Francia orientale, ecc. Caratteristiche di alcune divinità particolarmente importanti sono la trinità (dei a tre teste, a tre volti, o gruppi di tre dee) e gli attributi animali (dio Cernunnos, cornuto; dio col serpente; dio con orecchio di cervo, col cane; dea Artio, orsa; dea Damona, forse vacca; dea Rhiannon, dea Epona, giumente). Le figure delle singole divinità posseggono caratteri particolarmente complessi e non unilaterali (appunto in rapporto con la loro sovranità, esercitata su molteplici aspetti della vita e della natura): Esus è insieme un dio guerriero e, a Treviri e a Parigi, protettore dei battellieri; Lug è guaritore, artigiano, guerriero; Sucellus, dio raffigurato spesso col martello, è dio della morte, della forza vitale che sopravvìve alla morte, dell’ebbrezza festiva e del lavoro quotidiano. Teutates (in cui alcuni studiosi del passato riconobbero, erroneamente, la divinità suprema di tutti i Celti) è venerato sotto molteplici altri nomi: Albiorix (re del mondo), Manopos (grande adolescente), Tutiotix (re della tribù), Caturix (re del combattimento), Lucatios (lo scintillante). I grandi santuari celtici di Entremont, Caisses de Mouriès, Roquepertuse, Mandeurex, Saint-Maur-en-Chausée, Trougouzel e delle isole britanniche, erano molto spesso centri innanzi tutto funerari, sepolture di eroi e di capostipiti delle tribù. Una forte presenza di richiami alla morte, all’Aldilà, al destino ultimo dell’uomo, conferisce ai monumenti ivi ritrovati un aspetto per noi piuttosto lugubre e inquietante, nel quale va riconosciuta la prova del costante gravare della morte sull’esistenza dell’aristocrazia celtica”.
I Druidi
“Ogni società è tormentata, in modo visibile o invisibile, da ciò che pensa della morte”: è un pensiero di André Malraux, tratto dai suoi Antimémoires, che Gerhard Herrn prepone al capitolo del suo libro destinato ad approfondire la visione religiosa del mondo celtico. Vediamo in breve di che si tratta. “Speculazioni su ciò che i Celti potevano sapere su dio, natura, morte e vita dopo la morte” scrive Herm “seguitano a occupare, sui piani intellettuali più diversi, scettici, sognatori e ricercatori della verità. Gerald B. Miller, ad esempio, membro dichiarato dell’antichissima Lega britannica dei maghi, sospira in un suo scritto: ‘Se solo sapessimo veramente che cosa pensavano e insegnavano i druidi!’, avanzando così l’ipotesi che detenessero la chiave di una realtà sovrasensibile. Ernst Jünger discusse nel 1945 con un bretone che aveva combattuto dalla parte dei tedeschi, se non fosse meglio affidare la scienza della fissione nucleare a un ordine, i cui membri si segnalassero come i druidi nella scienza non profana. Allora, la forza fisica soggiacerebbe a quella spirituale’”. “Tutto ciò” — conclude Herm — “lascia vagamente intravvedere in che mito potente siano confluite le poche informazioni in nostro possesso sui sacerdoti dei Celti”. Il desiderio insoddisfatto ha provocato storie di taglio spesso fantasmagorico, dove anche il vischio ha una parte, per il fatto che uno scrittore romano l’ha collegato con i druidi. Il sei di ogni mese — scrive l’appassionato raccoglitore di fatti Plinio il Vecchio nella sua enciclopedia di storia naturale — i Celti celebravano una gran festa. I druidi biancovestiti montavano per l’occasione sulle querce per recidere con un falcetto d’oro il vischio che deponevano su candidi panni. Dopodiché sacrificavano due tori bianchi. Che cosa significhi questo solenne racconto, è stato dibattuto sotto tutti i possibili aspetti. La spiegazione più plausibile, e anche più prossima, è che il vischio servisse a usi medicinali. Spremuto di fresco, esso dà infatti un succo contenente colina, acetilcolina e viscotossina, tre sostanze che, iniettate in vena, abbassano temporaneamente la pressione del sangue.
Le foglie di vischio, inoltre, ridotte in poltiglia, leniscono i dolori dell’ulcera maligna. Quindi, secondo Plinio, i druidi sono né più né meno che dei guaritori naturali molto abili. Oltre al vischio, dice, conoscevano altre due piante medicinali, da lui chiamate samolus e selago: l’una da cogliere con la mano sinistra, l’altra con la destra infilata nella manica sinistra di una veste bianca. Plinio parla inoltre dell’anguinum, un uovo magico della grossezza di una piccola mela, che conteneva veleno di serpe e procurava buoni servigi al suo possessore dinanzi al tribunale o in altre circostanze pubbliche. Nessuno è riuscito finora a identificare samolus e selago, né è andata meglio con l’anguinum. Così, una volta ancora si avanza l’ipotesi che i druidi — o almeno alcuni di loro, i ‘vates’ di cui parla Strabone — fossero effettivamente dei ‘filosofi naturali’ profondi conoscitori quanto meno dei veleni e delle medicine vegetali, ma certo anche di quelle animali. Bryan McMahon, studioso di storia e folclore, ama provare le sue teorie predilette — è sempre Gerhard Herm che racconta questo gustoso aneddoto — e parlarne poi con la routine del declamatore consapevole dell’effetto finale. “Tutte le volte che incontro un indiano’ — mi disse — ‘lo tiro da parte e gli accenno il primo verso di un antico canto popolare del mio paese (cioè l’Irlanda). Quindi lo invito a proseguire la melodia a suo piacere. E, believe it or not, quasi ogni volta lui la canta fino alla fine come se conoscesse la canzone. Non è stupefacente?’ Si tirò indietro, così che il fuoco morente del camino nella sala del ‘Listowel Arms Hotel’ (contea di Kerry, Irlanda) ne modellò i tratti nella semioscurità di un cupo giorno di pioggia. Poi proseguì: ’Per me, questa è la prova che indiani e irlandesi hanno un passato comune, e che, come ho detto in un mio scritto, noi celti proveniamo dal misterioso Oriente’”.
Una lingua «Centum»
Parlavamo di sacerdoti vestiti di bianco: li vediamo innamorati, i Celti, quasi ipnotizzati dal colore bianco. Che sia, a suo modo, anche questo un segno? Non possiamo dimenticare che Joseph Péladan, detto Joséphin, un curioso scrittore nato a Lione nel 1859 e morto nel 1918 a Neuilly-sur-Seine, influenzato da un padre cattolico legittimista e da un fratello cultore di scienze occulte, influenzato dalle opere di Wagner e specialmente dal suo Parsifal, si proclamò un puro cavaliere dello spirito, e assunti atteggiamenti da gran sacerdote, si pose a capo di un ordine cui diede il settecentesco nome dei Rosacroce. Ebbene, questo strano personaggio, questo “sar” Péladan, volle vedere elementi celtici nella poesia cortese del Medioevo francese, e nella teologia dei Catari, ossia dei “puri”, dei bianchi sacerdoti del dualismo manicheistico emigrati in Europa e perseguitati a morte dalla Chiesa di Roma come eretici nell’unica terra che li aveva accolti fraternamente e dove avevano potuto mettere salde ancorché segrete radici: la Francia del sud, e soprattutto il territorio di Albi, donde il loro nome di Albigesi, un nome che rievoca senza troppa difficoltà il segno del bianco…
Poiché abbiamo avviato l’inevitabile discorso dei “segni”, vediamo di addentrarci rapidamente nel loro più caratteristico territorio, in quell’oceano misterioso o intricata foresta piena di sorprese, di strani collegamenti e di continue meraviglie che è la linguistica. Ecco che cosa essa ci dice dei Celti: le parlate delle popolazioni celtiche formano il gruppo più occidentale della famiglia delle lingue indoeuropee che paiono discendere tutte da una comune origine, o almeno sono caratterizzate da un sistema fonetico e morfologico strettamente correlato, come pure da una stessa struttura sintattica e da un vocabolario comune. Le lingue celtiche, in particolare, rientrano nel cosiddetto gruppo centum delle parlate indoeuropee che è lo stesso gruppo al quale appartengono l’italico, il germanico, il greco, il veneto, l’illirico e l’antico ittito. Si chiama così perché ha conservato le consonanti palatali come occlusive, a differenza del gruppo satem (albanese, armeno, balto-slavo, indoiraniano) nel quale esse sono diventate delle sibilanti. Esempio pratico: in gallese “cento” si dice cant, come in latino si diceva centum o kentum, da cui l’italiano cento, mentre in avestico abbiamo satam, da cui il nome, appunto, del secondo gruppo. Ed ecco una serie di mirabolanti collegamenti, che gli studiosi chiamano congruenze, come li espone Raffaele De Marinis nell’apposita voce della nuova enciclopedia Garzanti: “Le lingue celtiche, pur differenziate, presentano tratti che testimoniano un’origine comune, e hanno analogie con le lingue dell’Italia antica; il gaelico particolarmente col latino, e il britannico con l’osco-umbro.
Fra le congruenze che in una fase preistorica collegano il celtico (specialmente l’irlandese) e il latino, particolare importanza ha l’uso del suffisso –simo– con cui entrambi formano il superlativo, dei suffissi –tion– e –tut– con cui formano gli astratti, della desinenza –i di genitivo singolare dei temi in –o-.
Fra le caratteristiche delle lingue celtiche sono da notare, nel vocalismo, il passaggio di è indoeuropea a i (e così al latino rex corrispondono l’irlandese ri, il gallese rhi e il gallico –rix, che si trova nel secondo elemento di nomi come Vercingetorix”. Ed ecco una curiosità: il celtico e l’indoiraniano sono le sole due lingue indoeuropee che hanno conservato una distinzione tra il genere maschile e femminile nei numerali tre e quattro: così nell’antico irlandese abbiamo, per “tre” il maschile, tri (come pure in gallese e in bretone), mentre per il femminile troviamo téoir, in mediogallese e in bretone teir; e per quattro, il maschine cethair, gallese pedwar, bretone pevar, accanto al femminile rispettivamente cethéoir, pedeir, peder. Ebbene, nelle lingue padane è invece rimasto declinabile il due: infatti in piemontese si dice doe fije (due ragazze) ma dui fieuj (due ragazzi), e la stessa distinzione si fa in milanese tra du fioeu e dò tosann. Molte sono le somiglianze di vocabolario tra celtico e germanico, ad esempio tra il gotico runa (segreto) e il vecchio irlandese run; o tra il vecchio inglese wudu (legno), il gallico vidu e il vecchio irlandese fid. Un’ultima osservazione, preziosa, di Julius Pokorny, già professore di cultura celtica all’università di Berlino e ora professore della stessa materia in quella di Zurigo: “I numerosi termini religiosi comuni al celtico e all’indoiranico possono essere spiegati come sopravvivenze del passato comune indoeuropeo”. Osservazioni come questa certo colpiscono la fantasia e fanno comprendere perché il professor Pokorny concluda la sua trattazione con una citazione di John Rhys che dice: “Il mondo celtico domina una delle principali porte d’ingresso al mondo preariano, dal quale si può dire che noi europei moderni abbiamo ereditato molto più di quanto immaginiamo”.
Un modo di essere
Ma i popoli non si esprimono soltanto con le parole: essi posseggono altre forme di comunicazione e di linguaggio, prima fra tutte l’espressione artistica plastica e figurativa. E possiamo a questo proposito ricordare che l’arte celtica, ossia l’apporto dei Celti in questo campo, costituisce, secondo Furio Jesi, “a fianco di quello degli Iberi e degli Sciti, il triplice filone non-classico dell’arte dell’Europa antica, e dall’inizio dell’età del ferro si spinge almeno fino al mille dopo Cristo, penetrando profondamente la genesi dell’arte medioevale. Alla fine del XIX secolo la cosiddetta ‘rinascita celtica’, coronando le ricerche di un repertorio simbolico non classico per i propri presupposti esoterici, (che divergevano da quelli del romanticismo tedesco e quindi non potevano conciliarsi con immagini classiche), riconobbe nell’arte celtica una corrente sotterranea sopravvissuta per vie misteriose e iniziatiche fino al gotico, al rococò e all’art nouveau. Indipendentemente dalla validità storica di tale ipotesi, resta il fatto che l’arte dei Celti abbia esercitato la parte estremamente importante di contraltare del patrimonio classico nella moderna coscienza del rapporto con l’antico. Tale fatto” conclude Jesi “acquista singolare significato quando si considera la moderna rivalutazione dell’arte (un tempo detta ‘degenerata’) delle monete celtiche, che indubbiamente aprono la via alla liberazione del figurativismo delle convenzioni classiche e a grafismi di deflagrazione dell’immagine e di adesione alle libere forme organiche propri dell’art nouveau. ”
Ed ecco allora che siamo tornati a una prospettiva complessa per cui i Celti, prima ancora e più ancora che un determinato gruppo di popoli, più profondamente che non questo, sarebbero quasi una dimensione nascosta del nostro spirito, la dimensione della stranezza e della rivolta, il lato ribollente ed oscuro, anticlassico, anticonformistico. E certo una prospettiva che a qualcuno potrà apparire azzardata e precaria, fondata più su esili reminiscenze e arbitrari truismi che non su solide ragioni scientifiche. Eppure, ecco ancora un esempio di come quella che potremmo chiamare la “china celtica” induce a scivolare con la fantasia ed a istituire rapporti misteriosamente estesi e profondi tra la nostra cultura e i suoi sostrati più o meno celtici, appunto. Ancora una volta è il bel libro di Gerhard Herm che ci serve da guida, analizzando il culto dei cacciatori di teste e comparandolo con quelli analoghi presenti sulla scena della storia:
“I cacciatori di teste che avevano fatto un culto della caccia a questo trofeo, potevano avere almeno due altri motivi per tale barbara condotta: la convinzione che la collezione di crani nemici accrescesse per magia la forza del decapitatore; e la credenza che un avversario così mutilato non potesse ritornare dall’aldilà, vuoi in forma di spirito, vuoi in forma umana. Ora, se consideriamo gli Sciti effettivamente come polo orientale della loro civiltà, s’impone meglio per i Celti la seconda tesi. Anche i cavalieri delle steppe, infatti, decapitavano i caduti, e inoltre i loro sciamani sembrano aver considerato la morte in modo analogo ai druidi. Ciò permette di passare dai sacerdoti-maghi ai portatori di falcetto e spiega probabilmente molte loro pratiche. Gli sciamani — scrive Mirtea Eliade, uno dei più importanti storici europei delle religioni — giungevano alla loro professione per vocazione interiore o per nomina: in ogni caso, presupponevano un ammaestramento ottenuto per mezzo di sogni, estasi, stati ipnotici e visioni. Essi sperimentavano persino la loro propria morte, come pure il ritorno alla vita. Voci interiori spingevano il neofita a ricercare la solitudine della foresta. Qui egli aveva visioni tali da portarlo sull’orlo della pazzia. In seguito, egli saliva su un palo o su un albero, sino al cielo, e solo di là ritornava sulla terra. Quando finalmente lasciava la foresta, aveva le vesti lacere, il viso sanguinante e i capelli arruffati. Ciò che aveva sperimentato, dicono gli esperti, non era altro che la dissoluzione dell’essere profano nel caso psichico della pazzia, e la nascita di una nuova personalità. Tali esperienze sembrano tuttavia riflettere un modello-base di ogni religiosità, in quanto mirano soprattutto al superamento della morte. Chi, come gli sciamani, l’aveva dominata ed era penetrato, per cosi dire, da esploratore nel mondo dell’aldilà per poi tornare, doveva per forza essere abbastanza superiore al suo prossimo da poterlo in seguito guidare e anche sacrificare. Se anche l’autorità dei druidi si nutrisse a queste fonti, non sappiamo, anche se Mircea Eliade lo giudica senz’altro possibile. E poiché persino Stuart Piggott — un conoscitore dei Celti che in generale si appoggia soltanto ai fatti dimostrati — accetta l’opinione del rumeno, possiamo quanto meno ritenerla un’approssimazione della verità. Entrambi gli studiosi si appoggiano ad alcuni evidenti paralleli tra mondo celtico e scitico. Essi considerano che gli stregoni orientali e i dotti occidentali giudicavano la morte quasi allo stesso modo, e tengono anche presente la voce di una teorìa della rinascita, fondata su esperienze mistiche, nella Gallia antica. Che qui fossero ancora di moda pratiche di tipo magico, ne sono assolutamente certi. Una di tali pratiche si manifesta forse nel costume spesso testimoniato di andare nudi in battaglia. La ragione poteva essere semplicemente che i guerrieri avevano caldo, ma non bisogna dimenticare che il calore fisico viene considerato in molte religioni simbolo di potenza sacra e di irrefrenabile libertà spirituale. I giovani guerrieri delle tribù eredi dei popoli del kurgàn usavano caricarsi, per così dire, in lotte d’iniziazione rituale prima di venir mandati al loro primo combattimento. Diventavano, così, ardenti come il mitico eroe antico irlandese Cù Chulainn, del quale la leggenda vuole che dovessero ficcarlo in tre tinozze d’acqua gelata prima che fosse abbastanza raffreddato da potersi rivestire. Una notizia già citata delle storie liviane sembra connettersi direttamente a quanto appena detto. “I passi di danza coi quali i celti prigionieri presero le armi prima di cominciare i duelli organizzati da Annibale, potevano sembrare al romano espressione di bellicosità, mentre appunto facevano parte di un rituale con cui i duellanti s’immergevano in bollenti estasi prima di cominciare”.
Vediamo ora con occhio diverso, forse, la cultura celtica: non ci sentiamo più tanto “antichi romani” come avrebbero voluto farci sentire i nostri libri di scuola, e siamo meglio disposti a riconoscere nei “barbari” Celti o Galli che dir si voglia qualcosa della nostra natura più intima e gelosa, più inspiegabile e ribelle. La nostra emozione (e, se possiamo dirlo, il nostro affetto) non faranno che aumentare quando avremo appreso qualche altra notizia come questa: riguarda le Alpi, il cuore stesso dell’Europa che noi amiamo. Ebbene, la parola “alpe”, che designa i pascoli estivi e le malghe, è di origine celtica. Dal tempo dei Celti alpini, inoltre, deve datare il costume di festeggiare il primo giorno di maggio: il giorno in cui si cominciava a condurre le mandrie all’alpeggio.
E per giustificare questo “affetto” o “effetto celtico” — che fece scrivere a Costantino Nigra con decisione, nella sua introduzione alla raccolta dei canti popolari del Piemonte, che “nell’Italia superiore sotto il latino v’è un substrato celtico” — rievochiamo infine, sulla scorta della narrazione liviana, la bella leggenda che documenta come furono i Celti a fondare la principale delle nostre città padane: al tempo del re Tarquinio Prisco, dice lo storiografo romano, il popolo-guida dei Celti erano i Biturigi, cui apparteneva un terzo della Gallia. Il paese era così ricco di prodotti e d’uomini che il suo re Ambigato pensò di potere a stento governare tanta moltitudine. Decise quindi di liberare il suo regno del fastidioso sovrappiù, anche perché era già molto anziano. Fece pertanto sapere che avrebbe mandato i suoi nipoti Belloveso e Sigoveso, giovani animosi e intraprendenti, nelle terre che gli dei avessero indicato come patria tramite gli auspici. Gli uccelli volarono, i sacerdoti interpretarono. Sigoveso si vide assegnare la Selva Ercinia (i Mittelgebirge tedeschi), mentre a Belloveso gli dei offrirono il cammino molto più favorevole dell’Italia, Questi allora raccolse tutti gli uomini in soprannumero presso i loro popoli: Biturigi, Alverni, Sènoni, Edui, Ambarri, Carnuti, Aulerci; e, partito con un grande esercito di fanti e cavalieri, arrivò nel territorio dei Tricastini, sul basso corso del Rodano. Ora aveva in faccia le Alpi (a ovest); più esattamente, l’Alta Provenza. E poiché tali montagne parvero ai Celti troppo inospitali essi si legarono dapprima coi greci originari di Focea, in procinto di fondare la loro Massalia (la futura Marsiglia) e in conflitto con una tribù indigena. I Celti li aiutarono; quindi, precorrendo Annibale, traversarono la catena centrale europea e diedero, come poi appunto Annibale, la loro prima battaglia al Ticino. Dove, però, non si trovarono di fronte i romani bensì gli etruschi. Vinta la battaglia, si stanziarono sul posto, un verde territorio immerso in dolci acque, e vi fondarono l’attuale Milano, Ed è appunto nel nome di Milano, la capitale padana, che possiamo fare il punto di questa nostra cavalcata o scorribanda nell’antica storia dei Celti.
La druvida ëd Malciaussìa

“Plinio li ricorda (i druidi) come guaritori e maghi, e nel secolo III a.C. si parla anche di donne dedite alla divinazione: le druidesse, delle quali un singolare reperto è oggi conosciuto con l’appellativo di “Druida di Malciaussìa”, scoperto nel 1969 dallo studioso Mario Catalano in una cappella eretta forse nel seicento tra un gruppo di baite appunto in località Malciaussìa a 2000 msm della valle di Viù. L’altorilievo rappresenta una figura femminile, con lunga veste ed una stola cadente sul petto, il capo coperto da una mitria di antica foggia sacerdotale. La scultura fu eseguita su una lastra di pietra oliare ed oggi risulta molto manomessa da scritte, incisioni, scalfitture tra le quali alcune risultano classificanti e determinanti : su una piega della veste ed in caratteri greci è inciso il nome celtico druas; sul copricapo ed in parte sulla fronte è la scritta “S. Bernardo”, sicuramente incisa in età vicina per stravolgerne il significato religioso, cosi come nel Medio Evo si trasformavano in croci le stilizzazioni antropomorfe relative ai culti primitivi; con grandi ed intenzionali scalpellature si tentò di distruggere l’atto sacrificale che la scultura rappresenta: lo strumento sacrificale è stato scalfito nella parte sommitale, ma si rivela ancora molto chiaramente nella sua forma allargantesi ad ascia. In basso, lo stesso attrezzo si apre in due bandelloni con le estremità foggiate ad anello, quello in basso serrato attorno alla gamba destra di un bambino e l’altro superiore — più danneggiato — intorno al collo dello stesso corpicino che s’intravvede raffigurato in atteggiamento di abbandono passivo”.
L’interessante resoconto è di Luciano Gibelli, attentissimo studioso di storia e cultura piemontese: gli appassionati ricorderanno Dnans ch’a fàssa neuit, un’ampia raccolta fotografica della cultura materiale rurale con testo bilingue piemontese-italiano. La descrizione della druvida è tratta dal suo ultimo libro, Le leugne rèis (e chèich pass andarera për cheuje ’d leugne rèis), le antche radici, quelle testimonianze di vita, cioè, che migliaia di anni fa gli uomini incisero nelle rocce del monte Bego.
L’interesse per la statua, comunque, non è soltanto di natura archeologica in quanto attorno ad essa aleggia un’atmosfera di mistero che diremmo del tutto “celtica”. Ciò che Gibelli non riporta espressamente nel suo libro è che il simulacro non si trova al suo posto, nella cappella, ma è custodito gelosamente dagli abitanti della zona, che lo tengono ben nascosto.
Viene subito in mente la trama di un bel racconto alla Machen: lo studioso arriva al villaggio, dove è accolto da aperta diffidenza, e non riesce a farsi mostrare il misterioso reperto; dopo avere superato l’aperta ostilità della gente, le mezze frasi e gli sguardi sfuggenti, scopre infine che un rito pagano, tramandato nei secoli, sopravvìve all’ombra dei picchi montani…
Chiacchiere, naturalmente. Ma è affascinante pensare che qualcuno onori un cosiddetto San Bernardo che è, in realtà, un’antica sacerdotessa in alto di infilzare un bambino; e in modo alquanto evidente, oltre tutto.
Roberto C. Sonaglia