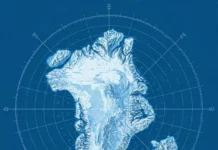L’autobus rallenta e l’avviso sonoro ricorda che siamo prossimi alla fermata: “Prochaine arrêt – Bois des frères”. La voce femminile, addolcita dall’eleganza dell’accento francese, suona come un mantra, mentre realizzo che ho già percorso quattro volte questa tratta senza riuscire a scorgere nemmeno l’ombra di quello che sto cercando, sempre che ancora esista.
Scendo comunque, nella speranza che questa lunga strada in salita, con i quartieri residenziali a sinistra e una boscaglia sulla destra, mi porti da qualche parte, anzi da “quella” parte, mentre il mite sole di maggio illumina i tetti di Ginevra.
Virgilio è un uomo anziano, dall’aspetto giovanile, gli occhi vivaci e il portamento distinto. È di origine portoghese, la sua famiglia è emigrata in Svizzera negli anni sessanta. Virgilio, l’unica persona che incontro in questa interminabile strada in salita, è con la moglie, ginevrina doc, passeggiano mano nella mano; non posso che rivolgermi a lui, ma sono certa che non sia casuale.
“So dove si trova, certo che ancora esiste, ti accompagno io con la mia macchina”, mi risponde con simpatia questo sconosciuto e gentilissimo signore.
Siamo a Vernier, ad appena cinque chilometri dal centro di Ginevra, e Le Lignon, in assoluto il più lungo complesso residenziale svizzero, abbraccia l’orizzonte. È una Cité, un quartiere suburbano, costituito da un unico edificio a forma di “Y”, lungo un chilometro e alto più di novanta metri, un serpente di acciaio e vetro, colorato, con vista sul Rodano, concepito per dare alloggio a 10.000 persone. I numeri sono importanti: due torri, una di 26 e l’altra di 30 metri, 88 entrate, 2780 unità abitative di quattro, cinque e sei locali, una chiesa cattolica e una protestante, una scuola, un centro medico, una palestra, un centro commerciale dotato di tutti i servizi, un ufficio postale, un parco giochi, una piazza punto d’incontro di giovani e non; in sintesi, una città nella città.

Ancora qualche numero: ci vivono 6800 persone di ben 100 nazionalità diverse, diversi ceti sociali e disponibilità finanziarie. Indipendentemente dalle possibilità economiche, ogni appartamento è simile all’altro nel concetto della vivibilità e della luminosità, compresa la magnifica vista sulla campagna svizzera.
Le Lignon rappresenta quella che è stata la risposta al problema della carenza abitativa verificatasi negli anni sessanta, e la necessità di sviluppare l’urbanistica con soluzioni architettoniche che fossero adeguate anche al continuo flusso migratorio verso la Svizzera.
“Je pense que l’honte devait être lavée”, penso che fosse necessario lavare la vergogna, sentenzia Virgilio osservando l’edificio. Non è l’unico a crederlo.
Le Lignon è una creatura dell’architetto ginevrino Georges Addor (1920-1982) realizzata tra il 1965 e il 1971: “il benessere delle persone è la prima preoccupazione di un architetto quando progetta una costruzione di tale dimensione”, era solito affermare nelle sue apparizioni pubbliche; d’altra parte si diceva di lui che fosse uno di sinistra dichiarato pur guidando una Maserati… una cosa non escludeva l’altra. Le contraddizioni emergono nella vita di tutti i giorni, quella vita così ben progettata da Addor: dal punto di vista tecnico l’insieme è perfetto, ma questo “insieme” è il regno dell’individualismo di massa; per alcuni è una fonte di ispirazione, per altri una forma gentile di segregazione.
Les baraques
Di certo rimane che il periodo storico in cui il Lignon ha preso forma è stato profondamente segnato da una immigrazione di massa: italiani, spagnoli, portoghesi arrivavano in Svizzera con contratti stagionali – les ouvriers saisonniers – e alloggiavano in affitto in piccole baracche di legno, con quattro letti per una camera di 10 mq, i bagni e la cucina in comune, la boscaglia per giardino e l’umidità del Rodano che si insinuava nei polmoni e nelle ossa. Per ragioni di sicurezza non erano permesse né radio né televisori, il dopo lavoro nelle baracche era nostalgia di casa e speranza in un futuro più dignitoso.
Erano gli anni in cui la Svizzera viveva il boom economico del dopoguerra, per molti il luogo più vicino dove andare a guadagnare qualche lira e poter pagare la casa in costruzione nel paese d’origine. L’emigrazione funzionava con il passaparola, il cugino, il fratello, l’amico metteva una buona parola e si partiva con in valigia un contratto di lavoro, per lo più stagionale, altrimenti non si passava il confine.
E il passaggio al confine era durissimo per chi non era mai uscito nemmeno dal proprio comune di nascita. Il controllo documenti non era che l’inizio di una ispezione in piena regola, con denudazione e lavaggio disinfettante, una procedura probabilmente utile ma assolutamente umiliante. Ci si faceva l’abitudine e si rafforzava il carattere; come dice un bel detto francese che mi piace molto, “à la guerre comme à la guerre”, non c’è scelta.
Si finiva poi per abitare nelle baracche di legno, umide e insalubri, dividendo gli alloggi con perfetti estranei che parlavano altre lingue ma avevano gli stessi problemi, sopravvivere e mantenere la famiglia. Il governo svizzero forniva lavoro, ma dimenticava di fornire welfare. Un dettaglio non da poco. L’emigrante lavorava e stava zitto, la paura di non essere riconfermati per la stagione successiva alimentava il silenzio. Rimaneva la condivisione, dalla finestra della baracca si cercava di comunicare con gli occupanti della baracca di fronte, qualche sorriso, una sigaretta offerta, la gentilezza non si nega a nessuno, nonostante la miseria le buone maniere non vanno perdute. E intanto la scarsa nutrizione e la forte umidità lavoravano come tarli nel fisico e nella dignità. Chi si ammalò di asma non guarì più, e si portò dietro il peso del marchio della baraque de bois gentilmente fornita dallo Stato svizzero. À la guerre comme à la guerre!
Il permesso di lavoro stagionale non prevedeva la presenza della famiglia, una normativa molto severa rimasta in vigore fino al 1996. I bambini, considerati clandestini, erano costretti a rimanere nascosti nelle baracche, con il terrore di essere scoperti e finire negli orfanotrofi creati appositamente ai confini italo-svizzeri. Drammi impossibili da dimenticare, che hanno alimentato molto spesso quel senso di rivalsa sociale nelle seconde generazioni. Energia e rabbia indirizzata verso la realizzazione di se stessi, un bell’esempio di capolavoro antropologico.

Virgilio parcheggia l’auto su un piccolo spiazzo, prima del bosco. Lo seguo lungo un sentiero in terra battuta e all’improvviso le vedo: dieci piccole file di costruzioni in legno, allineate, con minuscole finestre, qualche panno steso ad asciugare, una porta aperta che lascia intravedere un letto, un tavolino e una sedia. Alloggi umili quanto lo erano negli anni sessanta, nati temporanei e divenuti pezzi d’epoca, rimasti intatti da allora. L’ultimo batiment è posto di traverso, si capisce che ha una funzione diversa: è il luogo di aggregazione, la cucina e i servizi igienici, che ancora sono condivisi oggi come allora.
Virgilio mi spiega che ci vivono un centinaio di persone, esclusivamente di sesso maschile (così ha deciso il Comune), con permesso di soggiorno temporaneo. Ma non solo: c’è chi a metà della propria vita si ritrova disoccupato e non ha i soldi in tasca per un alloggio migliore, c’è chi ha problemi con l’alcol e la moglie lo ha lasciato, e c’è pure chi preferisce vivere senza fronzoli in una stanza senza il superfluo per poter un giorno andarsene per sempre e non avere nulla da portare con sé; scelte, più o meno forzate, per una vita ai margini, silenziosa, invisibile ai più. Tutto è cambiato senza che nulla sia veramente cambiato. Il concetto dell’emarginazione, non solo da immigrazione, non ha fatto un passo avanti, mentre il resto del mondo parla di intelligenza artificiale, metaverso e viaggi su Marte. Mon Dieu!
 Adesso capisco cosa intende Virgilio quando parla della honte, la vergogna: Le Lignon e les baraques, due facce della stessa medaglia, a cinque chilometri dall’elegantissimo e costosissimo centro di Ginevra, dai palazzi delle Nazioni Unite, dalla scintillante sede della unhcr, le ong di partito che salvano i nuovi migranti in fuga, dal cern e il suo bosone di Higgs.
Adesso capisco cosa intende Virgilio quando parla della honte, la vergogna: Le Lignon e les baraques, due facce della stessa medaglia, a cinque chilometri dall’elegantissimo e costosissimo centro di Ginevra, dai palazzi delle Nazioni Unite, dalla scintillante sede della unhcr, le ong di partito che salvano i nuovi migranti in fuga, dal cern e il suo bosone di Higgs.
Virgilio mi raccomanda di non avvicinarmi troppo alle baracche, la curiosità da queste parti non è la benvenuta; non si tratta di privacy, concetto un po’ radical chic, ma di una buona dose di allergia ai ficcanaso che si sentono bene osservando chi sta peggio di loro. Non è il mio caso.
Un ivoriano è seduto sotto un albero, controlla chi arriva, altri, sempre di colore, stanno cucinando qualcosa alla griglia.
C’è diffidenza nei loro sguardi; uno di loro mi si avvicina chiedendomi chi sono e cosa voglio: “Sei una giornalista? Cosa vuoi da noi? ”.
“Anche, ma non solo”, rispondo io.
Quando capiscono il motivo della mia visita mi sorridono e mi invitano a fare quattro chiacchiere. In fondo ho anch’io il diritto di sedermi insieme a loro nei vecchi batiment di Bois des Frères. Perché io lì, a Bois des Frères, nelle piccole baracche di legno lungo il Rodano, ci sono nata.